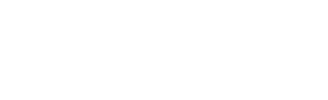La nuova disciplina della giurisdizione in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che è entrata in vigore a partire dal 1 luglio 1998, trae la sua origine dal decreto legislativo del 23.10.1993 n. 29 ma ha trovato una compiuta regolamentazione solo con la legge di delega del 15.03.1997 n. 59 (legge Bassanini), con il d. lgs. 31.03.1998 n. 80 e con la legge 205/2000.
Dalla tradizionale tutela giurisdizionale del pubblico dipendente legata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo[1], si è passati, con le disposizioni di cui all’art. 68 del d. lgs. n. 29/1993 ad una devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di gran parte delle controversie relative al rapporto di lavoro di pubblico impiego.
Questo spostamento di giurisdizione è stato la conseguenza immediata e diretta di quel processo, avviato con il d. lgs. n. 29/1993, di unificazione del sistema delle fonti di disciplina del rapporto di lavoro pubblico con quello privato che viene assoggettato alla disciplina del codice civile, alle leggi che regolano i rapporti di lavoro subordinato nell’impresa (art. 2, d. lgs. n. 29/1993) e allo Statuto dei lavoratori “che si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”. (art. 55, d. lgs n. 29/1993)
L’orginaria formulazione dell’articolo 68 del d. lgs. n. 29/1993, peraltro mai entrata in vigore per effetto delle successive modifiche, prevedeva la devoluzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze pubbliche, con esclusione delle materie di cui i numeri da 1 a 7 dell’art. 2 comma 1, lett. c) della legge delega 421/1992.[2] L’articolo effettuava altresì una inopportuna esemplificazione delle controversie che erano “in ogni caso” devolute al giudice ordinario.
L’attuale formulazione dell’art. 68, così come modificato dall’art. 29 del d. lgs. n. 80/1998, è espressione della volontà del legislatore di attribuire al giudice ordinario una competenza in materia di rapporto di lavoro il più possibile unitaria e completa nonchè di determinare un riparto tra le giurisdizioni sulla base di una competenza per materia.
L’art. 68 prevede, al primo comma, “la devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 dello stesso decreto[3], incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti”.
L’articolo precisa poi nello stesso comma, che la devoluzione avviene ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti, giacchè quest’ultimi, se sono rilevanti ai fini della decisione e illegittimi, vanno disapplicati e che comunque “l’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”.
Al secondo comma l’articolo 68 chiarisce che il giudice ordinario può e deve adottare nei riguardi delle pubbliche amministrazioni convenute tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati e che le sue sentenze che riconoscono il diritto all’assunzione ovvero accertano che l’assunzione è avvenuta illegittimamente, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
Al giudice ordinario sono altresì devolute le controversie in materia di comportamento antisindacale e quelle relative alle procedure di contrattazione collettiva e in ogni caso il ricorso per cassazione è ammesso pure per violazione dei contratti o accordi collettivi (art. 68 comma terzo così come novellato dal d. lgs. n. 80/1998).
In ragione della scelta del legislatore di attribuire al giudice ordinario una competenza pressochè generale in relazione alle controversie in materia di pubblico impiego, nasce spontaneo domandarsi se lo stesso non abbia voluto istituire una nuova giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, comprensiva di una competenza dello stesso giudice anche in materia di interessi legittimi.
Anche a voler superare il problema della astratta possibilità di attribuire al G.O. una giurisdizione in materia di interessi legittimi, visto l’attuale criterio costituzionale del riparto della giurisdizione per posizioni giuridiche soggettive, in realtà una simile ipotesi deve essere esclusa in virtù delle previsioni normative.
In primo luogo infatti, si deve osservare che l’attribuzione di una competenza pressochè generale al G.O. è stata ottenuta attraverso la quasi totale eliminazione delle posizioni soggettive di interesse legittimo avvenuta mediante la riconduzione alla disciplina privatistica di una molteplicità di atti della pubblica amministrazione tra i quali rientrano anche quelli attinenti alla c.d. micro-organizzazione dell’amministrazione, cioè quelli inerenti alla concreta e minuta organizzazione degli uffici, ai sensi dell’art. 2 co. 2 e art. 3 co.2 e art.4 co.2 del d. lgs. n. 29/1993 come novellato dal d. lgs. 80/1998.
In secondo luogo, la fondatezza di una simile ipotesi va esclusa dalla previsione, contenuta nell’articolo 68 primo comma, della possibilità di impugnazione dell’atto amministrativo di fronte al giudice amministrativo che conferma l’esistenza in materia di residui interessi legittimi tutelabili avanti al giudice amministrativo (secondo l’ordinario riparto di giurisdizione ex art. 103 Costituzione) e dalla permanenza del divieto, in capo al giudice ordinario, di annullare gli atti amministrativi, ancorchè illegittimi.
Il giudice amministrativo, secondo quanto disposto dall’art. 68 novellato dal d. lgs. n. 80/1998, invece, mantiene la propria competenza in quelle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e una giurisdizione esclusiva nelle controversie relative ai rapporti di lavoro non privatizzati ex. art. 2 co. 4 e 5 del d. lgs. n. 29/1993 (che riguardano il pubblico impiego di particolari categorie di di personale, quali magistrati, avvocati dello stato, personale della carriera prefettizia, militari, forze di polizia).
Nello stesso tempo il legislatore, con gli art. 33-35 del d. lgs. n. 80/1998, ha attribuito al giudice amministrativo una vera e propria giurisdizione esclusiva in materia: 1) di pubblici servizi, con particolare riguardo a quelle relative al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 481/1995, alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori e forniture; 2) in materia di urbanistica ed edilizia.
Sono escluse invece dalla sua competenza, i casi già rientranti nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche e quelle controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell’indennità di espropriazione o comunque connessa all’adozione di provvedimenti ablatori.
L’art. 35 del d. lgs. n.80/98 dispone che il giudice amministrativo nelle materie attribuite alla propria giurisdizione esclusiva “dispone anche attraverso il risarcimento in forma specifica del risarcimento del danno” e che “ il giudice può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica o il gestore di pubblici servizi possono determinare una somma di denaro da versare alla controparte, evidentemente a titolo risarcitorio.”
Alcune problematiche nella individuazione della giurisdizione competente:
L’attuale formulazione dell’art. 68 ha creato alcune difficoltà interpretative in relazione alla individuazione della giurisdizione competente: in particolare con riferimento agli incarichi dirigenziali, alle procedure concorsuali e infine alla applicazione del criterio del riparto temporale tra le giurisdizioni.
In relazione alle controversie relative al conferimento delle cariche dirigenziali, nonostante il legislatore all’art. 68 co 1 del d. lgs. n. 29/1993 nella sua originaria formulazione le abbia espressamente devolute al G.O., si è determinato un contrasto tra le pronunce di alcuni giudici ordinari e quelle di alcuni TAR: i primi rivendicavano infatti la propria competenza sul presupposto che l’atto di nomina dovesse essere considerato come atto negoziale inerente al rapporto di lavoro, i secondi invece rivendicavano la propria giurisdizione a conoscere di dette controversie in forza della qualificazione dell’atto di nomina quale atto di esercizio di una potestà pubblica (TAR Lombardia Milano sez. II, 21.02.1999 n. 60 e TAR Puglia, Lecce, sez. I, 6.02.1999 n. 271).
In senso contrario, invece, sulla spettanza della giurisdizione al giudice ordinario in merito alle controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali (TAR Campania, Napoli, sez IV, 7.02.2000 n. 352 e TAR Lombardia, Milano, ord. N. 2747 del 22.08.2000).
Tale contrasto è stato recentemente risolto a seguito di alcune pronunce della Corte Costituzionale: già con sentenza n. 275/2001, la Corte aveva affermato la piena legittimità dell’articolo 68 del d. lgs n. 29/1993 nella parte in cui attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative agli incarichi dirigenziali.
Ancor più recentemente, tale principio è stato di nuovo riaffermato dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza 11/2002.
Con tale ordinanza la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituzionale della nuova disciplina ( e in particolare, della norma di delega contenuta nell’art. 11, comma 4, lett. a della legge n. 59/1997 e degli art.15, 19, 21, 23 e 24 del d. lgs. n. 29/1993, nel testo modificato), estensiva del regime di diritto privato già esistente per i dirigenti anche ai dirigenti generali, per presunto contrasto con gli articoli 3, 97 e 98 della Costituzione. Ciò in quanto la nuova disciplina avrebbe comportato per i dirigenti generali uno stato di debolezza e precarietà che avrebbe impedito loro di operare secondo i canoni dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
La Corte, invece, nella suddetta ordinanza ha ritenuto in sostanza:
- che l’estensione della normativa privatistica anche ai dirigenti generali rientri nell’ambito della discrezionalità del legislatore in quanto trattasi di posizioni che, a differenza di quanto accade per es. ai magistrati, non necessitano di essere stabiliti necessariamente con legge al fine di garantire loro uno stato giuridico particolare;
- che, nonostante la privatizzazione, la posizione dei dirigenti generali rimane differenziata anche all’interno del ruolo unico e che la disciplina di significativi momenti del rapporto riserva ai dirigenti di prima fascia uno speciale e più favorevole trattamento;
- che la disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale (in particolare il conferimento degli incarichi dirigenziali e la loro revoca) nonché la procedimentalizzazione dell’accertamento di tale responsabilità è connotata da specifiche garanzie mirate a presidiare il rapporto di pubblico impiego dei dirigenti generali;
- che i dirigenti generali sono quindi posti in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto del principio di imparzialità e buon andamento.
Assolutamente incerto appare tutt’ora l’orientamento in materia di conferimento di incarichi di dirigente sanitario di secondo livello, principalmente in ordine alle incertezze sulla qualificazione “concorsuale” o meno, della particolare procedura selettiva che precede la determinazione del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria.
Alle pronunzie che hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in materia (TAR Molise, 25.11.1999 n.496; TAR Lombardia, sez. Brescia, ord. 25.02.2000 n.. 115 e 7.04.2000 n.209 e sent. 8.07.2000 n.618; TAR Sicilia, Palermo, sez. I 3.10.2000 n.1778 e 5.03.2001 n.351) si sono contrapposte altre pronunzie che hanno invece, affermato la competenza del giudice amministrativo (TAR Valle d’Aosta 23.06.2000 n.113; TAR Abruzzo, Pescara 26.02.2000 n.132 e L’Aquila 3.08.2000 n.605).
Le modalità e i tempi di attribuzione delle varie materie affidate alla competenza del giudice ordinario sono state disciplinate dall’art. 45 del d.l. 1998 n. 80 comma 17, il quale prevede che la competenza del giudice ordinario sia riservata per quelle questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
Le questioni invece attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000
Nell’individuare il criterio del riparto tra le giurisdizioni il legislatore prescinde da quanto previsto dall’art. 5 del c.p.c e determina la giurisdizione in virtù delle questioni attinenti al … “periodo del rapporto di lavoro”….. che è divenuto il vero elemento di discrimine della giurisdizione.
Le difficoltà interpretative che una simile espressione, generica e atecnica, ha creato sono dovute al fatto che essa può essere riferibile ad una molteplicità di momenti: come al dato storico di avveramento del fatto materiale e delle circostanze in relazione alle quali sia sorta la controversia, oppure all’arco temporale in cui l’atto produce i suoi effetti, oppure al momento di insorgenza del diritto in contestazione.
Ancora non è stata fatta definitiva chiarezza sul punto, ad una prima pronunzia della giurisprudenza che poneva l’accento sul dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze- così come posti a base della pretesa avanzata- in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (Cass. 808/1999) ne sono seguite altre che pongono l’accento sulla data di adozione dell’atto ritenuto lesivo, provvedimentale o negoziale, dell’amministrazione. (Cass. S.S.UU 505/2000; Cass. S.S.UU 553/2000; Cass. 41/2000, 1214/2000).
Recentemente il Consiglio di Stato (sez. IV, n.1176/2001) ha recepito detta soluzione, ritenendo che se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto provvedimentale o negoziale, debba farsi riferimento all’epoca della sua emanazione.
La Cassazione ha ritenuto che, nel caso in cui il lavoratore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore e in parte successivo alla data del 30.06.1998, la competenza giurisdizionale dovrà essere del giudice amministrativo per il periodo pregresso al 30 giugno 1998, e del giudice ordinario per il periodo successivo a tale data. (Cass. SS.UU.1323/2000).
Il riparto delle giurisdizioni nel caso di richiesta di risarcimento del pubblico dipendente per lesioni alla propria integrità fisica.
Ai fini del riparto della giurisdizione, nel caso di controversie che hanno per oggetto la richiesta di risarcimento del dipendente della pubblica amministrazione per i danni cagionati alla propria integrità fisica, è interessante ricordare il principio di diritto affermato ormai da una recente giurisprudenza, tutta a sezione unite. (Cass.24/12/2000 n. 42; Cass. 14/12/1999 n. 900; Cass. 25/5/1999).
Secondo la giurisprudenza il criterio da utilizzare ai fini della individuazione della giurisdizione deve far riferimento al petitum sostanziale: se la pretesa risarcitoria del pubblico dipendente si fonda sulla invocazione di una responsabilità contrattuale sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; se invece la pretesa risarcitoria si fonda su di una responsabilità extracontrattuale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
In quest’ultima ipotesi, infatti, la pretesa del dipendente non trae il suo titolo dal rapporto di pubblico impiego bensì dalla violazione di un diritto assoluto, il diritto alla vita e all’integrità fisica, rispetto al quale la tutela deriva dal principio del neminem leadere, principio che preesiste al pubblico impiego e che dà luogo ad una tutela del tutto autonoma.
La giurisprudenza ha altresì precisato che debbano essere qualificate come pretese extracontrattuali non soltanto quelle domande che espressamente invocano una responsabilità aquiliana, ma anche quelle in cui non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale, come quando per esempio la richiesta risarcitoria del danneggiato faccia riferimento in generale alla lesione dell’integrità fisica, senza però dedurre espressamente la violazione dell’inosservanza di una specifica obbligazione contrattuale.
Peraltro, a parere della giurisprudenza, la prospettazione della sola inosservanza dell’art. 2087 c.c., non è di per sé sufficiente a giustificare la qualificazione dell’azione come contrattuale, potendo la stessa essere stata effettuata in funzione esclusiva della dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di lesioni colpose e della configurabilità dell’illecito come extracontrattuale.
Alla luce dei predetti insegnamenti, potrebbe pertanto essere disattesa la competenza del giudice amministrativo qualora, nell’atto del giudizio il ricorrente addebiti la responsabilità dell’ente in base ad una asserita violazione contrattuale che richiami genericamente e astrattamente l’inosservanza delle cautele idonee a prevenire incidenti senza però dedurre espressamente la violazione di una specifica obbligazione contrattuale.
Considerata la complessità dei temi trattati lo studio è a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.
GGM & PARTNERS
[1] La genesi storica di tale assetto risale al testo Unico Giolittiano 1908 n.639 che per la prima volta dettò una disciplina organica dello stato giuridico dei dipendenti dello stato e al d. leg. 1923/2840 che aggiunse la materia del pubblico impiego a quelle nelle quali il consiglio di Stato e le giunte provinciali amministrative conoscevano anche di questioni relative ai diritti soggettivi.
[2] L’articolo indica le seguenti materie: le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative; gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali e l’organizzazione degli uffici; i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; i ruoli e le dotazioni organiche, la garanzia di libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca, la disciplina della responsabilità e della incompatibilità tra l’impiego pubblico ed altre attività.
[3] Art. 1 comma 2 d .lgs. n. 29/1993 “ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province , i comuni, le comunità montane loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.