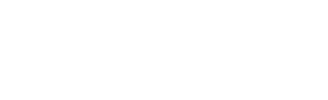[Novembre 2003] - La somministrazione di lavoro nel decreto legislativo n. 276/2003
Il decreto legislativo attuativo dei primi cinque articoli della legge 30/2003 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore venerdì 24 ottobre. Da tale data si è aperta, come illustreremo nella parte conclusiva della presente circolare, una complessa fase di transizione (art. 86) che porterà, solo gradualmente e con il concorso di molteplici attori (Governo, Regioni e parti sociali), al nuovo assetto tratteggiato dalla riforma del mercato del lavoro.
In questa sede verranno proposti alcuni brevi spunti relativi all’istituto della somministrazione di lavoro. Il capo I del titolo III dell’articolato governativo è, infatti, interamente dedicato a tale ipotesi contrattuale, la quale, a seguito dell’abrogazione della legge 1369/60 che ne sanciva l’illiceità penale, da reato diventa un contratto tipico, ovvero un contratto con requisiti specificamente disciplinati dalla legge.
Tale disciplina porta a compimento un processo evolutivo iniziato con la legge 196/1997 sul lavoro interinale, la quale, seppur in termini di mera deroga al regime vincolistico della legge 1369/1960 che vietava ogni forma di somministrazione di lavoro altrui, introduceva nel nostro ordinamento l’istituto del lavoro interinale quale unica ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 276/03, che, da un lato abroga gli articoli da 1 a 11 della legge 196/1997 ma, dall’altro, ne conferma principi e modelli giuridici, si realizza una figura unitaria di esternalizzazione di lavoro, la cui disciplina è interamente contenuta nel provvedimento in esame.
Da ciò derivano le numerose analogie con la fattispecie del lavoro interinale, istituto del quale ci siamo occupati in una precedente circolare pubblicata il mese di maggio, alla quale si rinvia.
Con la nuova disciplina viene, dunque, superato lo sfavore dell’ordinamento verso ogni forma di esternalizzazione del lavoro e decentramento produttivo. Tuttavia, non si tratta di una totale liberalizzazione della materia, dal momento che, come vedremo, la somministrazione di lavoro sarà possibile solo in presenza di determinate condizioni oggettive, definite dalla legge stessa o dalla contrattazione collettiva, e solo se resa da agenzie per il lavoro a ciò appositamente autorizzate.
L’articolo 20 delinea del nuovo istituto, disponendo, in primo luogo, che tale contratto “può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi degli articolo 4 e 5”. (comma 1)
Il primo requisito richiesto è, dunque, l’autorizzazione in capo ai soggetti che svolgono attività di somministrazione prevista ai dall’art. 4 del presente decreto. Tali soggetti consisteranno in agenzie di lavoro e potranno essere abilitate a svolgere non soltanto attività di somministrazione di lavoro a termine e a tempo indeterminato, ma anche attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale, nonché di supporto nella ricollocazione di lavoratori usciti dal circuito produttivo.
Tali soggetti dovranno, però, ricevere una autorizzazione dal Ministero del Lavoro ed essere regolarmente iscritti in un apposito albo che sarà istituito presso il Ministero stesso. Tale albo sarà diviso in 5 sezioni, ciascuna corrispondente a una delle diverse attività sopra riportate, con requisiti giuridici e finanziari differenziati, elencati in dettaglio dall’articolo 5. Inoltre, le Agenzie dovranno essere accreditate presso le Regioni nel cui ambito territoriale intendono operare.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 23 novembre, il Ministero dovrà predisporre alcuni dei provvedimenti necessari all’applicazione di determinati punti della riforma. È il caso, per esempio, delle modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione e delle modalità di funzionamento dell’albo per le agenzie di lavoro. È tuttavia prevista una disciplina transitoria che verrà illustrata nella parte conclusiva della circolare.
Il secondo comma dell’articolo 20 dispone che “per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.
Si verifica, dunque, come per la fattispecie contrattuale del lavoro interinale, una scissione tra titolarità giuridica del rapporto di lavoro ed effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa. I lavoratori vengono, infatti, assunti dal soggetto somministratore, ma prestano la propria attività presso l’impresa utilizzatrice, estranea al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il lavoratore stesso e l’agenzia di lavoro.
Nell’ambito di tale distinzione, infatti, il somministratore, pur essendo il reale datore di lavoro, è privo di potere gestionale nei confronti del lavoratore. I poteri di direzione e controllo dell’attività lavorativa subordinata sono, durante la durata del contratto, per intuibili ragioni organizzative, trasferiti dal datore di lavoro reale al soggetto che, di fatto, utilizza la prestazione lavorativa.
Questa scissione viene, invece, superata in tema di potere disciplinare, la cui titolarità giuridica, essendo riservata al somministratore, torna in capo al reale datore di lavoro. La normativa stabilisce, infatti, che “ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300” (art. 23, comma 7)).
Per quanto riguarda il profilo giuridico dell’istituto, il principale elemento di novità della disciplina in esame attiene alla legittimazione di forme di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto staff leasing), utilizzabile in specifici settori elencati dal terzo comma dell’articolo 20. Il lungo elenco comprende attività eterogenee, talvolta dai confini non facilmente determinabili, quali sevizi di consulenza e assistenza nel settore informatico; servizi di pulizia, custodia e portineria; gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi e magazzini; consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, gestione, ricerca e selezione del personale; attività di marketing, gestione di call-center; particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale.
Accanto alla tipizzazione ex lege, il decreto assegna alla contrattazione collettiva, nazionale o territoriale, il compito di individuare ulteriori ipotesi di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (art. 20, comma 3, lett. i). In questo modo, si affida alle parti sociali la possibilità di individuare nuove ipotesi di liceità dell’istituto.
Nel contratto a tempo indeterminato, in capo al somministratore, datore di lavoro reale, ricade l’obbligo di corrispondere al lavoratore un’indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità, che deve essere indicata nel contratto, è stabilita “dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali” (art. 23, comma 3).
Per quanto riguarda il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato (che era l’unica ipotesi ammessa dalla legge 196/1997), in luogo della tipizzazione legale adoperata nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato, il decreto introduce una clausola generale. L’ammissibilità della somministrazione a termine è, infatti, tassativamente subordinata all’esistenza di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ma, e la differenza rispetto alla disciplina precedente è importante, “anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore” (art. 20, comma 4).
La norma prosegue, come nel caso di contratto a tempo indeterminato, con un rinvio alla contrattazione collettiva, in base al quale “l’individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi”. Viene meno, quindi, la necessità del requisito della temporaneità e straordinarietà dell’esigenza dell’utilizzatore, che caratterizzava il lavoro interinale (a tempo detrminato).
Pur in un contesto, come abbiamo illustrato, volto a sostenere l’esternalizzazione della forza lavoro, una delle principali preoccupazioni del Legislatore è stata quella di fornire un’adeguata tutela al prestatore di lavoro “somministrato”.
In questo contesto, il punto cardine dell’intera disciplina è rappresentato dall’applicazione del principio di parità di trattamento. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno, infatti, diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, ovviamente a parità di mansioni svolte (art. 23, comma 1).
Anche per quel che riguarda la regolamentazione dei rapporti tra somministratore ed utilizzatore, sono confermati i principi e le scelte operate dalla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo, ex articoli da 1 a 11 della legge 196/1997.
In particolare, e a titolo esemplificativo, viene confermato, in primo luogo, il regime di solidarietà tra utilizzatore e somministratore in relazione ai trattamenti retributivi e ai contributi previdenziali (art. 23, comma 3). Il Legislatore pone, infatti, in capo alle due parti del contratto di somministrazione obblighi in proprio e/o solidali in ordine ai profili retributivi, e previdenziali connessi alle prestazioni rese dai lavoratori somministrati.
Più dettagliatamente, il somministratore ha sia l’obbligo di corrispondere direttamente al lavoratore il trattamento economico spettante a quest’ultimo, sia quello di provvedere in via diretta al versamento dei relativi contributi previdenziali (art. 21, comma 1, lett. h)
In caso di inadempimento del somministratore, tale obbligo ricade sull’utilizzatore, fatto comunque salvo il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente (art. 21, comma 1, lett. k). Sull’utilizzatore ricade, comunque, sia l’obbligo di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi da applicare ai lavoratori somministrati presso di sé (art. 21, comma 1, lett. j), sia quello di rimborsare a quest’ultimo tutti gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti (art. 21, comma 1, lett. i).
Le conseguenze in caso di impiego in mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto da parte dell’utilizzatore sono disciplinate dal comma 6 dell’articolo 23. Nel caso in cui il lavoratore venga adibito a mansioni superiori o comunque diverse da quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne comunicazione scritta sia al lavoratore che al somministratore. Ove tale obbligo di informazione non venga adempiuto, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori, nonché per l’eventuale risarcimento del danno spettante al lavoratore occupato in mansioni inferiori.
Il quinto comma dell’articolo 23 prevede un ulteriore obbligo in capo al somministratore: spetta a quest’ultimo, infatti, informare “i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale” nonché formarli ed addestrarli “all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti”. Il contratto di somministrazione può, però, prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore, purché ne venga data menzione nel contratto con il lavoratore.
A rigor di logica è, quindi, prevedibile un ampio uso di tale facoltà, posto che, in realtà, è l’utilizzatore a d essere compiutamente informato sui rischi connessi all’attività che verrà svolta dal lavoratore, nonché sull’uso delle attrezzature messe a disposizione dello stesso.
In continuità con il quadro normativo previgente, il prestatore di lavoro non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro (art. 22, comma 5).
Sempre nell’ambito dell’apparato di tutela previsto per il lavoratore, un diverso ordine di regole attiene alla predeterminazione legale del regolamento negoziale. Il Legislatore, nell’ottica di una rivalutazione dell’importanza del formalismo giuridico, ha optato per un sistema estremamente rigoroso e severo.
In base all’articolo 21, infatti, il contratto di somministrazione dovrà essere stipulato in forma scritta, e dovrà contenere quegli elementi indicati dal suddetto articolo a pena di nullità (comma 1, lettere dalla a alla e). Di conseguenza, nel contratto andranno necessariamente indicati: 1) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero al somministratore; 2) il numero dei lavoratori da somministrare; 3) le ipotesi previste dall’art. 20, comma 3 per l’ammissibilità della somministrazione a tempo indeterminato, ovvero le ragioni previste dal comma 4 dello stesso articolo per l’ammissibilità di quella a termine; 4) la presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate; 5) la data di inizio e la durata prevista per la prestazione lavorativa.
La mancanza di forma scritta del contratto, ovvero l’omessa indicazione nel contratto stesso di anche uno solo dei suddetti elementi, comporterà la nullità del contratto di somministrazione, con la conseguenza che i lavoratori saranno considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore fin dall’inizio del rapporto (art. 21, comma 4).
Una particolare attenzione sarà, quindi, necessaria all’atto del perfezionamento del contratto di somministrazione, in quanto l’eventuale nullità comporterebbe l’instaurarsi di diritto di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore, il quale, come vedremo, deve essere messo a conoscenza del contenuto del contratto di somministrazione.
Per quanto riguarda il profilo strettamente contenutistico, ossia le condizioni di liceità della somministrazione, il Legislatore delegato ha disciplinato tre diverse ipotesi di inammissibilità dell’istituto: somministrazione irregolare (art. 27), somministrazione illecita (art. 18, commi 1 e 2) e somministrazione fraudolenta (art.28).
La somministrazione irregolare, che secondo un ordine di gravità della risposta sanzionatoria, costituisce l’ipotesi minima di illegalità, si verifica allorquando la somministrazione avvenga “al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, lett. a), b), c), d) ed e)” (art. 27, comma 1).
Per quanto riguarda l’articolo 21, si rimanda a quanto appena illustrato. L’articolo 20, invece, nel delineare il profilo giuridico dell’istituto, ne enuncia le condizioni di liceità. Oltre all’autorizzazione ministeriale in capo al soggetto somministratore (comma 1), sono indicati sia i settori specifici nei quali è ammessa la somministrazione a tempo indeterminato (comma 3), sia le ragioni per le quali è ammessa quella a termine (comma 4), sia le ipotesi nelle quali l’istituto è vietato (comma 5).
Le ipotesi di somministrazione vietata sono quattro, due delle quali (sostituzione di lavoratori in sciopero e presso imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 626/94) costituiscono divieti assoluti. Le altre due ipotesi costituiscono, invece, divieti relativi (presso unità produttive interessate negli ultimi 6 mesi da procedure di licenziamento collettivo per i lavoratori adibiti alle mansioni alle quali si riferisce il contratto di somministrazione, e presso unità produttive in cui operi una sospensione dei rapporti di lavoro o una riduzione dell’orario lavorativo con diritto all’integrazione salariale). In questi due casi la norma prevede, infatti, un’eventuale ammissibilità, affermando che il divieto opera “salva diversa disposizione degli accordi sindacali” (art. 20, comma 5, lett. b).
Laddove, dunque, il contratto di somministrazione venga concluso “al di fuori dei limiti e delle condizioni” appena illustrati, si configurerà l’ipotesi di somministrazione irregolare.
Le conseguenze di tale illiceità sono di due diversi tipi. Un primo tipo opera su un piano sanzionatorio: in base all’articolo 18, comma 3, sia il somministratore, sia l’utilizzatore, saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro. La stessa sanzione è prevista per il solo somministratore ove questi non comunichi per iscritto al lavoratore, all’atto della stipulazione del contratto ovvero del suo invio presso l’utilizzatore, le informazioni contenute nel contratto stesso, nonché la data di inizio e la durata dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore.
Certamente più rivelante è l’altro tipo di conseguenza, che opera, invece, sul piano giuslavoristico. Ai sensi dell’articolo 27, comma 1, infatti, nei casi di somministrazione irregolare “il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione”.
È inoltre previsto che, in questo caso, per quanto riguarda i contributi e la retribuzione dovuti, i pagamenti già effettuati dal somministratore valgono a liberare l’utilizzatore fino alla concorrenza delle somme versate. Inoltre, gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto si intendono compiuti dall’utilizzatore (art. 27, comma 2).
La norma precisa che “ai fini della valutazione delle ragioni di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro (si tratta dei settori in cui è ammessa la somministrazione a tempo indeterminato e delle ragioni per le quali è ammessa quella a termine), il controllo giudiziale è limitato esclusivamente all’accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano” (art. 27, comma 3).
Si deve tuttavia osservare che tale ultima previsione può avere un senso in relazione al richiamo del comma 4 dell’art.20 (ragioni che consentono la somministrazione a termine) mentre più oscuro risulta, invece, il richiamo al comma 3 dello stesso articolo (settori di ammissibilità della somministrazione a tempo indeterminato), posto che, ove la somministrazione riguardi un settore non previsto ex lege e/o dalla futura contrattazione, non si possono ravvisare “ragioni che giustifichino” detto comportamento.
La somministrazione illecita costituisce un’ipotesi di reato e vi verifica nei casi in cui il contratto sia concluso in assenza dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero al somministratore. La pena prevista, a carico sia del somministratore che dell’utilizzatore, consiste nell’ammenda di 5 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa. Di conseguenza, l’utilizzatore avrà il potere di verificare l’esistenza di tale autorizzazione in capo al somministratore (art. 18, commi 1 e 2).
È previsto, poi, l’incremento della sanzione nei casi di sfruttamento di minori, allorché impiegati in una somministrazione non autorizzata siano minori non occupabili, ovvero che non hanno compiuto il quindicesimo anno di età o che comunque sono ancora soggetti all’obbligo scolastico. In questo caso la pena prevista sia per il somministratore che per l’utilizzatore, consiste nell’arresto fino a 18 mesi e nell’ammenda di base aumentata fino al sestuplo.
Essendo l’autorizzazione rilasciata dal Ministero al somministratore una condizione di ammissibilità dell’istituto, anche in caso di somministrazione illecita il lavoratore può chiedere in giudizio la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.
L’articolo 28 disciplina invece le ipotesi di somministrazione fraudolenta, ovvero effettuata “con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo”. In questo caso l’ammenda (prevista per entrambe le parti del contratto) è elevata a 20 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa. Anche in caso di somministrazione fraudolenta, laddove il contratto non rispetti condizioni e limiti di cui agli articoli 20 e 21 lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore potrà chiedere in giudizio la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.
Al fine di evitare possibili speculazioni ai danni dei lavoratori, l’art. 18, comma 4 prevede per chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione la pena alternativa dell’arresto non superiore ad un anno o dell’ammenda da 2.500 a 6.000 euro. In questo caso, nell’ipotesi in cui il soggetto che compie l’illecito sia il somministratore, è prevista anche la cancellazione dall’albo.
Come anticipato in apertura, con l’entrata in vigore del decreto si apre una delicata fase di transizione e di raccordo tra vecchia e nuova disciplina. Per quel che riguarda l’istituto della somministrazione, in attesa dei nuovi regimi di autorizzazione e di accreditamento da definirsi in sede regolamentare, resterà applicabile la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La nuova ipotesi contrattuale della somministrazione a tempo indeterminato, in particolare, potrà operare sul piano pratico solo una volta definiti i percorsi di autorizzazione, dal momento che le agenzie già autorizzate ai sensi della precedente disciplina (legge 196/1997) sono abilitate a svolgere attività di mera fornitura di lavoro a termine e solo per esigenze temporanee dell’impresa utilizzatrice.
Anche il quadro normativo della somministrazione a termine è, tuttavia, complicato dal fatto che le clausole dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi della predetta legge e vigenti alla data di entrata in vigore del decreto “mantengono, in via transitoria, e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza /…/ con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine” (art. 86, comma 3).
Questo non impedirà l’operatività della somministrazione di lavoro a termine così come regolata dal decreto 276/2003 anche in parallelo alle vigenti clausole contrattuali, ma ciò sarà possibile soltanto a partire dal momento in cui le agenzie di somministrazione saranno pienamente abilitate a operare ai sensi degli articoli 4 e 5. Nell’attesa, infatti, continueranno ad applicarsi le clausole degli attuali contratti collettivi, le quali subordinano l’ammissibilità della somministrazione a termine alla sussistenza di situazioni temporanee con carattere di eccezionalità e straordinarietà.
Di fatto, dunque, per effetto di una scelta certamente discutibile, la somministrazione a tempo determinato così come innovativamente delineata dal nuovo decreto parrebbe essere vincolata dalla prossima (si spera!) definizione del sistema autorizzatorio, con tutte le incertezze ad esso conseguenti.
La consapevolezza delle difficoltà che la transizione al nuovo regime comporterà ha, inoltre, indotto il Legislatore a predisporre un impianto normativo volto a realizzare una prima fase sperimentale della riforma. L’intero titolo III, e quindi anche tutte le disposizioni che abbiamo illustrato, ha, infatti, carattere sperimentale. L’articolo 86 stabilisce che “decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore (del presente decreto) il ministro del Lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle informazioni raccolte /…/, a una verifica con le organizzazioni sindacali /…/ degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza” (art. 86, comma 12).
Di notevole importanza è, poi, la previsione di cui al comma successivo, che ipotizza un accompagnamento guidato della riforma mediante l’intervento delle parti sociali. Entro il 29 ottobre, infatti, il ministro del Lavoro dovrà convocare le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la possibilità di affidare a uno o a più accordi interconfederali la gestione della messa a regime del regime transitorio del presente decreto e dei rinvii in esso contenuti alla contrattazione collettiva (art. 86, comma 13).
Per quanto concerne il settore del pubblico impiego, con l’entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni potranno applicare le nuove disposizioni solo per quel che riguarda la somministrazione a tempo determinato. Infatti, a fronte dell’abrogazione degli articoli da 1 a 11 della legge 196/97 disposta dall’articolo 85, il successivo articolo 86, comma 9 stabilisce la possibilità la P.A. di applicare le norme relative alla somministrazione di lavoro a termine, e non anche quelle sul contratto a tempo indeterminato.
La stessa disposizione precisa, inoltre, che in caso di somministrazione illecita il lavoratore non potrà, a differenza che nel privato, chiedere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Anche per il settore del pubblico impiego vale, poi, la norma transitoria contenuta nel terzo comma dell’articolo 86. Questo significa che nell’attesa della messa a regime dell’istituto della autorizzazione, come per il settore privato, continueranno ad applicarsi le clausole contenute negli attuali contratti collettivi, i quali subordinano l’ammissibilità della somministrazione a termine alla sussistenza di situazioni temporanee con carattere di eccezionalità e straordinarietà.
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento.
STUDIO LEGALE GGM & PARTNERS
Il contenuto della presente circolare è frutto dell’attività di ricerca e di analisi svolta dai componenti dello studio legale Galanti Gelfi Meriggi & Partners.
La circolare è destinata unicamente ai clienti dello studio e, pertanto, la sua comunicazione a soggetti diversi dai destinatari, la sua ulteriore diffusione e/o riproduzione non autorizzata è vietata.