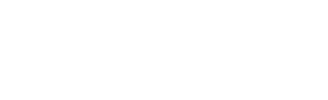[Aprile 2008] - Il software e il requisito di “originalità”
L’individuazione dello strumento giuridico da utilizzare per la tutela del software è stata negli ultimi anni una problematica che ha generato contrasti e divisioni sia tra gli addetti ai lavori che nell’ambito della dottrina e giurisprudenza.
Infatti, da tempo era stato aperto un acceso dibattito tra i sostenitori del brevetto quale strumento di salvaguardia dei programmi per elaboratore ed i sostenitori dell’attuale sistema di tutela basato sul diritto d’autore.
Negli ultimi anni si è, tuttavia, consolidato l’orientamento che ritiene il diritto d’autore quale unico strumento legale adeguato alla tutela dei diritti dei programmi per elaboratore e, ciò, ha trovato come ultima e ulteriore conferma la mancata approvazione del progetto di direttiva europea sulla brevettabilità del software nel luglio’05.
In Italia, l’art. 2 della Legge sul Diritto d’Autore (Legge 633/1941) sancisce la tutela dei programmi per elaboratore espressi in qualsiasi forma, unitamente al materiale preparatorio per la progettazione degli stessi, purchè originali e creativi.
Questa tipologia di protezione giuridica presuppone l’automatica tutela alla nascita dell’opera e tale caratteristica la rende più accessibile. Inoltre il diritto d’autore consente una tutela anche nei confronti di opere di carattere “funzionale”, ma limitate sotto il profilo della originalità.
Pertanto, l’orientamento ormai consolidato è più rivolto a proteggere opere in cui prevale l’aspetto pratico ed applicativo, rispetto ad opere innovative e di alto livello di qualificazione degli elementi creativi.
Proprio a tal riguardo nel 2007 la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito al principio di “originalità” del software, rafforzando il carattere meno rigoroso attribuito al diritto d’autore rispetto alla tutela brevettuale.
Infatti la Corte Suprema ha osservato che se da un lato i software devono essere “il frutto di una elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti”, nondimeno “la creatività e l’originalità sussistono anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purchè formulate e organizzate in modo personale e autonomo rispetto alle precedenti” (Cass. Civ. Sez. I n. 581 del 12/01/07).
Questa pronuncia ha quindi esteso il concetto di originalità non solo a casi in cui l’innovazione apportata sia una evoluzione significativa rispetto allo stato dell’arte, ma anche nei casi in cui “l’opera sia composta da idee e nozioni semplici ma formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti”.
In forza del ricordato principio la Suprema Corte ha ritenenuto sufficiente l’adattamento “dell’architettura applicativa al caso e all’ambiente tecnologico specifico”, per considerare il software innovativo e quindi originale e come tale tutelabile.
La forte esigenza di proteggere i singoli programmi per elaboratore senza arrestare il processo di innovazione tecnologico/scientifico è sempre stata il fattore cardine, nonché l’impulso che ha mosso l’Unione Europea e l’Italia verso una tutela giuridica non brevettuale. Questo ha consentito la libera diffusione di idee, principi e algoritmi alla base dei software.
Quanto però affermato dalla Corte Suprema, oltre a confermare questo orientamento ne amplia i confini. In questo modo due programmi per elaboratore con identica architettura applicativa e caratteristiche funzionali, che si differenziano solo per alcuni profili di adattamento, possono essere considerati due software originali e non l’uno l’opera derivata dell’altro.
Per comprendere le motivazioni di tale orientamento giurisprudenziale significative sono le osservazioni fatte dalla Corte di Appello di Milano (25 febbraio 2003), successivamente richiamate dalla Corte di Cassazione. Infatti la Corte d’Appello milanese ha osservato come “tutti i prodotti software che risolvono la stessa esigenza applicativa presentano una architettura di base che è comune alla maggior parte dei sistemi di controllo dei processi industriali, tuttavia ciò non impedisce di individuare la specificità di un singolo prodotto, in quanto l’innovazione risiede nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso e all’ambiente tecnologico specifico”.
Alla luce di quanto sopra illustrato, è rilevante comprendere come può compiersi una valutazione comparativa tra due programmi per elaboratori onde poter individuare eventuali violazioni del diritto d’autore.
A tal fine occorre distinguere ciò che nel software rappresenta la forma espressiva da ciò che riguarda i contenuti.
La prima trova la tutela giuridica in quanto è l’elemento al quale si richiede “originalità”, mentre i contenuti sono composti da quelle idee e principi che la Corte Suprema ha individuato come non tutelabili.
Pertanto, non sembrano poter essere considerati elementi a favore della originalità del programma elementi estrinseci come la veste grafica o l’interfaccia utente. Infatti sempre più spesso si possono riscontrare sul mercato software con caratteristiche, funzioni e formati simili o addirittura identici.
Occorre quindi valutare l’originalità dei programmi per elaboratori facendo una analisi dei fattori intrinseci che li compongono, mediante l’analisi del “codice sorgente”, rappresentato da quell’insieme di istruzioni appartenenti ad un determinato linguaggio di programmazione, utilizzato per realizzare un programma per computer.
E’ proprio dall’analisi del “codice sorgente” che si potrà valutare l’opera dell’autore nel trovare soluzioni originali che personalizzino una architettura di base comune.
Pur considerando l’estensione concessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza al concetto di originalità in tema di software, non ci si può esimere dall’evidenziare il rischio insito in una dilatazione così accentuata di tale concetto, senza adeguatamente valorizzare l’ulteriore e rilevante requisito della “creatività” come elemento necessario per la tutela del software, secondo i principi del diritto d’autore.
Si può quindi configurare il rischio di ampliare la tutela giuridica a programmi per elaboratore non originali, ma derivati da altri software e diversificati da questi ultimi solo per lievi e ininfluenti modifiche. Ciò finirebbe per rivelarsi eccessivamente pregiudizievole per i diritti dell’opera originale. Il rischio è infatti quello di disincentivare nel medio-lungo termine i produttori di software e le aziende ad investire denaro e ricerca per la creazione di programmi per elaboratori innovativi. L’effetto finale sarebbe quello di inaridire un settore che fino ad oggi ha dimostrato una forte propensione alla creatività ed all’innovazione. (Pubblicato su “Il Sole 24 Ore” del 14/04/08)
*Marco Emanuele Galanti
*Andrea E. Cavalloni
*Studio Legale Galanti – Meriggi & Partners, Milano