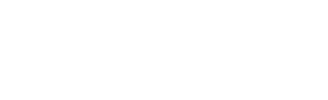[Luglio 2009] - Il Processo sommario si gioca il futuro alla prima udienza
di Marco Emanuele Galanti e Fabio Meriggi*
Dal 4 luglio, data di entrata in vigore della riforma, per tutti i procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, la parte che agisce in giudizio potrà scegliere se ricorrere ancora al “vecchio” schema processuale, contraddistinto da tempistiche solitamente molto lunghe, oppure se optare per il procedimento sommario, al fine di ottenere un provvedimento del Giudice in un arco di tempo “presumibilmente” molto più breve.
Il procedimento dovrà essere introdotto con ricorso ed il Giudice fisserà la data della prima udienza concedendo termine per la relativa notifica alla parte convenuta con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto all’udienza medesima. La parte convenuta dovrà costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima della data d’udienza proponendo le più specifiche difese, prendendo posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicando i mezzi di prova e producendo i documenti di cui intende avvalersi.
Alla prima udienza, e fuori dai casi di incompetenza o inammissibilità dei ricorsi, al Giudice potrà prospettarsi uno dei seguenti scenari: a) la causa potrebbe rivelarsi “matura per la decisione”, con conseguente emissione del provvedimento conclusivo, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva; b) sulla base delle difese delle parti, potrebbe rivelarsi necessaria un’istruzione probatoria non sommaria, con conseguente “trasformazione” del processo da sommario a ordinario; c) potrebbe invece rivelarsi necessaria un’istruzione breve e sommaria, ed in tal caso il Giudice provvederà a raccogliere le prove, decidendo in seguito il giudizio.
Ove, poi, solo le domande riconvenzionali della parte convenuta dovessero richiedere un’istruzione non sommaria, il Giudice potrà separare il giudizio “principale” da quello relativo alla riconvenzionale, decidendo il primo ed istruendo il secondo.
L’ordinanza conclusiva del procedimento sommario è appellabile entro il trenta giorni dalla sua notificazione o comunicazione. Nell’eventuale procedimento di appello possono essere ammessi solo mezzi di prova ritenuti rilevanti ovvero che la parte interessata non abbia potuto proporre in precedenza, per causa a lei non imputabile.
Una scelta prudente quella del Legislatore che, anziché ridurre la molteplicità dei riti, ha optato per un nuovo ed ulteriore rito sommario, che attribuisce al Giudice un’ampia discrezionalità per l’eventuale conversione in procedimento ordinario, introducendo così un ulteriore elemento di incertezza sulle potenzialità della novità di alleggerire i ruoli ed abbreviare i tempi delle cause. E’ comunque ragionevole ritenere che almeno una parte dei procedimenti civili dovrebbe beneficiare di tempi più brevi. Occorrerà, tuttavia, che Magistrati ed Avvocati profondano il massimo impegno, per non vanificare gli aspetti positivi della riforma.
I Magistrati dovranno evitare di fissare la prima udienza troppo distante dal deposito del ricorso e procedere alla trattazione conoscendo a fondo gli atti e i documenti di causa. Gli Avvocati, da parte loro, non dovranno abusare del nuovo strumento, ma utilizzarlo solo in presenza di fattispecie di rapida definizione: in presenza di casi complessi e che richiedano un’ampia istruzione probatoria, si dovrebbe optare per il processo ordinario. Altrimenti si corre il rischio del deposito di un elevatissimo numerosi di ricorsi per procedimenti sommari, con effetti opposti a quelli perseguiti dal Legislatore.
I Giudici, infatti, potrebbero essere costretti a produrre un rilevantissimo, quanto inutile sforzo, necessario per esaminare, in tempi brevi, un’enorme quantità di atti e documenti, già in origine “destinati” a confluire in una diversa tipologia di processo. Non vi sarebbe, quindi, alcun effetto di razionalizzazione e smaltimento dei carichi pendenti, ma un ulteriore aggravamento di una situazione già critica. Inoltre, un utilizzo improprio del rito sommario potrebbe comportare un rilevante rischio per le i ricorrenti ed i loro legali, che potrebbero incorrere in una rapida soccombenza, ben difficilmente riparabile in appello, ove non potrebbero essere ammesse prove colpevolmente non richieste e/o fornite nell’ambito del procedimento sommario.
Infine, va anche ricordato che la riforma, ha introdotto la possibilità per il Giudice di condannare la parte soccombente, per aver agito con mala fede o colpa grave, al pagamento, a favore di controparte, di una somma equitativamente determinata, e ciò anche indipendentemente da qualsivoglia prova di danno al riguardo. In casi estremi, quindi, potrebbe verificarsi non solo l’ipotesi di reiezione dei ricorsi ma anche quella di condanna della parte ricorrente al pagamento sia delle spese di lite sia dell’ulteriore somma determinata secondo equità.
Avv.ti Marco Emanuele Galanti e Fabio Meriggi*
(Tratto dal Sole 24 Ore del 13/07/2009 – pag. 10 “norme e tributi”)
* Marco Emanuele Galanti – Fabio Meriggi
*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners