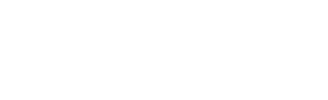E-commerce Lo sviluppo continuo della tecnologia applicata ad Internet ha realizzato un modo rivoluzionario di comunicazione che conseguentemente ha permesso agli utenti della rete, indipendentemente dalla propria localizzazione, di poter accedere in maniera semplice e soprattutto rapida a prodotti e servizi offerti da aziende situate ovunque nel mondo. Avvalendosi di mezzi informatici per la trasmissione e lo scambio di dati ed informazioni, gli operatori commerciali e gli utenti sono diventati potenziali parti di rapporti contrattuali utilizzando un nuovo sistema di conclusione di accordi commerciali genericamente denominato Electronic Commerce.
In prima approssimazione l’E-commerce si può definire come lo scambio di beni e servizi, attraverso una rete telematica.
All’interno di questo nuovissima tipologia di mercato si distingue tra commercio elettronico “diretto” e “indiretto”. Il primo è quello che si svolge interamente on-line ed ha per oggetto del contratto un bene immateriale, generalmente un servizio (ad esempio l’acquisto di un software), che viene trasmesso e immediatamente consegnato al cliente sul proprio personal computer attraverso la stessa rete tramite un’operazione denominata “download” (lett. scaricare).
Il secondo invece non può sfruttare pienamente la potenzialità di trasmissione delle reti telematiche in quanto l’oggetto del contratto è un bene materiale (ad esempio un libro, un computer, un CD, ecc.) che viene prima ordinato sul Web e in un secondo tempo spedito, off-line, tramite corriere espresso.
A questa prima differenziazione di carattere generale se ne deve aggiungere un’altra altrettanto importante di carattere soggettivo: infatti, ai fini di una corretta disciplina giuridica, e a prescindere dalle modalità di conclusione del contratto, è necessario qualificare l’utente/acquirente.
Convenzionalmente per l’e-commerce si distingue tra Business to Business e Business to Consumer. Nella prima categoria (BB) rientrano tutte quelle transazioni nelle quali l’utente/acquirente è un’azienda o comunque un individuo che opera nell’ambito della propria attività professionale. Nella seconda (BC) rientrano, invece, quelle transazioni compiute da una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. E’ il caso del c.d. shopping on line, dove ormai gli operatori commerciali che vendono al minuto i propri prodotti sono davvero numerosissimi.
La distinzione è molto importante perché, sia a livello comunitario che a livello nazionale, la scelta di politica legislativa per la tutela del consumatore si è ormai consolidata ed espressa in un ampio pacchetto di norme, che dovrà essere applicato anche alle vendite telematiche. Tali norme sono espressamente volte a garantire la tutela del consumatore/persona fisica, che agisce al di fuori delle sue attività professionali e che, in quanto tale, è considerato la parte debole del rapporto.
Pertanto è evidente che in forza dell’individuazione dei diversi destinatari, il contenuto delle informazioni da fornire all’acquirente dovrà subire delle variazioni.
In particolare, per i contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici l’Italia ha recepito, con il D. Lgs. 15 gennaio 1992, n.50 in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, la direttiva n.85/577/CEE. Inoltre, per garantire ulteriormente la tutela del consumatore telematico, con D. Lgs. 22 maggio 1999, n.185 è stata recepita anche la Direttiva 97/7/CE, che ha finito per sovrapporsi per molti aspetti a quella emanata precedentemente. Opportunamente l’art.15, II comma del D. Lgs. n.185/99 stabilisce che in attesa dell’emanazione di un Testo Unico di coordinamento delle legislazioni in materia (D. Lgs.50/92, D. Lgs. 114/98 e D. Lgs. 185/99) ” …si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo”.
Attraverso questa disciplina si è voluto in particolar modo tutelare il consumatore dalle vendite cd. aggressive, e cioè quelle vendite che si realizzano per corrispondenza, su catalogo, direttamente a domicilio e, pertanto, anche quelle che avvengono sul web. Le norme in questione garantiscono al consumatore un diritto d’informazione al quale corrisponde un correlativo obbligo del venditore d’informare. In particolare le informazioni obbligatorie previste dall’art.3 del D.Lgs. n.185/99 riguardano l’identità del fornitore, le caratteristiche essenziali del bene o del servizio, il prezzo del bene o del servizio comprese le tasse, le spese di consegna, le modalità di pagamento, le modalità della consegna o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto, l’esistenza del diritto di recesso (ampiamente disciplinato dall’art. 5 dello stesso decreto) o l’esclusione dello stesso per i casi previsti dall’art. 5 comma III del decreto, le modalità e i tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso, la durata della validità dell’offerta e la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata e periodica.
L’art. 4 del decreto prevede inoltre che il consumatore debba ricevere “… conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo precedente prima o al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore ulteriori informazioni riguardanti le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può eventualmente presentare reclami, i servizi di assistenza e le garanzie commerciali esistenti nonché le condizioni di recesso dal contratto nel caso di durata indeterminata o superiore ad un anno”. Il secondo comma dell’articolo citato precisa che tale conferma successiva non è operante nei casi di “contratti di fornitura di servizi, mediante una tecnica di comunicazione a distanza quando siano forniti in un’unica soluzione e siano fatturati dall’operatore della tecnica stessa” (si pensi allo scaricamento di brani musicali su licenza o allo scaricamento di software).
· Internet come vetrina pubblicitaria Indubbiamente Internet
rappresenta ormai per l’impresa uno strumento unico per farsi conoscere e per pubblicizzare i propri prodotti e servizi. Attraverso la rete non è solo possibile effettuare delle transazioni, ma si possono anche dare informazioni sulla propria azienda, farsi pubblicità e realizzare così delle strategie di marketing molto produttive.
Si ricorda infatti che la prima e vera utilizzazione della rete, da parte delle imprese, è stata l’apertura di siti di semplice esposizione della propria attività, dei propri beni e servizi, realizzando i cosiddetti cataloghi on-line, esposti in una sorta di vetrina pubblicitaria virtuale.
In poco tempo proprio la fase pubblicitaria del rapporto commerciale si è andata espandendo in rete attraverso l’utilizzazione da parte delle imprese dei cosiddetti banner: i banner non sono altro che delle bandiere/strisce contenenti un messaggio pubblicitario (il più delle volte lampeggiante e quindi di immediato richiamo per l’utente) presenti su pagine web di siti appartenenti ad altri..
Inoltre, la tecnologia ha permesso di ottimizzare questa nuova tecnica pubblicitaria attraverso l’utilizzazione di banner attivi: quest’ultimi contengono un link (rimando/collegamento) alla Home Page (prima pagina) del sito dell’impresa a cui si riferiscono, in modo che l’utente/navigatore incuriosito, clickando, possa accedere direttamente al sito stesso. E’ evidente che la potenzialità promozionale di tali strumenti cresce in funzione della postazione in cui si è scelto di inserire il banner, in quanto, per il raggiungimento di un risultato apprezzabile sarà essenziale che esso venga collocato nelle pagine dei motori di ricerca più visitati o in quelle dei siti con più alto tasso di contatti giornalieri.
In questo modo ci si assicura pubblicità, previo perfezionamento di accordi preventivi con i soggetti titolari dei siti, ogni volta che il navigatore visita il sito altrui. Questi accordi preventivi si realizzano, in genere, attraverso dei contratti di diffusione pubblicitaria in quanto, anche se la diffusione on-line della comunicazione d’impresa è da considerarsi atipica rispetto a quella tradizionale, ciò non toglie che possa qualificarsi ugualmente come pubblicità.
· Assegnazione del Domain Name
Il primo passo da effettuare per svolgere un’attività commerciale o anche soltanto pubblicitaria su Internet, è quello di assicurarsi un accesso alla rete e creare un proprio sito. Il sito per essere immediatamente riconoscibile e raggiungibile dagli utenti della rete dovrà essere identificato con il c.d. Domain Name.
Il domain name è un indirizzo elettronico. Ogni computer allacciato ad Internet deve essere dotato di un proprio codice di identificazione che lo renda individuabile e quindi raggiungibile dagli altri computer. Tale codice, il cd. indirizzo IP , è determinato secondo le specifiche del TCP Internet Protocol ed è formato da un numero binario, suddiviso in gruppi di cifre, ciascuno dei quali svolge una precisa funzione. E’ evidente che sarebbe oltremodo difficile, se non addirittura impossibile, pretendere che ogni singolo utente della rete conosca e memorizzi tutti quest’insieme di numeri per poter accedere ai siti altrui. Per questo motivo è stato creato il sistema DNS, Domain Name System, ossia il sistema dei nomi di dominio. In tal modo l’indirizzo digitato dall’utente, composto da semplici parole, viene immediatamente commutato da un apposito software nell’indirizzo IP corrispondente, che resta l’unico in grado di essere riconosciuto dai computers. Pertanto, sotto il profilo funzionale, il domain name non è altro che la traduzione letterale di un codice numerico.
Per poter ottenere un proprio domain name ci si deve registrare presso specifiche autorità. L’autorità di registrazione italiana è la Registration Authority Italiana (R.A.) ed ha sede a Pisa presso l’Istituto per le applicazioni telematiche del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Alla R.A., costituita nel 1994, è stato affidato il compito di assegnare i nomi di dominio per il livello (Top Level Domain) “.it”, e di tenere i relativi registri. Le disposizioni che regolano l’attività dell’autorità di registrazione sono stabilite dalla Naming Authority Italiana (N.A.), organismo costituito da esperti del settore accademico e commerciale, e costituiscono la cd. “Regole di Naming”. Da rilevare che questi due enti sono autonomi l’uno dall’altro: il primo svolge funzioni operative (R.A), il secondo funzioni normative (N.A.)
. A livello pratico per poter ottenere l’assegnazione di un nome di dominio il richiedente dovrà compilare un’apposita Lettera di Assunzione di responsabilità, accompagnata dal modulo di registrazione per nomi a dominio, entrambi rilasciati dalla Registration Authority e inviarli successivamente a quest’ultima.
Nella lettera al richiedente viene richiesto di dichiarare:
- di essere a conoscenza che l’assegnazione di un nome a dominio e la sua registrazione sono soggette a norme e procedure stabilite dalla Naming Authority;
-· di essere a conoscenza e di accettare la procedura per le eventuali contestazioni del nome di dominio contenuta nell’estratto delle norme e procedure stabilite dalla Naming;
-di sollevare la R.A. da qualsiasi responsabilità derivante dall’assegnazione e dall’utilizzo del nome di dominio da parte del richiedente;
-di avere titolo all’uso e/o disponibilità giuridica del nome di dominio richiesto e di non ledere con tale richiesta di registrazione diritti di terzi;
- di essere a conoscenza e di accettare che in caso di erronea o falsa dichiarazione nella richiesta, la R.A. provvederà all’immediata revoca del nome a dominio, salvo ogni più ampia azione legale.
Una volta ricevuta la lettera, la R.A. effettuerà delle verifiche per rilevare la congruenza tra la richiesta e le regole di naming stabilite dalla Naming Authority per il dominio “.it”; nonché per verificare la correttezza tecnica e formale della richiesta stessa. Entro dieci giorni dal momento della ricezione del modulo di registrazione, sintatticamente corretto, e degli altri documenti necessari, il richiedente verrà informato della conclusione con successo della procedura di registrazione e dell’avvenuto inserimento del nuovo nome di dominio nei name service e nelle tabelle operative necessarie al corretto utilizzo dello stesso.
Sul punto si rileva che fino ad oggi l’assegnazione dei domain names non è stata disciplinata a livello normativo , ma ha seguito un principio fondato sull’anteriorità della domanda di registrazione, il cd. principio del “first come, first served” in base al quale un determinato nome di dominio viene assegnato al primo soggetto che ne faccia richiesta. Pertanto, è accaduto che in passato siano stati concessi domain names corrispondenti a marchi famosi a soggetti diversi dai legittimi titolari di tali marchi. Anzi, spesso è accaduto che questi domain names siano stati ottenuti con un preciso scopo ricattatorio (Domain Name Grabbing) da soggetti che, ben consci di tale corrispondenza, si sono appropriati di nomi famosi proprio con l’intento di rivenderli poi a caro prezzo ai legittimi titolari.
Dottrina e Giurisprudenza maggioritaria ritengono sostanzialmente, seppur con diverse motivazioni, che sia illegittimo l’uso da parte di terzi di domain names coincidenti con i segni distintivi di soggetti legittimamente titolari degli stessi. D’altro canto si rileva che vi sono state pronunce contrarie a questo tipo d’orientamento basate sul principio che, in assenza di una specifica legislazione in materia, il domain name non può che essere considerato come semplice indirizzo elettronico e, pertanto, non tutelabile.
· Vendita di beni e la fornitura di servizi su Internet
Dopo aver registrato il proprio domain name per poter dare avvio all’attività commerciale dovranno essere espletati gli adempimenti Amministrativi previsti dal decreto legislativo n.114/98 . Solo dopo aver ottenuto le relative autorizzazioni l’impresa potrà finalmente offrire i propri prodotti o servizi su Internet ad una platea infinita di possibili acquirenti.
Per quanto riguarda invece la stipulazione del contratto, si precisa che anche in Internet, esattamente come nei tradizionali rapporti commerciali, l’accordo delle parti si realizza nel momento dell’incontro tra proposta e accettazione. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge (art. 1350 c.c.) ove il nostro ordinamento impone la forma scritta (ad substantiam) a pena di nullità per la conclusione del contratto (ad es. vendita di beni immobili, locazione di immobili di durata superiore a nove anni, ecc.), per gli altri casi l’ordinamento lascia piena libertà contrattuale alle parti per manifestare il loro accordo: si tratta del cd. principio di libertà delle forme in base al quale le parti possono scegliere liberamente il mezzo più idoneo per manifestare il proprio consenso. Nella prassi tradizionale basti pensare ai contratti conclusi a voce, per telefono, via fax: pertanto, nulla esclude che la conclusione del contratto possa avvenire anche tramite posta elettronica o attraverso il Word Wide Web. Ciò vale soprattutto in relazione ai contratti relativi alla compravendita di beni mobili o di fornitura di servizi.
D’altra parte sebbene l’uso dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale si sta sempre più espandendo per la contrattazione on-line, ci vorrà ancora del tempo perché divenga la prassi anche per le transazioni più semplici e di minor rilevanza economica.
Secondo l’art. 1326 c.c. “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”. La conclusione del contratto in Internet avviene mediante l’incontro telematico tra proposta e accettazione. L’uso del mezzo telematico non muta sostanzialmente la natura contrattuale delle operazioni.
Ciò che avviene sul web è paragonabile alla comune vendita al dettaglio. Le pagine web dove le aziende promuovono i lori beni e servizi con i relativi prezzi sono delle vetrine virtuali, ove il navigatore/acquirente può vedere e scegliere ciò che più gli interessa. Giuridicamente questo tipo di operazione ricade nella fattispecie legislativa dell’offerta al pubblico disciplinata dal nostro codice civile all’art. 1336. Infatti, una volta che i prodotti vengono esposti tale offerta, se contiene già tutti gli estremi essenziali del contratto, come la quantità e il prezzo, vale come proposta. Il cliente compila il relativo modulo d’ordine con i propri dati e le modalità di pagamento prescelte. Il meccanismo di tale invio dell’ordine può avvenire sia tramite e-mail (posta elettronica) che mediante la pressione del cd. tasto negoziale virtuale, tipico della navigazione su Internet, cd. sistema del point and click. Una volta comunicato al venditore la propria intenzione di accettare l’offerta, il contratto si perfeziona.
Entrambi questi strumenti possono essere assimilati alla comunicazione postale con relativi indirizzi, ai sensi dell’art.1335 c.c., cui inviare una dichiarazione contrattuale. Ciò viene confermato anche dal Decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997 , secondo cui “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato” (art 12, comma 1).
Ai sensi dello stesso Regolamento per indirizzo elettronico si intende: “l’identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici” (art. 1 lett. l). Si ricorda che, secondo il nostro ordinamento, proposta e accettazione sono atti recettizi, devono cioè essere portati a conoscenza del destinatario per potersi perfezionare. In realtà l’art. 1335 c.c. stabilisce una presunzione relativa di conoscenza (conoscibilità) e non di conoscenza vera e propria, in quanto la conoscenza si presume nel momento in cui la dichiarazione giunge all’indirizzo del destinatario “…se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia” (art. 1335 c.c.).
Pertanto, per quanto riguarda l’e-mail, tale indispensabile esigenza di conoscibilità si ritiene soddisfatta nel momento in cui la dichiarazione di accettazione giunge all’indirizzo elettronico del proponente ubicato sul server del provider. Sarà poi compito del titolare di tale indirizzo scaricare il messaggio sul proprio personal computer, esattamente come avviene per la posta tradizionale una volta che giunge nella relativa casella postale. Si realizza esattamente lo stesso procedimento nel caso in cui l’incontro tra proposta e accettazione avvenga tramite moduli elettronici (forms), sempre che si tratti di accettare una semplice offerta al pubblico: infatti, una volta compilati tali moduli da parte dell’acquirente il contratto si conclude con le stesse modalità dell’e-mail.
L’offerta al pubblico su Internet può però rivelarsi per il venditore un’operazione alquanto pericolosa: infatti, proprio per le caratteristiche della rete che permette l’accesso ad un numero imprevedibile di potenziali acquirenti, il venditore vincolandosi senza poter conoscere in anticipo l’esatto numero di ordini, può, senza volerlo, ritrovarsi inadempiente alle obbligazioni assunte (rischio di esaurimento scorte).
Per potersi cautelare da questo genere di inconveniente, è ormai prassi dei venditori/fornitori inserire nelle proprie pagine web, ove avviene la contrattazione, delle apposite diciture quali “senza impegno” o “salvo conferma”: in tal modo l’offerta non vale come proposta a tutti gli effetti di legge in quanto non contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto. Il visitatore del sito è invitato ad entrare in trattativa (invito a proporre): compilando il relativo modulo e inviandolo al venditore diviene lui il proponente, mentre il venditore, a sua volta inviando la conferma dell’ordine, diviene l’accettante. E’ pacifico come questa operazione sposti il momento della conclusione del contratto: esso infatti si concluderà nel momento in cui l’utente/acquirente ha conoscenza dell’avvenuta accettazione della sua proposta da parte del venditore, invertendo così anche le conseguenze relative alla revoca sia della proposta che dell’accettazione.
Infine, un’altra modalità molto usata in Internet per la conclusione del contratto è quella prevista dall’art. 1327 c.c. “Esecuzione prima della risposta dell’accettante”. Tale ipotesi si verifica quando, attraverso un comportamento concludente, si da inizio all’esecuzione prima dell’accettazione: si pensi al caso in cui l’acquirente decida per il pagamento anticipato tramite comunicazione del numero e dei dati della propria carta di credito oppure al caso in cui scarichi direttamente dal sito sul proprio personal computer un bene immateriale (ad esempio il downloading di software o di brani musicali su licenza).
In tal caso la conclusione avverrà nel momento e nel luogo in cui si trova il computer (o il server del provider) del destinatario della proposta, che ha accettato dando inizio all’esecuzione. · I sistemi di pagamento Le forme di pagamento relative agli acquisti via Internet sono in continua evoluzione. Si stanno sviluppando nuove metodologie che assicurano maggior tutela alle parti che concludono accordi commerciali attraverso la Rete. Fino ad oggi i sistemi di pagamento utilizzati sono:
1. Pagamenti in forma ordinaria Ancora oggi spesso si effettuano pagamenti in modo del tutto tradizionale in quanto molte imprese preferiscono rinviare il momento del pagamento, ad una fase off-line. Pertanto l’operazione commerciale si svolge in due fasi: la prima in Rete, per quanto riguarda la conclusione dell’affare (scelta e ordine), mentre la seconda, relativa al pagamento, viene differita a un momento successivo attraverso l’utilizzazione dei tradizionali strumenti di pagamento come il contrassegno, l’assegno e il bonifico. E’ evidente che la scelta di questa soluzione, seppur sicura, in quanto elimina i rischi di intercettazione, non consente l’integrazione di una transazione totalmente on-line. Ne deriva una sotto-utilizzazione delle potenzialità telematiche di Internet sia per quanto riguarda i vantaggi che quest’ultima può apportare in termini di gestione dei costi, sia per ciò che concerne la celerità stessa dell’operazione.
2. Pagamenti tramite carta di credito La carta di credito è sicuramente lo strumento più naturale per il pagamento di beni e servizi acquistati on-line. Tale strumento può però essere utilizzato in modi differenti. L’utilizzazione più semplice è ancora caratterizzata da una fase off-line: il navigatore/ acquirente dopo aver ordinato i beni e i servizi prescelti in Internet, comunica direttamente i dati della propria carta di credito attraverso un diverso mezzo di comunicazione, ad esempio via fax, per telefono o per posta. Un’altra utilizzazione, e in questo caso tutta la transazione si compie in Rete, prevede che nei relativi moduli (forms) contenuti nei siti, l’acquirente inserisca il proprio numero di carta di credito al momento dell’acquisto. Una volta giunte tali informazioni all’operatore commerciale, quest’ultimo sarà in grado di verificare gli estremi, la validità della carta e la copertura del conto. E’ evidente però che attraverso questo tipo di operazioni nessuna delle due parti è sufficientemente garantita relativamente al buon esito dell’operazione e all’assoluta mancanza di intercettazione dei dati da parte di terzi, pertanto è consigliabile solo per acquisti di modico valore. Invece, una vera rivoluzione in materia di pagamento in Internet mediante carta di credito si è realizzata con l’avvento dei c.d. sistemi sicuri: questi si avvalgano di una tecnologia (denominata crittografia) che riesce a garantire in modo soddisfacente la sicurezza dei dati relativi alle carte di credito e di trasmetterli in Rete criptati. Allo stesso tempo permette di individuare con certezza e di identificare il titolare della carta e i dati forniti da quest’ultimo.
3. Gli assegni elettronici Sono ulteriori strumenti per il trasferimento di denaro e si basano anch’essi sulla crittografia a chiave asimmetrica. Dopo la registrazione presso la propria banca o presso l’esercente da cui intendono acquistare, gli utenti emettono dei certificati digitali con l’importo desiderato e con i propri dati, a cui appongono la firma digitale.
4. Strumenti di moneta elettronica La moneta elettronica può essere incorporata in una smart card. Quest’ultima non è altro che una carta prepagata e ricaricabile. Dato la sua materialità può essere utilizzata sia in Internet che presso i negozi tradizionali. Nella smart card viene inserito un microchip in grado di memorizzare informazioni, come la cifra accumulata di cui il proprietario può disporre per effettuare transazioni. Attraverso degli appositi lettori da collegare al proprio personal computer la smart card permette di effettuare i pagamenti via Internet. Tuttavia, lo strumento di moneta elettronica più innovativo e rivoluzionario è costituito sicuramente dal caricamento e registrazione di un importo di denaro direttamente nella memoria di un computer. L’utente può, naturalmente dopo aver pagato il corrispondente valore ad un istituto emittente predisposto, ottenere moneta virtuale (e-cash). Questa gli viene trasferita attraverso un software e quindi memorizzata sul proprio personal computer sotto forma di moneta digitale. Questa operazione non comporta uno spostamento fisico del denaro, bensì lo spostamento di una sequenza di bit. La moneta digitale è definita nell’importo mediante appositi codici cifrati, che consentono al venditore, destinatario del pagamento, di avere in brevissimo tempo la garanzia della bontà del pagamento grazie alla verifica dei codici medesimi da parte dell’istituto emittente. In questo modo il venditore può accertare immediatamente che non si tratti di denaro contraffatto o già speso in precedenza. Se dalla verifica non emergono simili implicazioni, il software cancella la moneta spesa dalla disponibilità dell’acquirente per trasferirla a quella del venditore. Tale procedimento avviene mediante il trasferimento di dati cifrati con il sistema a doppie chiavi.
Considerata la complessità e le continue innovazioni in relazione alla materia trattata, lo studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento o chiarimento che si dovesse rendere necessario.
Milano Ottobre 2000
Studio Legale GGM