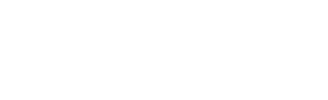[Febbraio 2002] - Riforma dei reati societari: lavori in corso
La riforma dei reati societari, dopo anni di dibattiti politico – giuridici e di lavoro da parte dei giuristi della commissione Mirone, è giunta, non senza polemiche, all’esame delle Commissioni Parlamentari, le quali dovranno rilasciare un parere sullo schema di decreto legislativo, contenente la “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’art.11 della legge 3 ottobre 2001, n.366”, approvato l’11 gennaio 2002 dal Consiglio dei Ministri.
E’ interessante, quindi, non solo esaminare, per grandi linee, le nuove norme previste dall’art.1 del suddetto decreto legislativo - che andranno a sostituire quelle attualmente in vigore nel codice civile al titolo XI, libro V, articoli 2621/2642 -, ma occorre soprattutto e in via preliminare evidenziare i caratteri generali di questa riforma confrontandoli con quelli che hanno retto fino ad ora il diritto penale societario.
In primo luogo, la riforma non va considerata limitatamente al falso in bilancio, in quanto questa fattispecie, pur avendo una preminenza assoluta nell’ambito del diritto penale societario ed un ruolo centrale nella repressione della criminalità economica, non può esaurirne la portata più ampia in tema sia di controllo penalistico dell’attività economica che di politica criminale.
In secondo luogo, la legge delega 366 del 2001, sebbene avesse dovuto riprendere il testo già elaborato dalla commissione Mirone in segno di continuità con l’attività di riforma avviata dal precedente Governo, ha introdotto invece all’interno delle singole fattispecie incriminatrici elementi di modifica di tale rilevanza da comportare un distacco radicale dal progetto precedente.
Infatti, nei primi commenti di illustri giuristi si evidenzia come tra il progetto Mirone e la suddetta legge delega “le coincidenze divengono puramente formali, essendo radicalmente mutato lo spirito dell’intervento”. Secondo tali autori il progetto Mirone era solo un “avvio” di riforma certamente bisognoso di miglioramenti in molte parti e mirava ad una riscrittura dei reati societari che, non solo semplificasse le norme, riducesse l’eccesso di penalizzazione e colmasse antiche lacune di tutela, ma tenesse altresì conto della longevità, dell’inadeguatezza e della scarsissima efficienza del nostro diritto penale.
La mancanza di razionale equilibrio tra l’attuale sistema penale e lo schema di decreto legislativo in esame è il punto critico della riforma. Le nuove norme in materia societaria, pur ispirandosi a principi incontestabili come la determinazione e la tassatività della condotta criminale, comporteranno un restringimento dell’ambito di applicazione della sanzione penale in senso stretto a favore di quella contravvenzionale. Tuttavia questo ipotizzato restringimento non si realizzerà in modo omogeneo nei confronti di tutte le fattispecie penalmente rilevanti previste dal codice penale, ma solo nei confronti di quelle societarie. Ciò potrà determinare evidenti squilibri tra fattispecie criminose disciplinate dal codice penale e fattispecie disciplinate invece da legislazione speciale.
Se da un lato, allora, si può porre l’accento su questa incoerenza, dall’altro si deve anche dire che queste scelte normative, contenute nello schema del decreto legislativo in esame, sono dettate da una già avviata “armonizzazione europea ”, che prevede in materia societaria un aumento delle ipotesi contravvenzionali. In Italia una prima attuazione di detta “armonizzazione ” si è avuta nella cosiddetta “legge Draghi” del 1998, in cui le false comunicazioni alla Consob sono previste come ipotesi contravvenzionali.
Per questo lo schema di decreto legislativo non deve essere ritenuto né un esperimento isolato né una creazione dell’attuale legislatore, ma deve servire da stimolo per una successiva fase di riforma del nostro sistema penale in modo che questo si caratterizzi per uniformità di disciplina e un elevato grado di efficienza.
Fatte queste premesse generali, passiamo ad analizzare le novità contenute nelle singole fattispecie di reato e le problematiche connesse.
Primi fra tutti vanno considerati gli articoli “sulle falsità” (2621-2625 c.c.). Questi stanno suscitando le maggiori perplessità e critiche, data la sostanziale metamorfosi a cui è sottoposto l’illecito base “delle false comunicazioni sociali”. Infatti, i nuovi articoli prevedono che il neo reato di “falso in bilancio” sia sussistente e sanzionabile “con l’arresto fino a un anno e sei mesi” solo quando:
“gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l’intenzione di ingannare i soci e il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto (dolo specifico), nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione (pericolo concreto)” (art.2621, 1°comma, c.c.).
Per completezza, si deve aggiungere che, oltre agli elementi del pericolo concreto e del dolo specifico presenti nella condotta criminosa prima descritta, sono richiesti per la punibilità sia che “le falsità e le omissioni alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene o comunque determinino una variazione del risultato economico, al lordo delle imposte superiore al 5% ”, sia che “le valutazioni estimative, singolarmente considerate, differiscano in misura superiore al 10% rispetto a quella corretta ” (3°- 4°comma, art.2621 c.c.).
E’ questa la struttura portante del nuovo reato di falso in bilancio che si riscontra anche nel “falso in prospetto” (art.2623 c.c.) e nel caso di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione” (art.2624 c.c.), comportando un definitivo abbandono dell’impostazione “plurioffensiva ”. Tale impostazione, ritenendo invece sussistente il reato di falso in bilancio ogniqualvolta l’esposizione o l’omissione di fatti non rispondenti al vero risultava idonea a ledere o a porre in pericolo una pluralità di interessi di portata diversa (interessi patrimoniali della società, dei soci, dei creditori, la fede pubblica, il corretto funzionamento della società commerciale e così via), poteva essere di difficile accertamento e causa anche di veri e propri arbitri.
Il legislatore, dunque, ha preferito, come abbiamo accennato, non solo determinare con più precisione il bene giuridico oggetto di tutela – non più un interesse pubblico, ma interessi privatistici degli azionisti, dei creditori, dei destinatari del prospetto o delle comunicazioni rilasciati dalle società di revisione – ed elevare la soglia di punibilità, ma anche prevedere una variante più grave dell’illecito base. Questa si realizza nel caso in cui “le false comunicazioni o l’omissione di esse cagionino un danno patrimoniale ai soci o ai creditori” (art.2622 c.c.). In quest’ultimo caso, però, la fattispecie “delittuosa” si sdoppia a seconda che l’illecito venga commesso in “società quotate o non”.
Nel primo caso, allora, le pene saranno più severe, “reclusione da uno a quattro anni e procedibilità d’ufficio” (3°comma, art.2622 c.c.). Nel secondo caso, invece, “la reclusione potrà andare da sei mesi a tre anni e servirà sempre la presentazione della querela della parte lesa” (ult. part.1°comma, art.2622 c.c.).
E’ immediatamente evidente come nell’articolo 2622 c.c. siano contenute le novità di maggior rilievo ma anche di maggior perplessità. Infatti, la fattispecie subisce una brusca deviazione dall’art.2621 all’art.2622, in quanto il primo articolo la qualifica come vera e propria contravvenzione e si rivolge a destinatari indeterminati (soci e pubblico), mentre il secondo, spostando l’attenzione sulla lesione del patrimonio del singolo, la ritiene un delitto a tutti gli effetti e ribadisce che il bene protetto è pienamente disponibile da parte del soggetto leso, il quale può decidere di ricomporre il conflitto in ambito negoziale attraverso la querela.
Non si riescono poi a comprendere le ragioni vere per cui le società non quotate debbano avere uno statuto penalistico privilegiato rispetto a quello delle società quotate, per le quali è prevista la procedibilità d’ufficio. Si può solo presumere che il reato di falso in bilancio nelle società non quotate sia stata considerata meno grave rispetto a quello commesso in società quotate.
Dal punto di vista edittale, la scelta di contenere in questi casi di danno patrimoniale la sanzione della reclusione nel tetto massimo di quattro anni non rappresenta un vero e proprio “depotenziamento” del falso in bilancio, ma costituisce una comprensibile risposta sanzionatoria adeguata al disvalore del fatto. Al riguardo non deve essere dimenticato che per il reato di truffa (art.640 c.p.), altra ipotesi di danno patrimoniale, è prevista la pena detentiva da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela. Il vero problema legato alla riduzione della sanzione, dunque, non parrebbe essere principalmente di carattere tecnico, ma pratico, dato che la riduzione della sanzione rispetto a quella originariamente prevista andrà ad incidere sulle prescrizioni…
Conclude il capo primo l’art.2625 che, in tema di “impedito controllo”, prevede nei confronti degli amministratori che occultano documenti, al fine di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, una sanzione amministrativa pecuniaria e nel caso di danno patrimoniale ai soci la reclusione fino a un anno con procedibilità a querela di parte (2°comma).
Le regole esaminate fino a questo punto trovano applicazione anche negli altri articoli del decreto legislativo. Per cui si può osservare come nelle norme del capo secondo, riguardanti “gli illeciti commessi dagli amministratori”, sia prevista l’applicazione o della reclusione fino a un anno per il caso di “indebita restituzione dei conferimenti” (art.2626 c.c.) e per quello di “illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o su quelle della società controllante”(art.2628 c.c.), o la sanzione amministrativa dell’arresto fino a un anno per “l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve”(art.2627 c.c.).
La configurazione privatistica si deve notare anche in questi reati, in quanto nel 2°comma dell’art.2627 e nel 3°comma dell’art.2628 sono previste delle cause di estinzione di natura negoziale, come la restituzione degli utili e la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve che, effettuate prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, estinguono la fattispecie criminale.
In questo capo, l’unico riferimento al danno patrimoniale e alla querela di parte si trova nell’art.2629, il quale sancisce “la reclusione da sei mesi a tre anni per gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni o scissioni cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato”.
Nel capo terzo, dedicato agli “illeciti commessi mediante omissione”, l’unica sanzione prevista è quella amministrativa pecuniaria. Si riscontra ciò sia nel caso di “omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi” da parte di chiunque vi sia tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio (art.2630 c.c.), sia nel caso di “omessa convocazione dell’assemblea dei soci” da parte degli amministratori e dei sindaci (art.2631 c.c.).
Nel capo quarto, assumono una certa rilevanza, visto l’esordio assoluto in tale materia, i reati di “infedeltà patrimoniale” (art.2634 c.c.) e di “infedeltà a seguito di dazione o promesse di utilità ” (art.2635 c.c.). L’art.2634 commina in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori e ai responsabili della revisione la sanzione della reclusione (da sei mesi a tre anni), qualora questi, “avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali cagionando alla società un danno patrimoniale”.
L’art.2635 prevede ancora che in capo ai suddetti soggetti si applichi la sanzione della reclusione (fino a tre anni), qualora, a seguito “della dazione o della promessa di utilità ”, questi “compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società”. Per entrambe le fattispecie è richiesto che venga esercitata la querela, per conto della società, da parte di un curatore speciale, previa delibera assembleare.
I restanti articoli non fanno altro che descrivere diversi tipi di illecito societario punibili con la sola reclusione. E’ questo il caso della “formazione fittizia del capitale” (art.2632 c.c.), della “indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”, per la quale si richiede anche la querela della persona offesa (art.2633 c.c.), della “illecita influenza sull’assemblea” (art.2636 c.c.), dell’ “aggiotaggio” (art.2637) e dell’ “ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ”(art.2638 c.c.).
Per concludere, è interessante segnalare sia la previsione di una “circostanza attenuante” nel caso in cui i fatti previsti come reato negli articoli precedenti abbiano cagionato un’offesa di particolare tenuità da comportare la diminuzione della pena (art.2640 c.c.), sia quella della “confisca” del prodotto o del profitto di reato applicabile ad ogni fattispecie descritta (art.2641).
Queste sono, seppur in sintesi, le prime considerazioni sullo schema del decreto legislativo su cui le commissioni parlamentari dovranno esprimere il loro parere.
Il tema, per sua importanza e complessità, richiederà ulteriori riflessioni non appena il provvedimento verrà approvato nel suo testo definitivo.
STUDIO LEGALE GGM