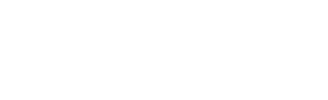[Dicembre 2002] - Il consenso informato all’atto medico: considerazioni generali
Relazione tenuta al Convegno “ Il rischio clinico e l’informazione al paziente”, svoltosi a Milano, il 29 novembre 2002, Centro Congressi Stelline.
Nell’ambito medico, una delle problematiche più delicate è quella concernente i limiti dell’attività medico-chirurgica e l’individuazione delle fonti normative idonee a consentire che un soggetto, sia pure qualificato come il medico, possa intervenire nell’ambito dell’integrità fisica o, più genericamente della salute, di un altro soggetto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
L’art. 32 della Costituzione prevede che la Repubblica tuteli la salute come fondamentale diritto dell’individuo: il principio generale che ne scaturisce è quella dell’intangibilità, da parte della collettività, della salute come bene individuale.
Al di fuori dei casi previsti dalla legge, nessuno può effettuare un trattamento sanitario senza che il paziente abbia prestato il proprio consenso.
In via esemplificativa è sufficiente ricordare il caso di una vaccinazione obbligatoria cui, per questioni di salute pubblica, il cittadino non possa sottrarsi [1] .
Il consenso è quindi quel requisito il quale deve precedere l’attuazione di un qualsiasi programma terapeutico ed al tempo stesso un limite oltre il quale nessun intervento chirurgico, né trattamento sanitario in genere, possano essere considerati legittimi, neppure se attuati nello specifico ed esclusivo interesse del paziente.
Sempre l’articolo 32 della Costituzione prevede che nessuno possa essere sottoposto ad un trattamento medico-chirurgico contro la propria volontà, salvo diverse disposizioni di legge. Il principio è quello del rispetto della persona umana, attraverso il quale l’individuo viene pertanto lasciato libero di autodeterminarsi.
In questa dicotomia tra diritto dell’individuo e diritto della collettività si è sviluppato in Italia il tema del consenso informato, e cioè “della possibilità per il paziente di decidere in modo libero e consapevole sulla propria persona” [2] .
Il principio dell’autodeterminazione del paziente è anche espressione di un principio più generale, enunciato all’art. 13 Cost. nel quale viene sancito che la libertà personale sia inviolabile, con particolare riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica.
L’aspetto che qui occorre mettere in luce è quello della libertà relativamente alle proprie scelte e quindi anche liberà di non subire atti e provvedimenti imposti non giustificati.
L’autonomia con cui il paziente esercita il proprio diritto alla salute permette inoltre di superare i confini descritti dall’art.5 c.c. secondo cui non potranno mai essere permessi atti di disposizione del proprio corpo che possano in qualche modo cagionare una diminuzione permanente della sua integrità.
Da ciò consegue che, nel caso di idonea informazione circa la necessità di un trattamento terapeutico finalizzato alla tutela del bene vita, il consenso da parte del paziente ben potrà legittimare atti di disposizione del proprio corpo idonei a determinare una diminuzione permanente della sua integrità.
Il consenso informato è stato “normativizzato” nel nuovo codice deontologico adottato nel 1995, poi modificato nel 1998.
L’esigenza di “codificazione” del consenso informato veniva avvertita dalla stessa categoria medica, la quale conscia dell’importanza della relazione medico-paziente, confermava che “il medico ha il dovere di dare al paziente, tenendo conto del suo livello di cultura ed emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena e idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive terapeutiche e sulle verosimili conseguenze della terapia e della mancata terapia, nella cosapevolezza dei limiti delle conoscenze mediche, anche al fine di promuovere la migliore adesione alle proposte diagnostiche-terapeutiche”(in tal senso art.30 Codice Deontologico).
Ma ad una informazione “idonea” deve comunque seguire un consenso, il cui ottenimento da parte del paziente non può prescindere da una corretta e completa attività informativa (il tal senso art.32 Codice Deontologico).
L’articolo 32 del Codice Deontologico. prevede inoltre, in presenza di esplicito rifiuto da parte del paziente capace di intendere e volere, che il medico debba desistere da qualsiasi atto diagnostico e curativo, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà del paziente, ad eccezione di casi specifici di cui si tratterà in seguito.
EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI
Nel contesto italiano, soprattutto nell’ultimo decennio, il tema del consenso informato ha avuto un rilevante sviluppo.
Prima della fine degli anni sessanta la problematica del consenso all’atto medico era stata approfondita solo da una minoranza della dottrina [3] .
Il principio del consenso all’atto medico infatti, è stato per parecchi anni un concetto più teorico che pratico e, benché vi fosse una marcata attenzione volta alla regolamentazione etico-giuridica dell’attività medica, le chiavi di lettura della stessa si limitavano a regole e riferimenti morali.
Nel 1967 però, la Corte di Cassazione con la sentenza n.1950 del 25 luglio introduce per la prima volta il concetto della necessità non solo di un consenso ma di un CONSENSO VALIDO (“…il medico nell’esercizio della professione sanitaria non può, senza un valido consenso del paziente, sottoporre costui ad alcun trattamento medico-chirurgico suscettibile di porre in grave pericolo la vita e l’incolumità fisica…”).
Ed ancora nel 1975, con la sentenza n. 2439 del 18 giugno la Corte di Cassazione afferma la necessità, per il medico, di rendere edotto il paziente affinché questi possa dare un consenso valido e quindi consapevole (“il medico il quale intenda eseguire sul corpo del paziente l’intervento rischioso tale da porre in serio pericolo la vita e l’incolumità fisica, ha il dovere professionale di renderlo di ciò edotto affinché questi possa validamente, cioè consapevolmente, prestare assenso al trattamento propostogli…”).
Caratteristica comune ad entrambe le sentenze sopraccitate risulta essere quella del riconoscimento del cosiddetto diritto all’informazione, ovvero l’essere edotti per meglio valutare e comprendere il trattamento medico: benché detto diritto risultava ancora limitato ai casi cosiddetti gravi, queste pronunce aprivano una strada alla dottrina ed ai relativi approfondimenti, sulla base del modello anglosassone ed in particolare quello statunitense [4] .
Con la sentenza n. 4394 del 1985 la Corte di Cassazione sancisce la necessità, di una corretta informazione gravante sul medico, (in questo caso chirurgo estetico), il cui dovere d’informazione deve necessariamente avere un contenuto più ampio rispetto a quello allora concepito (“…ove, quindi, il chirurgo non abbia correttamente informato il paziente in modo chiaro e certo sull’effettivo risultato dell’intervento si prospetta…una responsabilità dell’operatore per i danni patiti dall’assistito…”).
Gli anni novanta infine, hanno definitivamente sancito il radicarsi, sia nella letteratura giuridica che nella stessa giurisprudenza, della necessità di un consenso al trattamento medico: oggi assume grande importanza il rapporto personale che si instaura, o che dovrebbe instaurarsi, tra paziente e medico ed in questa direzione, specie nell’ultimo quinquennio si è mossa la giurisprudenza, ritenendo essenziale la partecipazione critica del paziente alla decisione medica su ogni attività terapeutica possibile o comunque attuabile.
Già a far data dal 1990 la Corte d’Assise di I grado di Firenze con la sentenza n.13 stabiliva che il medico dovesse attenersi alla volontà del paziente poiché “la salute non è un bene che possa essere imposto coattivamente al soggetto interessato dal volere o dall’arbitrio altrui, ma deve fondarsi esclusivamente sulla volontà dell’avente diritto”.
Ed a conferma del sopracitato principio, il 21 aprile 1992 la Corte di Cassazione, sezione V, con la sentenza n.699, affermava che soltanto il CONSENSO, manifestazione della volontà di disporre del proprio corpo, può escludere in concreto l’antigiuridicità del fatto e rendere questo legittimo: il consenso informato si stava trasformando in un requisito etico centrale della relazione medico-paziente, sempre più riconosciuto e dato per acquisito anche nel contesto italiano.
Quello che rileva, ai fini di un consenso validamente prestato, è un’adesione volontaria dell’ammalato alle cure proposte, previa informazione circa i costi ed i benefici del trattamento sanitario. E’ la Corte di Cassazione stessa a compiere questi ulteriori passi finalizzati a connotare il diritto alla salute ed alla autodeterminazione del paziente: punto di partenza delle recenti pronunce è il riconoscimento, negli artt. 13 e 32 Cost., dei fondamenti del consenso al trattamento medico.
Nella sentenza n.10014 del 25 novembre 1994 la Suprema Corte infatti afferma chiaramente che la necessità del consenso si evince in generale dall’art.13 della Costituzione, pertanto il medico che agisca senza il consenso del paziente pienamente informato lede, prima ancora del diritto alla salute, la stessa AUTODETERMINAZIONE del paziente e perciò la sua libertà personale. Viene inoltre specificata la necessità, da parte del medico, di procedere, nei confronti del paziente, ad un’adeguata, opportuna ed esaustiva informazione sugli aspetti relativi al trattamento sanitario prospettato, ivi comprese anche le ipotesi e le conseguenze negative.
Anche la successiva sentenza della Corte del 15 gennaio 1997, n.364 giunge alle medesime conclusioni, che hanno, come punto di partenza, il principio che qualunque esecuzione di terapie o di interventi, in qualche modo capaci di portare gravi lesioni all’integrità fisica del paziente, presuppongano che lo stesso venga diligentemente reso edotto di tutti i pericoli che sono insiti in quella specifica terapia od atto operatorio, anche in relazione ad eventuali tecniche operative egualmente utilizzabili.
Nella fattispecie, nel corso di un intervento chirurgico effettuato in un ospedale civico nell’anno 1979, un paziente veniva sottoposto ad anestesia mediante la pratica di una puntura lombare, dalla quale poi gli derivava una invalidità permanente totale. Se da un lato era evidente che l’intervento richiesto e per il quale il paziente aveva prestato il proprio consenso non poteva prescindere dalla preventiva pratica dell’anestesia, dall’altro non altrettanta evidenza risultava dell’avvenuta spiegazione al paziente sulla particolare metodologia che si era intenzionati ad utilizzare mediante la pratica di una cosiddetta iniezione lombare, notoriamente recante un rischio specifico.
Per questo motivo è stato ritenuto dalla Corte che l’anestesia epidurale comporti una “fine tecnica anestesiologica, mentre la ricerca dello spazio peridurale può risultare in alcuni casi particolarmente laboriosa, con possibilità, anche, di penetrazione nello spazio sottoaracnoideo” così da esporre il paziente a rischi dei quali non era a conoscenza.
Detti concetti sono infine stati ribaditi ed ampliati, dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 3599 del 18 aprile 1997 e n. 9705 del 6 ottobre 1997, prevedendo l’obbligo d’informazione, in capo al medico, anche per i rischi specifici delle singole fasi del trattamento sanitario: il medico deve pertanto informare il paziente anche circa l’esito delle indagini (ad es. ecografia), circa i rischi potenziali ed infine, circa i rischi prevedibili di complicanze in sede postoperatoria.
NATURA DEL CONSENSO INFORMATO
L’espressione “consenso informato” , che a prima vista potrebbe apparire, come alcuni autori sottolineano, apparentemente raddoppiativa [5] (giacché il consenso non informato è un non senso giuridico) ha la finalità di porre l’accento sulla cosiddetta “asimmetria informativa” [6] che inevitabilmente caratterizza certe relazioni, tra cui quella medico-paziente.
Il problema, che si riflette immediatamente sulla qualificazione giuridica del consenso, è se l’interesse che l’obbligo di informazione mira a soddisfare sia quello volto a superare le asimmetrie informative tra medico e paziente, ovvero se non si inserisca nella “procedimentalizzazione necessaria a dar corpo ai principi che presiedono la legittimità di trattamenti ed operazioni” [7] .
Ed è proprio per cercare di arginare detta asimmetria che l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale ha permesso al consenso informato di inserirsi quale condizione di legittimità dell’atto medico.
Pertanto il consenso dovrà essere inteso non come una causa di giustificazione dell’atto medico [8] , ma come quell’atto di autorizzazione a porre in essere quel trattamento sul proprio corpo, espressione del più generale diritto all’autodeterminazione che si traduce in un coinvolgimento del paziente nelle scelte relative alla propria salute.
Infatti, come il soggetto bisognoso di cure può rifiutare il trattamento medico, così può acconsentirvi: in tale caso, il consenso informato, validamente espresso dal paziente, costituisce una fondamentale condizione di legittimità dell’atto medico, da cui non si può prescindere.
Si può perciò affermare che un consenso informato possa essere considerato valido quando sia prestato da persona adulta, capace di intendere e volere.
Ed il primo requisito per un paziente maggiorenne e capace di intendere e volere, espressione della autodeterminazione terapeutica sopraccitata, è quello di un consenso esplicito prestato personalmente.
Pertanto in tutti quei casi in cui il paziente sarà in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, per poter legittimare il trattamento terapeutico, dovrà essere manifestato in modo espresso, con riferimento ad atti medici specifici e determinati.
Nel caso in cui il paziente versi in condizioni di incapacità momentanea (ad esempio nel corso di un intervento chirurgico) e non ricorra una condizione di emergenza che renda improcrastinabile l’atto medico, il sanitario dovrà attendere che il paziente sia di nuovo in grado di esprimere la propria volontà [9] .
Per quanto attiene alla validità del consenso ed alla adeguata e puntuale informazione occorre sottolineare che non è richiesta, salvo rare eccezioni [10] , una forma ad substantiam: è pertanto sufficiente in linea teorica che sia l’informazione che il consenso venga prestato oralmente, purché in modo non equivoco. L’esecuzione della puntuale ed adeguata informazione e la prestazione del proprio consenso in forma orale appaiono tuttavia certamente sconsigliabili in considerazione della obiettiva difficoltà di provare l’esecuzione di tali adempimenti nell’ipotesi, oggi tutt’altro che rara, di successiva contestazione da parte dei pazienti.
Si è quindi opportunamente instaurata la prassi di far sottoscrivere al paziente un documento da cui risulti l’accettazione dell’atto medico: prassi di per sé sicuramente condivisibile anche se troppo spesso effettuata al solo scopo di garantire il medico provando la liceità del suo operato piuttosto che assicurare l’effettività dell’idonea informazione del paziente al trattamento.
OGGETTO DEL CONSENSO
L’oggetto del consenso informato è il trattamento medico.
Occorre innanzitutto rilevare che negli ultimi anni la ricerca giurisprudenziale ha profondamente innovato il rapporto medico-paziente, e il contenuto del consenso informato è divenuto un requisito fondamentale che può legittimare l’atto medico quando venga prestato da un paziente informato.
In particolare la concezione del consenso come consapevolezza da parte del paziente di subire l’attività del medico, ha lasciato spazio all’orientamento che ritiene che l’adeguata informazione del paziente costituisca il presupposto necessario per un valido consenso e che, in linea di principio, il consenso informato sia richiesto per qualunque atto medico.
Il consenso inoltre, per essere validamente prestato da parte del paziente e quindi IDONEO, dovrà essere specifico, occorrerà cioè che il paziente riceva una specifica informazione su quanto gli verrà praticato e ciò dovrà pervenirgli dallo stesso sanitario cui è richiesta la prestazione professionale.
Da parte sua il sanitario ha un preciso obbligo, quello di adoperarsi nella fase informativa con BUONA FEDE. Più precisamente, muovendo dal rilievo che tra medico e paziente intercorre un contratto di opera professionale, si è osservato che sul medico grava il dovere di informare la controparte delle circostanze rilevanti dell’atto curativo, “quale tipica espressione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella trattativa pre-contrattuale” così infatti dispone l’art 1337 c.c.
La Corte di Cassazione [11] ha poi chiarito cosa debba intendersi, nel caso specifico, per buona fede, asserendo che, negli interventi chirurgici, il dovere d’informazione concerne la portata dell’intervento, le inevitabili difficoltà che potranno essere incontrate nel corso della esecuzione dello stesso, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi; tutto ciò al fine preciso di porre il paziente nelle migliori condizioni per una libera decisione circa l’opportunità di sottoporsi all’operazione prospettatagli.
Tale obbligo informativo sarà altresì esteso anche ai rischi prevedibili, ma non anche ai possibili esiti anormali, al limite del fortuito e sarà poi il medico interessato che dovrà contemperare l’esigenza di informazione con la necessità di evitare che il paziente, per una qualsiasi remotissima possibilità, rinunci a sottoporsi anche ad interventi tra i più banali.
L’informazione per essere completa ed esaustiva dovrà evidenziare tutti quei rischi specifici che si presentano ogni volta si possa scegliere tra comportamenti alternativi, e dovrà altresì essere dal sanitario fornita in modo tale che il paziente sia posto in grado di effettuare la propria scelta con una cosciente valutazione dei rischi e dei corrispondenti vantaggi.
Occorrerà però secondo parte della dottrina contemperare i precedenti doveri in relazione al parametro (relativo) del bisogno di conoscenza espresso dal paziente in concreto, in vista della sua libera decisione di sottoporsi al trattamento medico [12] .
La dottrina è in tal proposito concorde nel ritenere che il medico sarà tenuto a fornire quel complesso di informazioni adeguate al livello culturale del paziente, necessarie affinché questi possa comprendere la situazione clinica e decidere consapevolmente, tenendo conto delle probabilità di successo della terapia, dei suoi coefficienti di rischio, delle terapie alternative, dell’invasività dell’intervento prospettato, del livello presumibile di sofferenza. Il livello d’informazione sarà quindi diverso a seconda che il paziente sia anch’esso un medico, un soggetto con scarse conoscenze mediche, ovvero un soggetto fortemente emotivo.
Ma se quanto appena sopra prospettato ha un fondamento logico-giuridico, innegabili appaiono, nella prassi, le obiettive difficoltà di un completo adeguamento da parte dei sanitari agli indicati principi e ciò in considerazione dell’innegabile necessità di standardizzare il più possibile i processi d’informazione e di raccolta del consenso.
Per contro certamente condivisibile è da ritenersi l’orientamento che ritiene che la completezza dell’informazione debba crescere in proporzione all’importanza dei beni coinvolti e dei coefficienti di rischio dell’atto medico [13] .
Un ulteriore elemento che deve contraddistinguere l’informazione prestata dal medico al paziente è quello della verità in relazione alla diagnosi ed alla prognosi che dovranno essere a quest’ultimo prospettate con realismo, ma non tale da sconvolgere e/o scoraggiare il paziente.
Da un lato vi sono principi legali e deontologici da rispettare quali l’obbligo di dire la verità e di fornire informazioni veritiere dall’altro quello di prevedere ed evitare sconvolgimenti emotivi che possano alterare oltre misura l’equilibrio psicologico del paziente.
Il medico infatti dovrà essere tenuto al rispetto di determinate modalità, idonee ad assicurare una decisione del paziente serena, poiché è assolutamente pacifico che un’informazione ed un consenso prestati in un frangente in cui il paziente versi in una condizione di notevole sofferenza avrebbero un significato obiettivamente relativo.
CASI PARTICOLARI RELATIVI ALLA VALIDITA’ DEL CONSENSO
Si è in precedenza affermato che un consenso informato possa essere considerato valido quando sia prestato da persona adulta, capace di intendere e volere.
Può accadere però che il soggetto giuridicamente capace di agire versi in condizioni psico-fisiche disagevoli, ad esempio a causa della malattia da cui è afflitto o a causa dei farmaci a lui somministrati, nel qual caso la validità del consenso sarà direttamente proporzionale alla capacità reale del paziente.
La soluzione prospettata dalla dottrina propende per una cosiddetta “valutazione in concreto”. Pertanto finché le capacità residue del paziente consentiranno l’effettuazione di una scelta terapeutica libera e consapevole, l’operato del medico sarà subordinato alle determinazioni del paziente, previo assolvimento da parte del medico dei doveri informativi necessari.
Ove invece il soggetto non sia in grado di effettuare una scelta terapeutica consapevole, e risulti indifferibile il trattamento medico, l’attività del sanitario prescinderà dal consenso informato, trovando legittimazione nei principi costituzionali di cosiddetta ispirazione solidaristica (tra cui l’art.2 costituzione).
1. Il primo caso particolare concerne l’ipotesi di un paziente che versi in condizioni di sofferenza tali da far attenuare o addirittura scemare la capacità di autodeterminazione terapeutica: in tale caso, tenendo conto della notevole sofferenza del malato, sarà sufficiente che il paziente acconsenta all’intervento terapeutico, requisito che può, nel caso di specie, ricavarsi già dal fatto di essersi recato SPONTANEAMENTE dal medico o dall’avere richiesto il suo intervento.
Spetterà quindi al sanitario, in mancanza di scelta terapeutica da parte del paziente, il compito di prendere la decisione circa la terapia da effettuare, mantenendo come fine precipuo quello della conservazione del bene vita a discapito di scelte meno dolorose ma più rischiose.
E’ proprio questo l’ambito applicativo in cui l’attività medica trova il suo fondamento, quello cioè della tutela della salute e, più in generale della vita umana.
Pertanto quando il medico debba agire per salvare il paziente che non possa prestare alcun valido consenso, dal pericolo attuale di un grave danno alla persona (art.54 c.p.) sarà esentato dall’obbligo informativo e dal connesso e successivo consenso.
Diversamente, nel caso in cui la sofferenza non sia tale da far diminuire in capo al paziente le facoltà di discernimento, il medico dovrà prestare l’attività d’informazione ed ottenere il consenso.
2. Vi è poi l’ipotesi della persona incapace interdetta, che trova la propria regolamentazione all’art. 424 del codice civile, ove è previsto che al soggetto interdetto per abituale infermità mentale provvede il tutore.
I confini assolutamente rigidi entro i quali viene connotata la delicata tematica relativa al malato mentale vanno altresì attenuati con quanto opportunamente previsto dal codice di deontologia medica dove, parallelamente alla disposizione del codice civile, si evidenzia al comma 3 dell’art. 34 che in capo al medico permane un obbligo di informazione nel confronti del paziente, sia esso infermo di mente.
In questo modo vengono maggiormente tutelati i diritti dell’incapace-persona, della cui volontà il medico dovrà tenere conto compatibilmente con la capacità di comprensione dello stesso.
3. Diametralmente opposta appare la fattispecie della persona incapace non interdetta, poiché la normativa non tiene conto della effettiva situazione di incapacità in cui versa il paziente.
La legge n.833 del 1978 infatti, porta ad equiparare, in tema di consenso all’atto medico, il malato mentale alla stessa stregua di un qualsiasi altro paziente.
In tale ipotesi il consenso informato del paziente quale atto di autorizzazione a porre in essere un determinato trattamento sul proprio corpo, espressione del più generale diritto all’autodeterminazione, risulterebbe inevitabilmente compromesso: verrebbe così a mancare il presupposto fondamentale, quello della capacità mentale.
Cercando di arginare la carenza normativa del caso di specie, la dottrina propende per la necessità del consenso informato nella misura in cui il paziente sia in grado di autodeterminarsi.
4. La fattispecie relativa alla capacità ed alla conseguente validità del consenso che ha maggiormente catalizzato la dottrina è quella concernente la legittimità dell’atto medico quando ha come destinatario un minore.
Il dati normativi da cui bisogna partire sono gli artt. 2 e 316 del codice civile dove stante l’incapacità del soggetto minore, il consenso informato dovrà essere espresso dal legale rappresentante, cui dovrà essere indirizzata l’attività medica informativa necessaria.
Il problema relativo al caso di specie si presenta in sede di determinazione dei limiti entro i quali il consenso del legale rappresentante può esprimersi, dato che risulterebbe alquanto problematico stabilire (ad esempio in caso di intervento che incida in maniera irreversibile su un diritto personalissimo, quale la sterilizzazione), se sia sufficiente il consenso dei genitori.
Alcuni autori evidenziano come l’istituto della rappresentanza legale del minore non trasferisca in capo al rappresentante l’incondizionato potere di disporre della salute del minore dato che la disponibilità della propria salute è un diritto personalissimo sul quale “gravano vincoli pubblicistici di indisponibilità, che valgono anche per il suo rappresentante legale” [14] .
Per questa ragione si registrano crescenti orientamenti volti ad una riqualificazione della condizione dei minori, tesa a valorizzarne l’autonomia e la consapevolezza: la condizione di incapace propria del minore non impedisce allo stesso di valorizzarne la naturale attitudine a gestire i propri rapporti personali.
Conformemente ai predetti orientamenti dottrinali, si è espressa la Convenzione Europea di Bioetica che all’art.6 recita testualmente “l’opinione del minore d’età dovrà essere tenuta in considerazione come un fattore sempre più determinante in proporzione alla età dello stesso ed al suo grado di maturità”.
E nella medesima direzione di pone il codice deontologico quando prevede che, anche nei confronti del minore, il medico informi il paziente e tenga conto della sua volontà sia pure nei limiti delle reali capacità del minore e sempre nel rispetto dei diritti del suo legale rappresentante.
Al legale rappresentante spetterà pertanto il compito di valutare il migliore interesse terapeutico nei confronti del minore, purché non incida pregiudizievolmente sul bene salute.
Nel qual caso, unitamente all’ipotesi in cui l’atto medico risulti necessario ed indifferibile per evitare un grave danno alla salute del minore, l’eventuale volontà contraria del legale rappresentante così come quella del minore saranno irrilevanti, prevalendo nel caso si specie il principio solidaristico che anima l’atto medico, ed il sanitario potrà intervenire al fine di evitare un grave rischio per la salute del paziente.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI ATTUALI
Negli ultimi anni la materia dei trattamenti sanitari e il relativo consenso informato all’atto medico è stato uno dei settori dove, in crescente misura, si sono concentrate le attenzioni e le riflessioni degli studiosi.
L’interesse, intorno al tema, è sicuramente frutto dell’intensa elaborazione giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, che viene ormai frequentemente investita di domande risarcitorie nei confronti degli operatori sanitari.
I fattori che hanno storicamente inciso sul tema sono di natura sociale e culturale. Infatti, il progresso medico e scientifico ha l’effetto di aumentare le aspettative da parte dei cittadini/pazienti che guardano all’atto medico con una sempre minore propensione ad accettare i margini di incertezza ad essa connessi.
Le decisioni del Supremo Collegio, confermano la tendenza piú rigida che la giurisprudenza, ormai da qualche anno, sembra aver assunto nel valutare la condotta professionale del medico, in particolare, nella sentenza n.364 del 15/01/1997 la Suprema Corte di Cassazione, condanna una struttura ospedaliera per violazione da parte di un medico, suo dipendente, del dovere di informare il paziente sui rischi inerenti ad un intervento.
L’interesse e, forse anche, la novità della decisione risiedono in ciò, che la Corte stabilisce, nei trattamenti chirurgici particolarmente articolati e complessi, che vengono condotti in équipe, l’obbligo di informazione, necessario per la validità del consenso del paziente, deve essere rispettato anche in relazione al singolo intervento e deve comprendere, laddove questo presenti un’autonomia gestionale e si possa scegliere tra una rosa di soluzioni alternative, l’indicazione degli specifici rischi delle singole soluzioni.
Nel caso di specie, la Suprema Corte afferma che “se potevasi presumere la necessità di essere sottoposti ad anestesia, non altrettanto potrebbe dirsi per la specifica metodologia adottata, mediante iniezione lombare, che comportava un rischio specifico” del quale il paziente doveva essere espressamente edotto.
La scelta di una tra le tecniche metodologiche possibili, nella fattispecie in esame anestetiche, comportando diversi fattori di rischio, avrebbe dovuto ottenere un valido e consapevole consenso del paziente.
Quello che preme sottolineare è l’estensione dell’obbligo d’informazione, ora ampliato anche ai rischi specifici rispetto alle scelte terapeutiche alternative, in modo che il paziente, con l’ausilio tecnico-scientifico del sanitario, possa determinarsi verso l’una o l’altra delle scelte possibili, attraverso una cosciente valutazione dei rischi relativi e dei corrispondenti vantaggi.
Del resto, sottolinea il Supremo Collegio “è noto che interventi particolarmente complessi, specie nel lavoro in équipe, ormai normale negli interventi chirurgici, presentino, nelle varie fasi, rischi specifici e distinti. Allorché tali fasi assumano una propria autonomia gestionale e diano luogo, esse stesse, a scelte operative diversificate, ognuna delle quali presenti rischi diversi, l’obbligo d’informazione si estende anche alle singole fasi ed ai rispettivi rischi”.
Sempre in tema di obblighi informativi in capo al sanitario, una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione Sez.III, 16/05/2000, n.6318, stabilisce che, al medico dipendente di una struttura ospedaliera, relativamente ai danni subiti da un neonato, partorito da donna della quale costui era medico di fiducia, per difetto di assistenza nelle varie fasi del parto, per quanto non possano essere a lui addebitate le carenze della struttura stessa, nè la condotta colposa di altri dipendenti dell’ospedale, a lui incombe, tuttavia, l’obbligo, derivante dal rapporto privatistico che lo lega alla paziente, di informarla della eventuale, anche solo contingente, inadeguatezza della struttura, tanto più se la scelta della stessa sia effettuata proprio in ragione dell’inserimento di quel medico in quella struttura, nonchè di prestare alla paziente ogni attenzione e cura che non siano assolutamente incompatibili con lo svolgimento delle proprie mansioni di pubblico dipendente. (Nella specie, la S.C. ha cassato, sul punto, la decisione della Corte di merito che, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, aveva escluso la responsabilità del medico di fiducia della partoriente nella causazione del danno neonatale sul rilievo che, avendo egli preso servizio poco prima dell’inizio del parto, non sarebbero stati a lui addebitabili nè i precedenti interventi di altri sanitari, del tutto inadeguati alla particolarità del parto a rischio, nè le carenze organizzative della struttura, e, in particolare la contingente indisponibilità del cardiotocografo da parte della stessa, senza indagare se detto medico di fiducia avrebbe dovuto, in ipotesi, sconsigliare il ricovero presso quell’ospedale in relazione a detta carenza, recarsi in ospedale anche fuori del proprio orario di servizio, chiedere di essere informato dell’inizio e del decorso del travaglio, od usare altre cautele).
L’importanza di tale pronuncia risiede nel fatto che la responsabilità e i doveri del medico non riguardano solo l’attività propria e dell’eventuale “equipe” che a lui risponda, ma si estende allo stato di efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui presta la sua attività, e si traduce in un ulteriore dovere di informazione del paziente.
Il consenso informato personale del paziente in vista di un intervento chirurgico o di altra terapia specialistica o accertamento diagnostico invasivi, non riguardano soltanto i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva e allo stato dell’arte della disciplina, ma riguardano anche la concreta, magari momentaneamente carente situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature, e al loro regolare funzionamento, in modo che il paziente possa non soltanto decidere se sottoporsi o meno all’intervento, ma anche se farlo in quella struttura ovvero chiedere di trasferirsi in un’altra.
L’omessa informazione sul punto può configurare una negligenza grave, della quale il medico risponderà in concorso con l’ospedale sul piano della responsabilità civile, quindi del risarcimento del danno, ed eventualmente anche sul piano professionale, deontologico – disciplinare.
Afferma inoltre la Suprema Corte che, benché manchi nella legislazione italiana uno standard di riferimento degli strumenti di cui una struttura sanitaria pubblica deve necessariamente disporre, ciò non esimerebbe il medico responsabile della cura dei pazienti dal dovere di informarli della possibile inadeguatezza della struttura per l’indisponibilità, anche solo momentanea, di strumenti essenziali per una corretta terapia o per un’adeguata prevenzione di possibili complicazioni, tanto più se queste siano prevedibili in relazione alla particolare vulnerabilità del prodotto del concepimento, specialmente se esso venga alla luce in condizioni di prematurità o immaturità.
Una ulteriore sentenza della Corte di Cassazione n.9705 del 6/10/1997 affronta una delle tematiche che negli ultimi anni è stata oggetto di parecchie pronunce giurisprudenziali ed altrettante rivisitazioni dottrinali, ossia quella relativa al consenso informato nella chirurgia estetica.
Come in precedenza accennato, già nel 1985, con la sentenza n.4394 la Suprema Corte sottolineava che il dovere informativo in capo al sanitario era particolarmente incombente nella chirurgia estetica, in cui dovevasi ricomprendere anche la possibilità da parte del paziente di conseguire un effettivo miglioramento dell’aspetto fisico, che si sarebbe ripercosso favorevolmente nella vita professionale ed in quella di relazione.
Le difficoltà connesse all’adattamento rigido della distinzione tradizionale tra obbligazioni “di mezzi” e obbligazioni di “risultato”, si avvertono forse con maggiore intensità quando si pone attenzione alla particolare cura che la giurisprudenza ha riservato a particolari ipotesi di responsabilità professionali sanitarie.
Nella fattispecie relativa alla chirurgia estetica, essendo l’intervento orientato a perseguire un risultato estetico migliorativo, viene posto l’accento sul fatto che la mancata informazione sulla qualità dei risultati prevedibili integri una responsabilità del medico tutte le volte in cui l’esito dell’intervento non corrisponda a quello atteso o promesso, configurando in capo al sanitario una obbligazione “di risultato”.
Nel caso di specie, la Suprema Corte afferma che dalla peculiare natura del trattamento sanitario volontario scaturisce, al fine di una valida manifestazione di consenso da parte del paziente, la necessità che il professionista lo informi dei benefici, delle modalità di intervento, dell’eventuale possibilità di scelta tra diverse tecniche operatorie e, infine, dei rischi prevedibili in sede post operatoria, necessità, quest’ultima, da ritenersi particolarmente pregnante nel campo della chirurgia estetica (ove è richiesta la sussistenza di concrete possibilità, per il paziente, di conseguire un effettivo miglioramento dell’aspetto fisico che si ripercuota favorevolmente sulla sua vita professionale o di relazione), con la conseguenza che la omissione di tale dovere di informazione genera, in capo al medico, nel caso di verificazione dell’evento dannoso, una duplice forma di responsabilità, tanto contrattuale quanto aquiliana. Anche gli stessi e gravi esiti cicatriziali residuati all’intervento di chirurgia estetica eseguito in violazione del dovere di informazione da parte del sanitario possono integrare gli estremi della “alterazione anatomo-patologica dell’organismo” e, conseguentemente, l’elemento oggettivo del reato di lesioni colpose (al cui accertamento il giudice civile sia chiamato “incidenter tantum”, onde statuire sulla risarcibilità del danno morale), allorquando tali esiti non siano riferibili ad interventi in cui le possibilità di simili conseguenze dannose erano già state preventivamente ed esaurientemente rappresentate al paziente dall’operatore.
Alcuni autorevoli autori [15] alla luce degli orientamenti giurisprudenziali hanno criticato la differenziazione tra sanitari in genere ed i chirurghi estetici poiché non sarebbe corretto sostenere che, a fronte di una diligente prestazione del chirurgo, debbano conseguentemente conseguirsi risultati estetici soddisfacenti, ben potendosi produrre risultati di segno opposto, o comunque non soddisfacenti, legati a fattori fisiologici o patologici peculiari al paziente, non sempre prevedibili.
Pertanto risulterebbe eccessivamente penalizzante per il chirurgo estetico valutare la propria responsabilità secondo i canoni relativi alle obbligazioni “di risultato”, piuttosto che puntare l’attenzione sul diligente adempimento del dovere d’informazione del paziente, gravante sul chirurgo estetico, come sugli altri sanitari; dovere d’informazione ancor più fondamentale in questa specialità al fine di determinare le condizioni ideali per una partecipazione cosciente ed attiva del paziente nonché per la prestazione di un consenso all’intervento altrettanto pieno e cosciente.
Sembra in effetti più corretto secondo parte della dottrina, spostare l’attenzione dal piano dell’identificazione della natura dell’obbligazione, ovvero tra obbligazioni “di risultato” e quelle “di mezzi”, ad un piano diverso che privilegi la fase della definizione e di approfondita informazione del contenuto della prestazione del chirurgo estetico, data la particolare delicatezza che in questa specialità assume anche la prestazione del consenso da parte del paziente.
Si tratterebbe quindi di dar corso ad una sorta di vera e propria contrattualizzazione della prestazione, disegnandone i confini, gli obiettivi e le modalità esecutive e quindi, conseguentemente, i limiti di responsabilità.
Come già accennato, nell’ambito della chirurgia estetica, particolare attenzione deve essere data all’obbligo informativo.
Si sostiene che l’obbligo informativo nella chirurgia estetica sia da espletarsi in modo più ampio di quanto non succeda nella chirurgia riabilitativa, poiché sarebbe diverso il rapporto intercorrente tra cliente e terapeuta da quello tra cliente e chirurgo estetico.
Nel primo caso si perseguirebbe infatti la guarigione da un’infermità, nel secondo caso l’intervento sarebbe finalizzato ad un miglioramento dell’aspetto fisico in vista di un migliore presentarsi nella vita di relazione.
Alla luce di queste considerazioni, e sulla base di quanto disposto dal Tribunale di Roma il 10 ottobre 1992 [16] , vi sarebbe una diversificazione del dovere d’informazione, “limitato in genere, per il terapeuta, ai possibili rischi ed effetti della terapia suggerita o degli interventi chirurgici proposti (…) e quello, invece, gravante sul chirurgo estetico in ordine alla conseguibilità di un miglioramento effettivo dell’aspetto fisico”.
La sopraesposta circostanza, tuttavia, è stata oggetto, da parte della dottrina di alcune critiche per il fatto che discriminare la specialità in esame sostenendo la necessità di valutare più rigorosamente la fase dell’informazione e della prestazione del consenso, significherebbe introdurre, all’interno della scienza medica, una differenziazione che non trova specifiche ragioni deontologiche per essere sostenuta.
Occorre infine accennare la sentenza n.3046 dell’ 8 aprile 1997 con cui la Corte di Cassazione effettua un’ulteriore differenziazione all’interno della categoria stessa delle prestazioni poste in essere dal chirurgo estetico, ossia quella tra interventi di chirurgia estetica “ordinari”, ed interventi di chirurgia estetica cosiddetti “ricostruttivi”. Questi ultimi sarebbero interventi riferibili a casi, come quello trattato dalla sopraccitata sentenza, nei quali sia stato il paziente stesso a procurarsi volontariamente alcune alterazioni, nel caso di specie tatuaggi osceni e ripugnanti, per poi volerne conseguire l’eliminazione. Di fronte a casi simili il contenuto dell’obbligo d’informazione sarebbe diverso rispetto a quello richiesto, al contrario, nei casi di chirurgia estetica cosiddetta ordinaria, dovendosi nel primo caso adempiere all’obbligo d’informazione del paziente in modo meno rigoroso e limitato agli esiti eventuali che potrebbero rendere vana l’operazione, e non dovendo il medico spingersi oltre nell’informazione diligente al paziente.
Se negli ultimi anni dottrina e giurisprudenza hanno delineato i principi generali relativi alla tematica del consenso informato, occorre anche rilevare che non poche problematiche restano ancora irrisolte.
Ad esempio quella relativa ad un modello generale di consenso informato, che risulta obiettivamente di difficile applicazione in ogni particolare relazione medico-paziente, troppo spesso influenzata da fattori personali quali emotività e condizione psicologica.
Sarà perciò fondamentale l’apporto di studiosi e giuristi, nell’ottica di “riuscire a sviluppare le potenzialità positive dell’idea di autodeterminazione in campo sanitario, riducendo al minimo gli effetti indesiderati, secondo un’ispirazione che non disgiunga libertà ed uguaglianza” [17] .
AVV.MARCO EMANUELE GALANTI
[1] Tra gli altri è il caso delle malattie infettive e diffusive di cui all’art.253 T.U. leggi sanitarie 27/3/1934 n.1265 e D.M. 5/7/1975
[2] SANTOSUOSSO, Il consenso informato. Tra giustificazione per il medico e diritto del paziente, Milano, 1996.
[3] LEGA, Il dovere del medico di informare il paziente, Riv.Dir.Lav., 1960, 222.
[4] SANTOSUOSSO, op.cit. pag. 6 “Gli Stati Uniti sono considerati il luogo d’origine del consenso informato. Quest’idea trae origine non certo dal fatto che essi siano l’unico paese nel quale si sia posto il problema della regolamentazione giuridica dell’attività medica ma dal fatto che, proprio negli Stati Uniti, questa particolare forma giuridica ha preso corpo e ha assunto la forma che ora tende ad affermarsi anche in altri paesi, come in Inghilterra o qui da noi”
[5] GORGONI, La stagione del consenso e dell’informazione, Responsabilità civile e previdenza, 1999, 488
[6] MARTORANA, Considerazioni su informazione del paziente e responsabilità medica, Resp.civ e prev. 1997, 1228
[7] MARTORANA, Op.cit.
[8] RIZ, Il consenso dell’avente diritto, Padova, 1979; NANNINI, il consenso dell’avente diritto, Milano, 1989; BONELLI – GIANNELLI, Consenso e attività medico-chirurgica, Riv.It.Med.Leg., 1991, 9 ss.
[9] Consiglio Nazionale per la Bioetica, 1992, 20 giugno.
[10] Ad esempio il caso delle donazioni sanguinee dove, al donatore, viene richiesto consenso informato scritto. Così infatti prevede il Decreto del 15 gennaio 1991, in Gazzetta Ufficiale 24/1/1991
[11] Cass. 25 novembre 1994, n.10014.
[12] SERRA, Fisiopatologia del rapporto medico-paziente in ginecologia, Milano, 2000; GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali e implicazioni penalistiche, Firenze, 2000.
[13] POLVANI, Indicazioni giurisprudenziali e considerazioni critiche sul consenso all’attività medica, Foto It., 1996.
[14] GIUNTA, Op. Cit.
[15] BILANCETTI, La responsabilità civile e penale del medico, Padova, 1996; FERRANDO, Consenso informato del paziente e responsabilità del medico, principi, problemi e linee di tendenza, Riv. Critica Dir.Priv., 1998.
[16] Tribunale di Roma 10 ottobre 1992, In Assicurazioni, 1993, II, 207; in Giur. It. 1993, I, 2, 234.
[17] Santosuosso, Op.Cit. pag. 222.