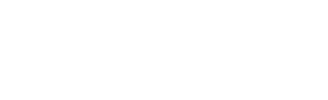[Febbraio 2003] - Concorrenza sleale e patto di non concorrenza
La Sezione I della Corte di Cassazione è di recente tornata ad esprimersi sul delicato tema della concorrenza sleale e dell’uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale con la sentenza n. 14479 del 11 ottobre 2002.
Per meglio comprendere la portata ed il significato di tale decisione è opportuno, in primo luogo, muovere da un esame, seppur sintetico, delle modalità in cui libertà ed obblighi operano nei diversi ambiti economici. Concorrenza sleale e patti di non concorrenza verranno, dunque, qui di seguito considerati quali fattori operanti nell’assetto del libero mercato (rapporti tra le imprese) e del lavoro subordinato.
Nel campo delle imprese, la libera concorrenza non è soltanto consentita, bensì auspicata e promossa, ed è dall’ordinamento difesa e tutelata. Tale tutela è confermata dai divieti sanciti dalla legge in tema di intese tra imprenditori finalizzate a restringere o a falsare la reale concorrenza, ovvero in tema di abuso di posizione dominante, o, ancora, in tema di ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento (articoli 2 e 3 della legge 287/90, “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) .
Quelle che la legge consente e tutela sono, tuttavia, solo le forme di concorrenza conformi ai principi di correttezza professionale. L’art. 2598 del Codice civile vieta, infatti, il compimento di atti di concorrenza cosiddetta sleale, quali l’utilizzo del nome o di altri segni distintivi propri dell’impresa altrui, ovvero la diffusione di notizie e apprezzamenti denigratori sui prodotti o sull’attività di un concorrente, o, ancora, l’appropriazione dei pregi di prodotti o di imprese concorrenti. Chiude la norma, infine, una previsione generale che sancisce l’illegittimità di ogni ulteriore e diversa modalità non conforme ai principi di correttezza professionale ed idonea a danneggiare l’altrui azienda.
Tra gli imprenditori è poi possibile pattuire vincoli più penetranti alla libera reciproca concorrenza prevista e tutelata dall’ordinamento. Seppur entro i limiti sanciti dalla normativa antitrust e dall’art. 2596 del Codice civile, alle previsioni di legge brevemente illustrate si aggiunge, in tal caso, la possibilità di prevedere un patto di non concorrenza. Tale patto non può tuttavia eccedere la durata di cinque anni (un accordo che prevedesse una durata superiore avrebbe comunque efficacia vincolante solo per il quinquennio consentito dalla legge). Il patto deve inoltre contenere limitazioni in ordine all’ambito territoriale di validità dello stesso, ovvero alla tipologia e ai contenuti dell’attività inibita (tali limiti sono previsti come alternativi tra loro). Non è richiesta la forma scritta ai fini della validità del patto tra le imprese (tale forma è, infatti, richiesta solo ad probationem), né è previsto un corrispettivo in favore dell’imprenditore obbligato.
Nell’ambito del lavoro subordinato, al contrario, vige un regime di divieto di concorrenza contenuto in tutti i contratti. L’obbligo in capo al lavoratore dipendente di non compiere atti di concorrenza ai danni del proprio datore di lavoro in costanza di rapporto discende direttamente dalla legge. L’art. 2105 del Codice civile vieta, infatti, al dipendente di “trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore”, di “divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”. Le attività vietate al lavoratore subordinato vanno ben oltre quelle qualificate come illecite dall’art. 2598 del Codice civile, brevemente esaminato a proposito delle imprese, fino a comprendere qualsiasi tipo di attività concorrenziale.
La ragione di un tale assetto sta nel fatto che il prestatore di lavoro, essendo inserito nell’organizzazione aziendale, sarebbe in grado di rendere la propria attività competitiva particolarmente insidiosa, proprio a causa della diretta conoscenza che egli ha del contesto e delle vicende dell’impresa.
Il divieto assoluto di concorrenza previsto dalla legge è, proprio per l’argomento sopra esposto, strettamente connesso alla sussistenza del rapporto di lavoro. Con il cessare di questo, quindi, il dipendente riacquista la libertà di svolgere qualunque attività, anche in concorrenza con quella svolta dal suo precedente datore di lavoro, salva la previsione di un patto di non concorrenza post-contrattuale.
L’art. 2125 del Codice civile disciplina infatti l’ipotesi in cui il datore di lavoro voglia tutelarsi anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo la possibilità di stipulare con il lavoratore un apposito patto di non concorrenza, in forza del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di denaro al lavoratore e questi, a sua volta, si obbliga a non svolgere attività concorrenziale con quella del proprio datore una volta cessato il rapporto.
Il patto di non concorrenza può essere perfezionato sia all’atto della stipula del contratto di lavoro, sia nel corso del rapporto, sia, infine, al momento della sua cessazione. Il patto di non concorrenza deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto (tale forma è qui prevista ad substantiam) e prevedere un corrispettivo in favore del lavoratore (nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia irrisorio o troppo modesto rispetto al sacrificio imposto al lavoratore il patto sarà comunque nullo). Devono, inoltre, sempre a pena di nullità, essere indicati limiti di oggetto, di tempo e di luogo, previsti non come alternativi tra loro. La durata massima del patto di non concorrenza è stabilita dalla legge in cinque anni per i dirigenti ed in tre per gli altri prestatori di lavoro (quadri, impiegati e operai). Nel caso in cui venga pattuita una durata maggiore, o non sia stabilita affatto, questa si intende fissata nella misura prevista dalla legge.
In sintesi, dunque:
imprese – libera concorrenza è sempre promossa e tutelata, purché sia conforme
ai principi di correttezza professionale.
Quindi c’è piena libertà salvo che si configurino ipotesi di concorrenza sleale, vietata dall’art.2598 c.c e salvo eventuale patto di non concorrenza (patto negoziale di limitazione della concorrenza, disciplinato dall’art. 2596 c. c.);
lavoro subordinato durante rapporto = vincoli (obblighi di fedeltà ex art. 2105 c.c.);
dopo scioglimento = libertà, salvo eventuale patto di non concorrenza disciplinato dall’art. 2125 c.c.
La sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, n. 14479 del 11/10/2002, dalla quale siamo partiti per questo breve excursus sulle libertà e sui divieti in tema di concorrenza,
ha affrontato la questione della configurabilità di un’ipotesi di concorrenza parassitaria (2598 n.3, c.c.) in capo al datore di lavoro che si avvalga di un ex dipendente di altra impresa concorrente. Il caso in esame riguarda, dunque, l’utilizzazione da parte del prestatore di lavoro della professionalità acquisita alle dipendenze del precedente datore di lavoro e la eventualità che ciò configuri un’ipotesi di concorrenza parassitaria del nuovo datore di lavoro concorrente. La Suprema Corte fa comunque salva la possibilità, da parte del dipendente, di spendere quel valore aziendale unicamente costituito dalle proprie capacità professionali, e non distinguibili dalla sua persona.
Il punto è quindi quello di individuare l’ambito di liceità all’interno del quale può legittimamente operarsi in regime di libera concorrenza (ambito in cui varranno le regole della correttezza professionale e del buon costume commerciale), la cui linea di confine può essere individuata nel divieto, che deriva direttamente dalla legge (art. 2598 n. 3 c.c.), di compiere atti volti a sviare a proprio vantaggio i valori aziendali di altre imprese operanti nello stesso settore (c. d. concorrenza parassitaria).
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto, con la sentenza ancora oggi non pubblicata, che “non può considerarsi illecita l’utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiché si perverrebbe altrimenti al risultato, duplicemente inammissibile, di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell’impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, della scelta felicemente a suo tempo fatta con l’assunzione di quel dipendente”.
In questo modo la Cassazione, seppur ricorrendo a concetti di non facile ed immediata individuazione, quale quello delle “capacità professionali non distinguibili dalla persona”, sembra aver confermato precedenti orientamenti giurisprudenziali in tema. Parrebbe così recepito l’orientamento decisamente cauto ed equilibrato, in base al quale “/…/ la tutela dell’imprenditore /…/ non può giungere ad impedire o limitare la facoltà di sfruttamento da parte dell’ex dipendente o collaboratore delle conoscenze acquisite nella propria pregressa esperienza lavorativa, o la libertà di avvalersi della propria capacità tecnica, pur se acquisita nell’esplicazione di mansioni alle quali esso era addetto nell’impresa” (Trib. Verona, 23/07/1998); e, per quanto riguarda la posizione del prestatore di lavoro, “non compie un atto di concorrenza sleale l’ex dipendente che, compatibilmente con la tutela dei segreti aziendali, utilizzi a proprio profitto il bagaglio di esperienze e cognizioni acquisite presso altri, comprese quelle attinenti il mercato e il rapporto con la clientela” (Trib. Cagliari, 21/11/1994).
STUDIO LEGALE GGM