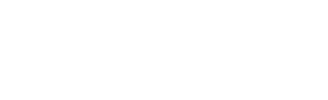[Settembre 2003] - Risarcibilità dei danni derivanti dallo sconvolgimento della vita famigliare
Con due importantissime sentenze, La Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la problematica, sino ad oggi ampiamente dibattuta, della risarcibilità dei danni non patrimoniali.
Le vicende che hanno originato queste due decisioni, sebbene tra loro differenti, hanno avuto un medesimo denominatore comune, ovvero quello della risarcibilità degli effetti prodotti da alcuni tragici eventi sulla normale vita familiare, in quanto causa di uno sconvolgimento delle abitudini di vita.
Le due decisioni della Corte, rispettivamente n.8827/2003 e n.8828/2003, hanno di fatto superato il rigido schema del risarcimento del danno non patrimoniale subordinato all’art.185 c.p. che, come noto, sancisce la riscarcibilità del danno conseguente a reato.
Come è noto, l’art.29 della Costituzione sancisce e riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, da intendersi, nei casi di specie, come diritto alla realizzazione della vita stessa dell’individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti ispirati dal rapporto parentale, ove, pur generando bisogni e doveri, danno luogo a gratificazioni, supporti, affrancazione e significati.
L’alterazione di questi particolarissimi e personalissimi rapporti positivi, derivanti dal più generale rapporto parentale, determinerebbe questa particolare fattispecie di danno non patrimoniale, consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita, risarcibile ex art. 2059 c.c. poiché lesione di un interesse costituzionalmente protetto.
Ebbene nella richiesta risarcitoria promossa dai congiunti di una persona deceduta a seguito di sinistro stradale, sfociata nella sentenza 7-31 maggio 2003 n.8828, lo sconvolgimento è rappresentato dall’estinzione del rapporto parentale con i congiunti e dalla lesione della sfera degli affetti reciproci e della famiglia. In questa pronuncia la Corte ha opportunamente sottolineato che la lesione che si vuole risanare è quella relativa alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, lesione differente sia da quella al bene salute (risarcibile con il danno biologico) che da quella all’integrità morale da ingiusta sofferenza (risarcibile con il danno morale soggettivo).
Detta lesione si concreta, nel caso in esame, nella irreversibile perdita del godimento del congiunto, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali nell’ambito del nucleo familiare.
Perdite e preclusioni che sono diretta conseguenza della lesione di un interesse protetto.
Per quanto concerne la prova del danno, la Suprema Corte ha evidenziato che detta tipologia di danno non patrimoniale non è in re ipsa, ovvero coincidente con la lesione dell’interesse, dovrà invece essere adeguatamente provato. Si dovrà perciò avere riguardo, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente protratto il godimento del congiunto, anche mediante valutazioni prognostiche e presuntive, sulla base degli elementi che dovrà fornire il danneggiato.
In ordine, infine, alla liquidazione di detta tipologia di danno non patrimoniale, trattandosi di lesione di valori inerenti alla persona, la stessa dovrà unicamente avvenire in base ad una valutazione equitativa, sulla base di parametri quali l’intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza (più o meno ampia) del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti.
Con la sentenza 7-31 maggio 2003 n.8827, relativa ai gravi ed irreversibili danni riportati da un neonato all’atto della nascita, tali da costringere lo stesso ad una vita vegetativa, la Suprema Corte ha ripreso i principi sopra enunciati stabilendo che, quando un fatto lesivo altera l’assetto su cui si fonda il nucleo familiare (fatto di bisogni e doveri ma anche di significati e gratificazioni) lo sconvolgimento che inevitabilmente scaturisce nelle abitudini di vita deve essere risarcito.
Nel caso di specie, le gravi lesione subite al momento della nascita dal bambino hanno determinato una vita vegetativa dello stesso, che ha inevitabilmente determinato il più totale sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative dei genitori stessi, con l’ulteriore conseguenza di dover costantemente e perennemente provvedere alle esigenze del figlio stesso.
Questa “riduzione delle positività derivanti dal rapporto parentale”, osserva la Corte, trova tutela nell’articolo 29 della Costituzione che riconosce i diritti della famiglia e detto danno non patrimoniale deve pertanto essere risarcito ex art. 2059 cod. civ.
Al riguardo è bene precisare che la Suprema Corte, con le decisioni in esame (n.8827/03 e n.8828/03), ha affermato che il danno da sconvolgimento della vita costituisce un’autonoma lesione, ontologicamente differente dal danno biologico, dal danno patrimoniale e da quello morale (vd. anche Trib. Torino 8 agosto 1995, C.App.Torino, 4 ottobre 2001, n. 1285).
Tuttavia, il ricorso ad una autonoma voce di danno “non deve significare incremento generalizzato delle poste di danno, ma mezzo per colmare le lacune dell’ordinamento nella tutela risarcitoria della persona” .
Pertanto, come già accennato, la liquidazione del danno non patrimoniale dovrà avvenire sulla base di una valutazione equitativa, tuttavia tenendo conto di quanto liquidato a titolo di danno morale soggettivo, al fine di evitare una duplicazione delle poste di danno e dei connessi risarcimenti.
Al riguardo non si può non rilevare una certa contradditorietà nei principi enunciati dalle sentenze in esame.
Infatti se da un lato viene affermata con chiarezza una sostanziale autonomia del danno da “sconvolgimento della vita familiare”, dall’altro, detta autonomia, viene sensibilmente ridotta in quanto, sotto l’aspetto liquidatorio, la nuova tipologia di danno viene correlata all’entità del danno morale.
La soluzione, così come prospettata, pare essere il frutto di un compromesso. Si riconosce, quindi, un’autonoma categoria di danno, dai confini obbiettivamente incerti, ma nello stesso tempo si cerca in qualche modo di ridurre gli impatti risarcitori della stessa.
Milano, 04.09.2003