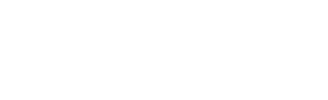[Aprile 2004] - L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro nel decreto legislativo n°276
In attuazione dell’articolo 5 della legge delega n. 30 del 2003, con il titolo VIII (capo I, articoli da 75 a 82 e capo II, articoli 83 e 84) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 è stata introdotta nel nostro ordinamento la disciplina dell’istituto della certificazione dei contratti di lavoro.
Tale istituto, in base alla previsione dell’articolo 5, comma 1, lett. a) e i) della legge delega, ha carattere sperimentale. Dopo 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo (ossia dal 24 ottobre 2003) è, infatti, prevista una verifica dell’attuazione delle disposizioni disciplinanti l’istituto in esame da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La relativa procedura, “al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro” (art. 75, ma sul punto torneremo nel prosieguo del presente lavoro), avrà una doppia funzione: da un lato, fornire assistenza alle parti in ordine alla predisposizione delle clausole presenti nell’accordo contrattuale, facilitando le stesse nel concordare il programma negoziale (art. 81: “Le sedi di certificazione /…/ svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali /…/”); dall’altro, fissare la qualificazione giuridica del contratto concluso dalle parti (art. 75, art. 78).
Fin dalla lettura della prima disposizione dell’istituto in esame emerge chiaramente il carattere volontario della procedura di certificazione (“le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo”, art. 75), carattere che viene ribadito anche in successive disposizioni (“La procedura di certificazione è volontaria…”, art. 78, comma 1).
Al riguardo, è stato fin da subito sottolineato il rischio che non sia sufficiente la mera previsione formale della volontarietà della procedura perché venga effettivamente garantita la libertà decisionale del lavoratore. Una parte dei primi commentatori denuncia addirittura il rischio che il carattere volontario della procedura sia, in realtà, un requisito meramente formale, “atteso che maggior interesse alla certificazione lo ha indubbiamente il datore di lavoro, intenzionato a non correre rischi per il futuro, ove dovesse ricorrere a soluzioni negoziali che possano facilmente debordare nella subordinazione”[1]
Di qui, l’auspicio che gli organi competenti, al fine di un effettivo rispetto del presupposto della volontarietà, non si limitino a richiedere la sussistenza di una comune istanza di avvio della procedura di certificazione (requisito, come vedremo oltre, imprescindibile per l’avvio della procedura certificatoria), ma verifichino la presenza di una effettiva libertà di scelta dei soggetti coinvolti. In questo senso, sarà importante che la parte debole del rapporto possa accedere a (e, quindi, disporre di) tutte le informazioni utili ai fini dell’adozione della propria decisione.
Proseguendo nella lettura dell’articolo 75, viene delineato il campo di applicazione dell’istituto: è infatti previsto che si possa attivare la procedura di certificazione solo in caso di scelta di una delle tipologie contrattuali introdotte ex novo o modificate dal decreto stesso, ossia il lavoro intermittente o a chiamata (c.d. job on call), il lavoro a prestazioni ripartite (c.d. job sharing), il lavoro a progetto, il lavoro a tempo parziale, nonché il contratto di associazione in partecipazione ex articoli 2549-2554 c.c. (art. 75)[2]. Infine, l’articolo 84 prevede la possibilità di ricorrere all’istituto della certificazione anche in sede di stipulazione del contratto di appalto di cui all’art. 1655 c.c. e nelle fasi di attuazione del relativo programma, “anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto”.
Non è mancato chi, tra i primi commentatori della riforma, aveva intuito un raccordo tra l’istituto della certificazione, previsto dall’articolo 5 della legga delega, e la creazione di nuove figure contrattuali, previste dall’articolo 4 della stessa legge[3]
La lettura combinata delle due norme aveva, infatti, condotto parte della dottrina a porre l’attenzione sulle potenzialità della certificazione intesa come strumento di legittimazione delle nuove figure negoziali “atipiche”, con l’effetto di garantire maggior certezza alle qualificazioni convenzionali ratificate dai soggetti abilitati, mettendole tendenzialmente al riparo da eventuali successive contestazioni.
Sempre in tema di campo di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto n. 276/03, così come già stabilito dagli articoli 5 e 6 della legge delega n. 30/03, la procedura della certificazione non si applica alle Pubbliche Amministrazioni e al loro personale[4].
L’esclusione stabilita dal Legislatore non pare del tutto in linea con un utilizzo sempre maggiore di rapporti di lavoro di origine privatistica presso le Pubbliche Amministrazioni[5], e di certo non facilita il processo di armonizzazione tra settore pubblico e settore privato nel mondo del lavoro. Come è stato, infatti, osservato, la riproduzione di ordinamenti speciali non giova alla costituzione di un sistema orientato a realizzare un medesimo livello di tutela sociale[6].
A questo si aggiunge, secondo parte della dottrina, la dubbia costituzionalità da un lato dell’esclusione del datore di lavoro pubblico dall’applicazione delle nuove regole di applicazione volontaria in materia di assistenza e consulenza giuslavortistica, e, dall’altro, l’esclusione dei lavoratori pubblici dal raggio di azione di alcune tutele legislative.
Proseguendo nell’analisi testuale delle disposizioni dedicate all’istituto in esame, l’articolo 76 individua gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro in “Commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale, quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; b) le Direzioni provinciali del lavoro e le Province, secondo quanto stabilito da apposito decreto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto; c) le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie /…./ esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo /…/” (art. 76, comma 1).
Per una maggiore comprensione di cosa il Legislatore delegato intenda per “enti bilaterali”, si riporta la definizione fornita dal decreto stesso, secondo la quale questi sono “organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l’inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità retributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento” (art. 2, comma 1, lett. h).
Per quanto riguarda le commissioni di certificazione istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro e le Province, si sottolinea che il decreto ministeriale in base al quale le stesse devono essere individuate non è ancora stato emanato, nonostante il termine previsto di sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 276/2003, sia scaduto già da diverso tempo. Su tale identificazione sono state, inoltre, avanzate molte riserve, dal momento che, in questo modo, la funzione certificatoria verrebbe attribuita a soggetti già sovraccarichi di lavoro, con il rischio, quindi, di vanificare le intenzioni del legislatore.
Lo stesso ordine di critiche è stato mosso in merito alle Università, dove il numero dei docenti è spesso insufficiente a garantire una proficua didattica. A questo si aggiunga che diversi professori universitari svolgono già, oltre all’insegnamento, un’autonoma attività professionale, con il rischio, paventato da alcuni commentatori, di porre in essere un conflitto di interessi.
Sempre in tema di università, inoltre, in base al secondo comma dell’articolo 76 “per essere abilitate alla certificazione, le Università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con apposito decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”. In questo caso, però, non soltanto il decreto istitutivo dell’albo delle università abilitate non è stato ancora emanato, ma il testo della norma non specifica nemmeno il termine entro il quale ciò debba avvenire.
È stata, inoltre, posta una condizione per le Università che vogliano ottenere la funzione certificatoria: è infatti previsto che, “per ottenere la registrazione, le Università sono tenute ad inviare, all’atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro, con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” (art. 76, comma 2).
Tale previsione è stata oggetto di ulteriori critiche, inerenti il rischio che ciò si traduca nella produzione di una spropositata quantità di scritti che per essere seriamente e utilmente vagliata richiederebbe la dedizione a tempo pieno di uno staff di studiosi all’interno del ministero. Questa notevole mole di informazioni dovrebbe essere, inoltre, utilizzata dal ministero stesso per elaborare periodicamente i “codici di buone pratiche”, previsti dall’articolo 78, comma 4 (ma sul punto torneremo nel prosieguo).
Il terzo ed ultimo comma dell’articolo 76 prevede, infine, che “le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione”. In questo senso, è stata accolta l’istanza di parte della dottrina che, all’indomani della legge delega, auspicava l’istituzione di un unico soggetto certificatorio, idoneo ad assolvere tutte le funzioni previste dalla riforma. Tale possibilità dovrebbe, infatti, fornire maggiori garanzie di adeguatezza rispetto ai compiti attribuiti agli organi certificatori, i quali presuppongono sia una rigorosa padronanza della tecnica giuridica, sia l’attitudine a percepire i reali interessi sottesi al singolo caso concreto.
L’articolo 77 disciplina la competenza territoriale dei diversi organi certificatori, stabilendo che, nel caso in cui le parti dovessero optare per le Direzioni Provinciali del Lavoro o per le Province, dovranno rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza nella quale sarà impiegato il lavoratore titolare del contratto da certificare.
Nel caso in cui, invece, le parti volessero rivolgersi alla Commissione istituita presso gli enti bilaterali, si dovrà fare riferimento a quella costituita dalle rispettive associazioni sindacali del datore e del prestatore di lavoro. Nessun vincolo territoriale è stabilito, invece, con riferimento alle Università. Nulla viene, però, stabilito nel caso in cui le parti si rivolgano ad una commissione che, ai sensi dell’articolo 77, non sia competente.
L’articolo 78 disciplina il procedimento di certificazione. Il primo comma ribadisce il carattere volontario della procedura, stabilendo che la stessa consegue obbligatoriamente ad un’istanza scritta comune delle parti del contratto.
Il secondo comma dell’articolo 78 prevede che le procedure in esame sono determinate dalle commissioni di certificazione all’atto della loro costituzione e, “si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4 /…/”. Il successivo comma 4 concede al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ben sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 276/2003 (la scadenza è, dunque, prossima, ossia il 24 aprile) per adottare “con proprio decreto codici di buone pratiche per l’individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi /…/”. Come sopra accennato, all’aggiornamento periodico di tali moduli concorreranno senz’altro, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, anche gli elaborati e gli studi che le Università abilitate alla certificazione sono tenute ad inviare al Ministero ogni sei mesi. A tali codici dovranno fare riferimento gli organi certificatori per dedurre le clausole dello schema contrattuale oggetto di certificazione.
Sempre in base all’articolo 78, comma 4, tali codici dovranno recepire, “ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”[7]. Nella loro funzione di assistenza alle parti del contratto, sarà compito delle commissioni individuare quali, tra le clausole indisponibili (legali o collettive) previste dai codici di buone pratiche, possono essere dedotte nel contratto individuale. Ad oggi, dunque, ancora mancano i principali criteri di riferimento cui la procedura di certificazione dovrà informarsi.
Vediamo, adesso, i criteri espressamente indicati dal decreto n. 276/2003 in merito alla procedura certificatoria. In primo luogo, l’inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione Provinciale del lavoro (ovviamente, questo nel caso in cui le parti non si siano rivolte alla commissione istituita presso la D.p.l stessa), la quale ha l’obbligo di provvedere a comunicare l’avvio della procedura a tutte le autorità pubbliche che subiranno gli effetti (civili, previdenziali o fiscali) dell’atto certificato. Tali autorità hanno la facoltà di presentare osservazioni alla commissione certificatoria (art. 78, comma 2, lett. a; la norma, però, non precisa il termine, come vedremo al punto successivo, sicuramente inferiore a trenta giorni, entro cui dette osservazioni debbano pervenire alla commissione).
Il procedimento di certificazione deve, in ogni caso, concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell’istanza scritta (art. 78, comma 2, lett. b). Anche in questo caso, però, la norma non disciplina l’ipotesi in cui tale limite temporale venga superato[8].
L’atto di certificazione deve essere motivato e deve contenere il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere, nonché l’esplicita indicazione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione (art. 78, comma 2, lett. c e d). I principi appena illustrati sono gli stessi previsti dalla legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Alla luce di ciò, l’atto certificatorio assumerebbe una natura paragonabile a quella del provvedimento amministrativo, il quale assolve la funzione di “certezza pubblica”, ed è non solo materialmente redatto, ma anche giuridicamente imputabile all’organo che lo emana. Nondimeno, se tali principi non fossero stati adottati dal decreto in esame, sarebbero stati applicabili solo al procedimento di certificazione operato dalla pubblica amministrazione, e non anche a quello operato dal soggetto privato.
I codici di buone pratiche e gli altri principi appena illustrati contribuiscono a rendere marginale il potere di autonomia accordato ai privati e agli uffici pubblici nella determinazione della prassi da seguire nell’attività certificatoria. Come vedremo, infatti, l’atto illegittimo sotto il profilo procedurale non soltanto non avrà valore giuridico, ma potrà costituire causa di ricorso al TAR per violazione del procedimento o per eccesso di potere (articolo 80, comma 5).
Ad uniformare ulteriormente le procedure di certificazione e a restringere il margine di discrezionalità delle commissioni di certificazione concorre anche un altro elemento. Il quinto comma dell’articolo 78 prevede, infatti, che il Ministro del Lavoro definisca, con decreto, appositi moduli e formulari per la certificazione dei contratti di lavoro.
Questi formulari dovranno tenere conto dei prevalenti orientamenti “giurisprudenziali in tema di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro”. Anche in questo caso, inoltre, all’aggiornamento periodico di tali moduli concorreranno senz’altro anche gli elaborati e gli studi che le Università invieranno al Ministero ogni sei mesi.
Infine, ai sensi del terzo comma dell’articolo 78, “i contratti di lavoro certificati e la relativa pratica di documentazione devono essere conservati presso le sedi di certificazione per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza”. Tale termine, ovviamente, varrà solo per i contratti a tempo determinato.
Uno dei motivi di tale disposizione è, sicuramente, rinvenibile in quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 80, ossia nel fatto che “il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro /…/ potrà essere valutato dal giudice del lavoro ai sensi degli articoli 9 (si ritiene che quest’indicazione costituisca un errore materiale, volendo il Legislatore indicare in realtà l’articolo 91), 92 e 96 del C.p.c.”, e, pertanto, solo in relazione alle spese del giudizio e all’eventuale risarcimento del danno per lite temeraria.
Ma vediamo, adesso, quale valenza giuridica avrà il contratto di lavoro regolarmente certificato. L’articolo 79 del decreto in esame, relativo all’efficacia giuridica della certificazione, dispone che “gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione /…/ permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari”.
In primo luogo si sottolinea che il testo della norma, limitandosi alla dizione “sentenza di merito”, non specifica se la sentenza cui si riferisce sia quella di primo grado ovvero la sentenza passata in giudicato. La quasi totalità dei commentatori, al riguardo, ha optato per il passaggio in giudicato della sentenza[9].
In ogni caso, la disposizione appena riportata si limita ad enunciare l’esistenza di effetti conseguenti alla certificazione, senza, tuttavia, precisarli. Sicuramente, nel decreto in esame non trovano riscontro le espressioni forse troppo trionfali utilizzate dal Legislatore delegante (quali, ad esempio, “l’attribuzione di piena forza legale al contratto certificato” ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. e della legge delega).
L’articolo 79 prevede, comunque, la possibilità di agire nei confronti dell’atto certificato anche in via cautelare, consentendo così alle parti (e ai terzi che vi abbiano interesse) la tutela in via immediata di diritti, derivanti da una diversa qualificazione del rapporto di lavoro, altrimenti impossibile fino alla pronuncia di merito.
Alla luce di ciò risulta, pertanto, condivisibile l’interpretazione di chi ritiene che il contratto di lavoro certificato diviene intangibile per le parti ed i terzi limitatamente alla possibilità di porre in essere atti di autotutela riconducibili ad una differente tipologia negoziale, fino a che eventuali provvedimenti cautelari non anticipino la pronuncia giurisdizionale[10].
Più specificamente, a titolo esemplificativo, la sussistenza di un contratto certificato parrebbe precludere agli enti previdenziali, quali l’Inps, la possibilità di emettere ingiunzioni di pagamento sulla base delle risultanze dei semplici verbali di accertamento dei funzionari preposti. In presenza di un rapporto certificato, l’Inps dovrebbe infatti preventivamente impugnare la certificazione ai sensi dell’articolo 80 del decreto in esame, richiamato nell’immediato prosieguo.
La certificazione attiene, dunque, alle conseguenze giuridiche dell’accordo contrattuale, imprimendo a quest’ultimo non “piena forza legale”, bensì una sorta di “temporanea immunità”[11], fino ad un eventuale e diverso accertamento giudiziale. Alla luce di ciò, l’efficacia dell’intero istituto, finalizzato proprio alla riduzione del contenzioso giudiziario in materia di qualificazione dei contratti, appare di portata limitata.
Invero, la disciplina dettata dal decreto in esame non solo non impedisce la tutela giurisdizionale dei diritti dei lavoratori o dei terzi (in caso contrario ci si sarebbe trovati di fronte ad imprescindibili questioni di illegittimità costituzionale), ma, a ben vedere, non opera nemmeno da argine.
In base all’articolo 80, comma 1, infatti, “nei confronti dell’atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l’autorità giudiziaria di cui all’articolo 413 C.p.c., per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti /…/ potranno impugnare l’atto di certificazione anche per i vizi del consenso”. Sul punto viene da chiedersi quali motivi di impugnativa il Legislatore abbia inteso lasciare fuori dalla previsione, dal momento che i casi indicati dalla norma esauriscono la quasi totalità dei motivi di ricorso.
Nel caso di ricorso per erronea qualificazione non è, però, prevista alcuna responsabilità in capo alle commissioni che hanno, in un primo momento, fornito l’assistenza e la consulenza giuridica alle parti, e, successivamente, effettuato la certificazione. Al riguardo, si registra l’opinione di chi ritiene che il datore di lavoro potrà chiedere il risarcimento del danno all’ente certificatore nel caso sia accertata l’erronea qualificazione del contratto, che comunque condurrà ad un’ulteriore controversia giudiziaria[12].
In ogni caso, ai sensi del secondo comma dell’articolo 80, l’accertamento giurisdizionale ha effetto retroattivo: nel caso di ricorso per erronea qualificazione del rapporto, questo avrà effetto fin dal momento della conclusione del contratto; nel caso di ricorso per difformità, invece, avrà effetto dal momento in cui ha avuto inizio l’accertata difformità.
Infine, ai sensi del quarto comma dell’articolo 80, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’articolo 410 C.p.c., dovrà svolgersi dinanzi all’organo che ha effettuato la certificazione. Tale tentativo di conciliazione andrà a sostituire quello previsto dall’articolo 410 C.p.c. Questa previsione risulta funzionale alla dichiarata finalità di ridurre il contenzioso, in quanto si presume che la valutazione espressa dalla stessa commissione che a suo tempo fornì consulenza giuridica e certificò il contratto, sarà in grado di contribuire a trovare una soluzione più adeguata al reale assetto dei contrapposti interessi.
Come sopra accennato, dalla disciplina in esame è anche prevista la possibilità di adire al Tribunale Amministrativo Regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto per violazione della procedura o per eccesso di potere (art. 80, comma 5). Secondo l’interpretazione di alcuni, l’impugnabilità della certificazione per eccesso di potere presuppone l’esercizio di un potere discrezionale da parte della commissione che in realtà non esiste, fondandosi l’attività di certificazione esclusivamente sull’esatta applicazione di norme giuridiche. Conseguentemente, si sarebbe dovuta prevedere la possibilità di impugnare l’atto certificato per violazione di leggi ulteriori rispetto a quelle relative alla procedura[13]. Tale previsione conferma la scelta legislativa di riconoscere alla certificazione natura di atto amministrativo, anche nell’ipotesi in cui venga posta in essere da un organismo privato (come, ad esempio, l’ente bilaterale).
Un ultimo aspetto è quello disciplinato dall’articolo 82, in base al quale “le sedi di certificazione di cui all’articolo 76, comma 1, lett. a) /…/ (ovvero, le commissioni istituite presso gli enti bilaterali) sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113 C.p.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse”. La norma parrebbe introdurre la possibilità, soltanto per le commissioni istituite presso gli enti bilaterali, di applicare la procedura della certificazione anche alle rinunzie e transazioni operate ai sensi dell’articolo 2113 C.p.c..
Trattandosi di certificazione delle rinunzie e delle transazioni, parrebbe legittimo supporre che la stessa certificazione venga assoggettata al regime delle impugnazioni previsto dall’articolo 80, comma 1 già richiamato. Tuttavia, non risulta obbiettivamente chiaro se tutte le ipotesi di impugnazione previste dall’articolo possano essere effettivamente compatibili con la certificazione di un atto unilaterale, quale è la rinunzia.
L’ipotesi appena descritta non va, però, confusa con quanto previsto dall’articolo 68 dello stesso decreto. Quest’ultima disposizione, infatti, non soltanto è dettata esclusivamente in materia di lavoro a progetto (mentre l’articolo 82 è applicabile a tutti i rapporti certificabili), ma stabilisce la diversa possibilità che i diritti derivanti esclusivamente dal lavoro a progetto siano oggetto di rinunzie o di transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro (mentre l’articolo 82 stabilisce, come abbiamo illustrato, che eventuali rinunzie o transazioni operate dalle parti ai sensi dell’articolo 2113 C.p.c. e relative ad uno qualunque dei rapporti certificabili, possono essere certificate esclusivamente dalle commissioni istituite presso gli enti bilaterali).
In conclusione, dalla complessiva analisi svolta in questa sede, emerge che, a fronte dell’ambizioso progetto perseguito dal Legislatore, finalizzato, in primo luogo, a ridurre il contenzioso giurisdizionale in tema di qualificazione di rapporti di lavoro, gli strumenti concretamente predisposti si presentano quantomeno fragili.
La mancata emissione da parte del Ministero dei decreti previsti dal provvedimento in esame, indispensabili per il funzionamento dell’intero impianto certificatorio (si pensi, ad esempio, al decreto ministeriale di individuazione dei codici di buone pratiche, o a quello di definizione dei moduli e formulari, o, ancora, a quello relativo alle commissioni di certificazione da istituirsi presso le Direzioni Provinciali de Lavoro) non fa che aumentare i dubbi circa l’effettiva utilizzabilità e la reale efficacia dell’istituto della certificazione.
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento.
STUDIO LEGALE GGM & PARTNERS
Il contenuto della presente circolare è frutto dell’attività di ricerca e di analisi svolta dai componenti dello studio legale Galanti Gelfi Meriggi & Partners. La circolare è destinata unicamente ai clienti dello studio e, pertanto, la sua comunicazione a soggetti diversi dai destinatari, la sua ulteriore diffusione e/o riproduzione non autorizzata è vietata.
[1] “Il caso della delega in materia di certificazione dei rapporti di lavoro ex articolo 5 l. n. 30/’03”, Il Diritto del Lavoro 1-2/2003, Fondazione Diritto del Lavoro L. A. Miglioranzi.
[2] A differenza di quanto previsto nella legge delega n. 30/2003, le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio non sono menzionate tra i contratti che possono ottenere la certificazione. Come osservato da alcuni, per questi tipi di rapporti, legati più ad opportunità contingenti che ad un vero progetto negoziale, sarebbe difficile predisporre un’attività certificatoria. Inoltre, data la loro limitata portata sia in ordine alla durata temporale, sia in ordine al reddito, verrebbe meno anche il principale obiettivo della certificazione, ossia la riduzione del contenzioso (“Lavoro e previdenza oggi”, 1/2004, Iuridica Editrice).
[3] “I nuovi spazi dell’autonomia privata nel diritto del lavoro: critiche al modello come strumento della qualificazione dei rapporti”, Il Diritto del Lavoro 1-2/2003, Fondazione Diritto del Lavoro L. A. Miglioranzi.
[4] Questa esclusione presenta diversi profili di criticità ed è esposta al vaglio della Corte Costituzionale. Dubbi sulla costituzionalità di tale esclusione sono stati sollevati da diversi autori (L. Zoppoli, La subordinazione tra persistenti disuguaglianze e tendenze neo-autoritarie, intervento al Seminario di studio Marco Biagi su “Lavoro subordinato, lavoro coordinato e dintorni”; R. Santucci, Contrattazione collettiva e lavori flessibili nelle Pubbliche Amministrazioni, in Aidlass, “Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro, Pesaro – Urbino, 24-25 maggio 2002).
[5] Da un punto di vista pratico, infatti, tale esclusione non considera il ricorso crescente delle Pubbliche Amministrazioni a modalità di lavoro flessibili (part-time, contratti a termine, lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative), derogando, inoltre, alla regola generale dell’applicabilità alle P.A. delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell’impresa sancita dall’art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. Testo Unico sul pubblico impiego).
[6] Considerazioni in questo senso sono state espresse dal CNEL secondo il quale la omogeneizzazione del rapporto di lavoro pubblico e privato è d’interesse fondamentale per il Paese (Parere sul disegno di legge S-848/2001, concernente la delega in materia di occupazione e mercato del lavoro del 18 febbraio 2002).
[7] Ai sensi dell’articolo 86, comma 13 del decreto legislativo n. 276/2003, entro cinque giorni successivi all’entrata in vigore del decreto, è previsto che il Ministro del Lavoro convochi le predette associazioni al fine di verificare la possibilità di affidare ad uno o più accordi interconfederali la gestione della messa a regime del decreto stesso, anche con riferimento al regime transitorio e all’attuazione dei rinvii alla contrattazione collettiva. Ad oggi, si registra la sottoscrizione di un solo Accordo interconfederale relativo al regime transitorio dei contratti di formazione e lavoro (13/11/2003).
[8] Sul punto, qualche autore rileva come tale termine, in assenza di specifiche sanzioni, sia ordinatorio, e ciò in conformità con quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 241/1990, ai sensi del quale il termine entro cui concludere il procedimento è sempre ordinatorio ed il suo superamento non determina decadenza del potere di emanare l’atto, né l’illegittimità di quello adottato (Speziale, “La certificazione dei contratti di lavoro”).
[9] Sul punto, si registra l’interpretazione opposta fornita in “Lavoro e previdenza oggi”, 1/2004, Iuridica Editrice.
[10] Nogler, “Il nuovo istituto della certificazione dei contratti di lavoro”.
[11] Speziale, “La certificazione dei contratti di lavoro”, op. cit.
[12] F. Toffoletto, “Resta il rischio-contenzioso: giudici svincolati dal visto”, su Il Sole 24 Ore del 6 settembre 2003, n. 244.
[13] (E. Ghera, “Nuove tipologie contrattuali e certificazione dei rapporti di lavoro”; L. Nogler, “Il nuovo istituto della certificazione dei contratti di lavoro”; V. Speziale, “La certificazione dei contratti di lavoro”)