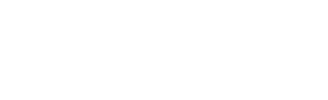[Giugno 2004] - Dell’amministrazione nelle S.p.A. (artt. 2380 bis, 2381, 2384, 2386, 2387 c.c.)
1. Amministrazione della società: in particolare “potere di gestione” (art. 2380 bis c.c.)
2. Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati: in particolare poteri e doveri degli amministratori, delegati e deleganti (art.2381 c.c.)
3. Poteri di rappresentanza (art. 2384 c.c.)
4. Sostituzione degli amministratori (art. 2386 c.c.)
5. Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (art. 2387 c.c.)
°°°
L’intento che si intende perseguire con la pubblicazione della presente circolare e delle successive è quello di voler fornire al lettore un quadro preciso e puntuale delle novità e dei cambiamenti normativi che hanno interessato la disciplina del Codice Civile in tema di amministratori delle S.p.A. a seguito della riforma del diritto societario attuata con il DLGS n.6 del 17 gennaio 2003, già in vigore dal 1 gennaio 2004 e oggetto di correzione da parte del successivo DLGS n.37 del 6 febbraio 2004.
L’analisi si soffermerà in modo particolare sulla nuova concezione del potere di gestione spettante agli amministratori (artt.2380 bis), sui rapporti tra organo delegante e organo delegato (art. 2381), sul potere di rappresentanza (art.2384), sulla sostituzione degli amministratori (art.2386), sui requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (art.2387) .
1. Amministrazione della società: in particolare “potere di gestione” (art. 2380 bis c.c.)
L’art. 2380 bis c.c. al comma primo comma sancisce che “la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”.
Tale norma, codificando un principio di origine germanica accolto in passato solo da una parte della dottrina, attribuisce definitivamente ed in via esclusiva agli amministratori il potere di assumere le decisioni che incidono direttamente sull’organizzazione e sulla conduzione dell’impresa sociale nonché il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale senza che vi sia interferenza alcuna da parte dell’organo assembleare nell’ambito del potere gestorio e senza possibilità da parte degli amministratori di sgravarsi dalle proprie responsabilità per gli atti dagli stessi compiuti.
A tal proposito, il legislatore è stato molto chiaro sostituendo il vecchio art. 2364 comma 1, n.4 in cui si leggeva che “l’assemblea ordinaria delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori…” con il nuovo art.2364 comma 1, n.5 in cui ha previsto che “l’assemblea ordinaria delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti”.
Ne consegue, pertanto, che lo statuto dovrà prevedere a priori e con sufficiente grado di precisione quali siano gli atti o le categorie di atti che gli amministratori dovranno sottoporre all’autorizzazione dell’assemblea e al fine di evitare la paralisi dell’iniziativa e dell’autonomia dell’azione degli amministratori dovrebbe auspicarsi che le clausole statutarie non assoggettino ad autorizzazione assembleare una vasta categoria di atti.
Inoltre dal tenore letterale del primo comma dell’art.2380 bis si può altresì ritenere che il potere gestorio attribuito agli amministratori deve essere intenso come un “dovere” che questi ultimi, in forza del cosiddetto contratto di società, si impegnano ad assolvere al fine di perseguire, con atti diretti o funzionali, l’oggetto sociale, unico vero limite di detto potere.
Alla luce, quindi, di tali considerazioni si può concludere che il ruolo degli amministratori ne esce sensibilmente mutato in quanto nell’assumere l’incarico di amministratore, delegato o non, come in seguito vedremo, ci si impegna non solo ad amministrare il patrimonio sociale con prudenza ed avvedutezza, ma anche ad utilizzare al meglio le risorse e le potenzialità di cui dispone la società.
Conseguentemente, ed è qui l’aspetto più innovativo e rilevante della riforma, da qualsiasi comportamento pregiudizievole per la società, anche omissivo, può discendere una responsabilità degli amministratori che non hanno agito “professionalmente” come prescritto per legge o statuto.
Infine, per completezza, occorre precisare che il legislatore ha riportato nei commi 2, 3, 4 dell’art. 2380 bis la medesima disciplina prevista nel precedente art. 2380 apportando soltanto delle modifiche formali.
Infatti il comma 3 prevede che lo “statuto” e non più “l’atto costitutivo” deve contenere il numero esatto degli amministratori o l’indicazione del numero massimo e minimo degli stessi; il comma 4, invece, prevede che “il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti (prima, membri) il presidente, se questi non è nominato dall’assemblea”.
2. Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati: in particolare poteri e doveri degli amministratori, delegati e deleganti (art.2381 c.c.)
L’art.2381 è stato completamente riscritto. Infatti fin dal suo primo comma il legislatore ha inteso disciplinare i poteri e i compiti del presidente del consiglio di amministrazione prevedendo che “salvo diversa previsione dello statuto, il presidente:
· convoca il consiglio di amministrazione;
· ne fissa l’ordine del giorno;
· ne coordina i lavori;
· provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornire a tutti i consiglieri”.
È evidente che l’intento del legislatore è stato quello di attribuire per legge al presidente delle funzioni tipiche non derogabili, funzioni che possono però essere ampliate con esplicita previsione statutaria (es. potere di rappresentanza).
Tra queste funzioni tipiche, occorre soffermarsi sul dovere del presidente di informare i consiglieri del CdA sulle materie all’ordine del giorno, dovere che si giustifica se si considera che uno dei principi cardini della riforma è rappresentato dalla maggiore circolazione di informazioni sulla gestione della società all’interno dell’organo amministrativo al fine di consentire a tutti i componenti delegati e non “di agire in modo informato” (comma 6, art.2381 c.c.).
Per quanto riguarda i commi 2, 3, 4, 5, 6 dell’articolo in esame sono interamente dedicati alla disciplina delle deleghe e dei rapporti tra organo delegato e delegante con la nuova specificazione dei poteri e dei doveri incombenti su entrambi i soggetti.
Infatti il comma 2 prevede che “se lo statuto (prima, atto costitutivo) o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti (prima, membri), o ad uno o più dei suoi componenti (prima, membri)”.
Come prima della riforma, quindi, il consiglio di amministrazione per poter attendere in maniera efficiente ai compiti di gestione sociale può, in presenza di consenso statutario o assembleare, delegare le proprie attribuzioni o ad un organo collegiale, comitato esecutivo (detto anche consiglio di amministrazione ristretto), o ad uno o più amministratori.
Il consiglio di amministrazione, però, non può per legge delegare le seguenti attribuzioni (comma 4, art. 2381 c.c.):
· emissione di obbligazioni convertibili in azioni (art. 2420 ter c.c.);
· redazione di bilancio (art.2423 c.c.);
· aumento di capitale (art.2443 c.c.);
· attribuzioni spettanti agli amministratori in relazione alla riduzione del capitale per perdite (art.2446 c.c.) o al di sotto del limite legale (art.2447 c.c.);
· progetto di fusione (art.2501 ter c.c.);
· progetto di scissione (art. 2506 bis).
L’aspetto più innovativo della disciplina delle deleghe è rappresentato dalla sostituzione della precedente espressione “il consiglio di amministrazione determina i limiti della delega” (precedente comma 1 dell’art. 2381 c.c.) con la nuova formulazione del 3 comma dell’art.2381 che sancisce “Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega”.
Tale disposizione ha innanzitutto recepito un orientamento dottrinale e giurisprudenziale che si era formato nel vigore della legislazione precedente, ma ha altresì disatteso la direttiva contenuta nell’art.4, comma 8, lett. a della Legge delega, la quale esprimeva la necessità che il legislatore precisasse i contenuti e i limiti delle deleghe.
Infatti si è ritenuto più opportuno formulare un principio generale su tale materia lasciando il consiglio di amministrazione libero di determinare i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio sia delle deleghe sia dei suoi interventi sull’organo delegato.
Inoltre il legislatore esplicitando che “il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega” ha inteso precisare che le attribuzioni delegate sono sempre attribuzioni che appartengono al consiglio di amministrazione, il quale può sempre ritenere opportuno compierle direttamente pur in presenza di deleghe specifiche.
Ne consegue che oltre ad una competenza concorrente tra organo delegato e delegante possa sorgere in capo a quest’ultimo una responsabilità in caso di danno alla società Inoltre l’ultima parte del 3 comma dell’art.2381 c.c. prevede che il consiglio di amministrazione:
· valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sulla base delle informazioni ricevute;
· esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società, quando elaborati;
· valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”.
Le specifiche competenze attribuite da questa disposizione al consiglio di amministrazione sono strettamente collegate a quelle previste dal comma 5 dello stesso articolo per gli organi delegati, i quali:
· curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa;
· riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
È evidente che il legislatore con tale ripartizione di poteri e doveri tra gli organi deleganti e delegati intende soddisfare un‘esigenza di corretta e trasparente governance societaria e a tal fine ha altresì previsto al comma 6 sia un obbligo generale per tutti gli amministratori “di agire informati” sia la possibilità per gli amministratori deleganti “di chiedere agli organi delegati che in consiglio forniscano informazioni relative alla gestione della società”.
Si può, quindi, concludere che il legislatore sancendo un obbligo di agire in modo informato ha ritenuto valido l’assioma che una buona informazione è strumentale al miglior funzionamento dell’organo collegiale amministrativo e di conseguenza garantisce una più efficiente gestione della società.
3. Poteri di rappresentanza (art. 2384 c.c.)
Il potere di rappresentanza disciplinato dal riformato art.2384 c.c. ed inteso come potere di costituire diritti ed obblighi in capo alla società con i propri atti, è il naturale corollario del nuovo potere gestorio fin qui esaminato.
Si tratta innanzitutto di poteri che in linea di principio e nella maggior parte dei casi coesistono, ma non si esclude che possono essere attribuiti a soggetti diversi.
Infatti il potere di rappresentanza può essere conferito oltre che ad amministratori anche a terzi procuratori ad acta ed in questo caso non troverà applicazione l’art. 2384, bensì le norme generali in materia di rappresentanza (art. 1387 e ss. c.c.) e all’occorrenza quelle in materia di rappresentanza commerciale (art. 2203 c.c.).
In secondo luogo la riforma ha distinto in maniera più marcata detti poteri, basti pensare che per definizione oggi il potere di rappresentanza è “generale” ed eventuali “limitazioni che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti (prima, risultano dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto) non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società” (exceptio doli).
Pertanto alla luce del nuovo testo dell’art. 2384 e dell’abrogazione dell’art. 2384 bis si può affermare che gli atti, aventi causa ed oggetto leciti, compiuti da un amministratore in nome e per conto della società, senza che allo stesso sia stato conferito o sia stato conferito invalidamente il relativo potere di rappresentanza (mancanza di potere), sono comunque validi e vincolano la società nei confronti dei terzi, i quali ricevono una tutela estesa in virtù del principio dell’affidamento e i diritti dagli stessi acquisiti non possono essere pregiudicati a meno che la società non provi che questi hanno agito intenzionalmente a suo danno.
La medesima regola è applicabile al caso in cui l’amministratore munito di potere di rappresentanza compia atti, sempre con causa ed oggetto leciti, estranei all’oggetto sociale (eccesso di potere).
Per questo motivo il legislatore, ritenendo la problematica del compimento di atti estranei all’oggetto sociale contenuta e risolta nel nuovo art. 2384 c.c., ha opportunamente abrogato l’art.2384 bis.
In conclusione, anche il nostro ordinamento ha recepito un principio già presente in quelli francese e tedesco, secondo cui “il potere di rappresentanza degli amministratori non può essere limitato e le eventuali limitazioni hanno efficacia puramente interna con la conseguenza che la loro violazione –ferma restando la validità degli atti compiuti – vale solo a rendere gli amministratori stessi responsabili nei confronti della società”.
4. Sostituzione degli amministratori (art. 2386 c.c.)
La disciplina in tema di sostituzione degli amministratori prevede al primo, al secondo ed al terzo comma due distinte ipotesi:
“se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea”
“Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carico all’atto della loro nomina, salvo diversa disposizione dello statuto o dell’assemblea” .
Il comma 4 ha invece recepito una clausola di origine giurisprudenziale, la cosiddetta “simul stabunt simul cadent”, la quale, inserita nello statuto, comporta che se “a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l’intero consiglio” gli amministratori rimasti in carica o - come prevede il comma 5 - il collegio sindacale convocano d’urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio.
In tal caso il collegio sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (art. 2387 c.c.)
Con il nuovo art. 2387 c.c. il legislatore ha previsto che:
“lo statuto può subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l’art. 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all’esercizio di particolari attività”.
La ratio ispiratrice di tale norma si individua nell’esigenza di una maggiore “profesionalizzazione” dell’attività di amministrazione alla stregua di quanto già previsto per gli esponenti bancari e per quelli di società di intermediazione finanziaria.
Già dai primi commenti, appare una certa perplessità in merito alla portata precettiva di tale norma e sulla sua concreta applicabilità a tutte le società essendo sufficiente che gli amministratori designati operino nel rispetto del principio di diligenza professionale qualificata.
Infine il rinvio all’art. 2382, ossia alle cause di ineleggibilità e decadenza, sembrerebbe far ritenere che lo statuto non possa prevederne altre, ma non si esclude che in futuro si arrivi ad un’interpretazione estensiva della norma stessa.
Restiamo a disposizione per qualsivoglia chiarimento.
Studio Legale Galanti Gelfi Meriggi & Partners
LombardConsulting
°°°
Il contenuto della presente circolare è frutto dell’attività di ricerca e di analisi svolta dai componenti dello studio legale Galanti Gelfi Meriggi & Partners e dello studio LombardConsulting. La circolare è destinata unicamente ai clienti degli studi e, pertanto, la sua comunicazione a soggetti diversi dai destinatari, la sua ulteriore diffusione e/o riproduzione non autorizzata è vietata.