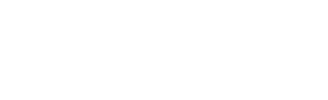[Dicembre 2006] - Tipologie di assunzione del dirigente e pattuizioni accessorie
Il dirigente deve essere informato dal datore di lavoro sulle condizioni applicabili al suo rapporto di lavoro, inclusa l’indicazione, nel contratto ovvero nella lettera di assunzione o in altro documento scritto, della durata del rapporto, che può essere a tempo determinato o indeterminato, delle funzioni allo stesso attribuite, del trattamento economico riservato e delle eventuali condizioni di miglior favore. In linea generale, nel rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere anticipatamente, dando all’altra il preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, ovvero corrispondendo, in caso di mancato preavviso, la relativa indennità sostitutiva. Naturalmente, nessun preavviso o indennità sostitutiva sono invece dovuti in caso di recesso motivato da giusta causa (art.2119 cod. civ.). Il dirigente può essere assunto anche con contratto a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni (D. Lgs. n.368/2001). La previsione di un termine di durata eccedente i cinque anni non determina la nullità dell’intero contratto, ma la riconduzione della clausola di durata entro il limite legale, in virtù dei principi generali di conservazione del contratto (art.1367 cod. civ.) e di sostituzione automatica delle clausole contrattuali difformi (artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ.). Nel rapporto a tempo determinato, è attribuita inoltre al dirigente la facoltà di recedere, trascorso un triennio dalla data dell’assunzione, previa prestazione del preavviso o pagamento della relativa indennità ai sensi dell’art.2118 cod. civ. Detta facoltà è riservata solo al dirigente; il datore di lavoro è tenuto a rispettare la durata del contratto e può recedere anticipatamente solo in presenza di una giusta causa (ossia di fatti gravi che ledano irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti). In caso di recesso datoriale non sorretto da giusta causa, il dirigente può chiedere il risarcimento del danno sia per la perdita subita che per il mancato guadagno. Il danno viene solitamente commisurato alle retribuzioni e contribuzioni che il dirigente avrebbe percepito dal momento del licenziamento fino alla scadenza del contratto. Il datore di lavoro, per contrastare o attenuare le richieste risarcitorie del dirigente, può opporre un difetto di diligenza di quest’ultimo nella ricerca di altra occupazione o l’esistenza di altri guadagni compensativi (aliunde perceptum) per il periodo residuo della durata contrattuale. Prima che sia trascorso un triennio dalla data dell’assunzione a termine, il dirigente può recedere dal rapporto di lavoro solo nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa ex art.2119 cod. civ., riferite a gravi inadempimenti del datore di lavoro, ovvero ad altre ipotesi contemplate nei contratti collettivi. In caso contrario, il datore di lavoro avrà il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito (es: oneri sostenuti per la ricerca di un sostituto, danni all’immagine e all’organizzazione della società), che dovrà provare nel suo ammontare, fatta salva la valutazione equitativa del Giudice. Il contratto a tempo determinato dei dirigenti può essere convenzionalmente prorogato per più di una volta (in tema, Cassazione n.12741/1991 e n.8069/1998). Unico limite alla proroga è rappresentato dal periodo massimo di durata del rapporto, fissato come già detto, in cinque anni. In caso di prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine, nel caso in cui lo stesso sia inferiore a cinque anni, si dovrà accertare l’effettiva volontà delle parti e verificare se le stesse abbiamo inteso disporre una proroga di detto termine, ovvero trasformare il rapporto a tempo indeterminato. Il dirigente può essere assunto a tempo determinato ripetutamente, e mediante consecutivi accordi. Naturalmente, la ripetuta e continuativa assunzione a termine che superi il limite di durata massima, si presta a possibili censure sotto il profilo dell’elusione del limite stesso. In particolare, potrebbe essere configurato un “abuso” del contratto a termine, con conseguente e possibile dichiarazione giudiziale di nullità delle assunzioni a termine del dirigente oltre il limite quinquennale di durata legale del contratto. In tale ipotesi, il rapporto di lavoro verrebbe considerato unico ed a tempo indeterminato.
L’assunzione del dirigente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, può prevedere un patto di prova. Compiuto il periodo di prova, ed in assenza di recesso di una delle parti, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità di servizio del dirigente. L’assunzione in prova del dirigente è disciplinata dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La durata della prova non può superare i sei mesi e, tale limite, è applicabile sia ai dirigenti di nuova assunzione che a quelli assunti dopo che abbiano rivestito la stessa qualifica presso altri datori di lavoro (in tema, Cassazione n.516/1989). Il patto di prova deve risultare da atto scritto, a pena di nullità. Tale essenziale requisito deve sussistere sin dall’inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di soluzioni equipollenti o sanatorie (in tema, Cassazione n.11122/2002). Il patto di prova deve contenere l’indicazione specifica delle mansioni, sulle quali il datore di lavoro deve esprimere la propria valutazione (Cassazione n.17045/2005, n.2357/2004, n.13498/2003). Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Il recesso intimato dal datore di lavoro durante il periodo di prova è un atto discrezionale (recesso ad nutum), senza obbligo di motivazione. Tuttavia, in linea teorica, il recesso datoriale non è affatto insindacabile, essendo sempre possibile per il dirigente contestarne la legittimità ma, in tal caso, dimostrando (benché la prova non sia agevole) o il positivo superamento della prova e l’arbitrarietà del recesso o l’imputabilità del recesso ad un motivo estraneo all’esperimento della prova, ovvero l’inadeguatezza della durata della prova o la difformità fra le mansioni specificate nel patto di prova e quelle di fatto espletate.
In tema di patto di prova la Corte di Cassazione, in una recente sentenza (22 giugno 2006 n.14462), ha ribadito alcuni principi cardine, applicabili anche al rapporto di lavoro dirigenziale. In particolare la Corte, ricordando il limite di durata massima del patto (sei mesi), ha confermato il potere di recesso del datore di lavoro durante la prova, senza alcun obbligo - per quest’ultimo - di fornire specifiche motivazioni al riguardo. Qualora il “lavoratore”, latamente inteso, e quindi anche il dirigente, agisca in sede giudiziale sostenendo la tesi della nullità del recesso datoriale, dovrà necessariamente dimostrare sia l’avvenuto superamento della prova con esito positivo sia la riconducibilità del recesso ad un motivo, “unico e determinante”, che sia totalmente estraneo alla funzione ed alle finalità proprie del patto di prova. La Corte ha così avuto modo di confermare quanto già delineato in precedenti apporti giurisprudenziali, riguardo ai confini sia della legittimità del recesso datoriale durante il periodo di prova sia dell’onere probatorio da assolvere per ottenere una declaratoria di nullità ed illegittimità del recesso medesimo. Nel caso di specie, in particolare, la Corte aveva rilevato che il ricorrente non aveva in alcun modo dimostrato l’imputabilità del recesso datoriale ad un motivo estraneo al patto di prova, essendosi limitato a lamentare, un “preconcetto ostruzionismo dell’azienda e dei colleghi all’inserimento del lavoratore nell’ambiente di lavoro”. Inoltre, era stato confermato lo svolgimento di un’attività certamente rientrante nell’oggetto della prova. Nell’ambito del rapporto di lavoro dirigenziale, e fuori dall’ipotesi di contratto a tempo determinato, l’unico strumento per poter garantire una continuità al rapporto è quello delle c.d. clausole di stabilità. Mediante dette clausole, il dirigente o il datore di lavoro, od anche entrambe le parti, si impegnano a non recedere unilateralmente dal contratto per un certo periodo di tempo. Oggetto della clausola di stabilità è quindi una limitazione del potere di recesso unilaterale, per un periodo di tempo prestabilito. Comunemente si distinguono due specie di clausole di stabilità: le clausole di stabilità in senso stretto, dirette alla conservazione del posto di lavoro fino ad un tempo massimo di durata, oltre il quale il rapporto cessa, e le clausole di stabilità relativa, che assicurano il mantenimento del rapporto per un certo periodo, ferma la sua prosecuzione anche dopo lo scadere di detto periodo. La differenza essenziale tra le due tipologie di clausole è data dal fatto che, mentre nelle clausole di stabilità in senso stretto il termine finale determina l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro (in tema, Cassazione n.2318/2004), in quelle di stabilità relativa la scadenza del termine non fa cessare il rapporto di lavoro che, pertanto, prosegue a tempo indeterminato. Le clausole di stabilità relativa possono essere dirette a tutelare sia l’interesse dell’azienda di fidelizzare il dirigente o garantire gli investimenti profusi per la sua formazione (in tema, Cassazione n.17817/2005 conf. alla n.1435/1998), sia l’interesse del dirigente, nelle sue esigenze di tutela rispetto a mutamenti dell’assetto di controllo della società, ovvero di tutela rispetto ad irrazionali ed ingiustificate scelte datoriali (in tema, Cassazione n.6520/1995). L’ampiezza delle clausole di stabilità relativa può variare secondo la volontà delle parti. Le clausole di stabilità relativa sono compatibili solo con un rapporto a tempo indeterminato, ed è quanto mai opportuno che le stesse vengano adeguatamente predisposte e documentate in forma scritta. Per quanto concerne la determinazione dell’entità del danno per violazione delle clausole di stabilità, si configurano due possibilità: a) la prima è che l’entità del danno venga predeterminata convenzionalmente ed in modo congruo dalle parti; b) la seconda è che, in mancanza di una determinazione convenzionale, l’entità del danno risarcibile possa essere quantificata in base ai principi generali in tema di risarcimento del danno da inadempimento; in tal caso, e nell’ipotesi di violazione della clausola di stabilità relativa da parte del datore di lavoro (in assenza di giusta causa), il danno subito dal dirigente può essere commisurato alle retribuzioni (ed ai contributi previdenziali) da corrispondere fino alla scadenza del termine di durata minima, a cui si dovranno aggiungere l’indennità sostitutiva di preavviso e l’indennità supplementare (in assenza del requisito della giustificatezza dell’interruzione del rapporto). Nel caso di mancato rispetto della clausola di stabilità relativa da parte del dirigente, l’entità del risarcimento a favore del datore di lavoro, in mancanza di previsione di una penale (che dovrà essere congrua e “sostenibile” in caso di richiesta di riduzione), dovrà essere comprovata dal datore di lavoro.
L’accordo di assunzione del dirigente può a volte prevedere uno specifico patto di non concorrenza al termine del rapporto (art. 2125 cod. civ.). Il patto di non concorrenza deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto, determinare limiti di oggetto, di luogo e di tempo all’obbligo di non concorrenza, attribuire al dirigente un corrispettivo per l’assunzione dell’obbligo. La durata del patto non può superare i cinque anni. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il patto di non concorrenza può riguardare qualsiasi attività che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve necessariamente limitarsi alle sole mansioni espletate dal dirigente nel corso del rapporto (Cassazione, n.15253/2001 e n.10062/1994). Tuttavia, il patto di non concorrenza è valido qualora sia previsto il pagamento di un corrispettivo congruo rispetto al “sacrificio” richiesto (in tema Tribunale di Milano, sentenza 11/6/2001) e qualora non venga compressa eccessivamente la professionalità del dirigente, in limiti che compromettano la sua possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo a soddisfare obiettive esigenze di vita (Cassazione n.5477/2000, n.5691/2002 e n.4891/1998). Il corrispettivo del patto di non concorrenza, oltre che congruo, deve essere esattamente determinato nel suo ammontare (in tema Tribunale di Milano, sentenze 18/6/2001 e 16/6/1999), può essere erogato mensilmente in costanza di rapporto, oppure, come avviene nella quasi totalità dei casi, alla scadenza del patto, ovvero, in casi più rari, alla cessazione del rapporto. Se il corrispettivo del patto di non concorrenza viene erogato in costanza di rapporto, lo stesso incide sul calcolo del TFR ed è soggetto a tassazione ordinaria ed a contribuzione previdenziale; se invece viene pagato alla cessazione o dopo la cessazione del rapporto, non incide sul TFR, è soggetto a tassazione “separata” ed esente da contributi previdenziali. Il patto di non concorrenza può essere sciolto solo per volontà di entrambe le parti, salvo il caso di clausole che prevedano la facoltà di recesso da parte del datore di lavoro, da esercitarsi, in ogni caso, prima della cessazione del rapporto (in tema, Tribunale di Milano sentenza 25/7/2000).
Avv. Marco Emanuele Galanti
Studio Legale Galanti Gelfi Meriggi & Partners
(Tratto dal Sole 24 Ore – Norme e tributi del 16/10/2006)