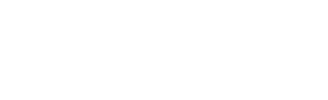[Maggio 2007] - Il contratto a termine: principi generali e recenti novita’
Una pur sintetica trattazione della tematica del rapporto di lavoro a tempo determinato non può prescindere da alcune brevi considerazioni concernenti la Direttiva comunitaria 1999/70/CE, che, come noto, e sotto l’aspetto normativo, è stata, indubbiamente, il principale punto di riferimento per la modifica nel nostro ordinamento della regolamentazione del lavoro a tempo determinato.
La Direttiva comunitaria, pur volendo configurare un modello alternativo e non subalterno all’istituto del contratto a tempo indeterminato, fissa un punto fermo in materia di lavoro a termine, confermando, peraltro, che i contratti a tempo indeterminato continuano ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro. Tale principio è stato inoltre più volte ribadito anche dalla giurisprudenza, secondo cui l’apposizione del termine al rapporto di lavoro subordinato costituisce deroga al principio generale in forza del quale i rapporti di lavoro, per loro natura, sono a tempo indeterminato (In tal senso Cass. 21/5/2002 n. 7468 e Corte d’appello Milano 9/1/2006).
La Direttiva comunitaria ha affermato, inoltre, il principio di non discriminazione, equiparando i lavoratori a tempo determinato a quelli a tempo indeterminato, precisando altresì che i primi non possono essere, per nessuna ragione, trattati in modo meno favorevole rispetto ai secondi.
Il presupposto che la Direttiva richiede per l’apposizione del termine ad un rapporto di lavoro è la presenza di condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
La scelta operata dal legislatore italiano nel recepire la Direttiva comunitaria, con il decreto legislativo 368/2001, è stata quella di meglio specificare l’ambito delle “condizioni oggettive” delineate dalla Direttiva, elencando quattro ampie ipotesi che legittimano il ricorso al contratto a termine.
Più specificamente, e contrariamente rispetto alla vecchia disciplina del contratto a termine dettata dalla legge n. 230 del 18 Aprile 1962, che prevedeva la possibilità del ricorso al contratto a termine solo in caso di attività o finalità particolarmente tipizzate (esigenze sostitutive, attività stagionali, opere e servizi definiti e predeterminati a carattere straordinario e occasionale etc.), il decreto legislativo 368/2001 consente l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
Le quattro ragioni appena ricordate costituiscono indubbiamente delle categorie generali, che, necessariamente, il datore di lavoro dovrà, obbligatoriamente in forma scritta, meglio precisare nei loro confini all’atto dell’instaurazione del rapporto a tempo determinato, posto che lo stesso datore ha uno specifico obbligo di motivare formalmente le ragioni del ricorso a tale tipologia di contratto ( art. 1, comma 2, D. lgs. 368/2001).
In linea generale, le ragioni del ricorso al contratto a termine devono fare riferimento a delle esigenze tali da non poter essere soddisfatte con l’impiego del personale dipendente già presente né con l’assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato (In tal senso Circolare ministeriale n. 42 del 1° Agosto 2002).
L’assenza e/o l’incompletezza formale delle indicazioni relative alle ragioni legittimanti il ricorso al contratto a termine o la loro non rispondenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, determinano, avendo l’art. 1, comma 1 natura imperativa, la nullità dell’apposizione del termine e la conversione in contratto a tempo indeterminato (In tal senso Corte d’Appello di Bari 20/7/2005; Trib. Milano 9/4/2004).
Se con la disciplina del decreto legislativo 368/2001 il datore di lavoro ha acquisito la facoltà di invocare ragioni diverse e apparentemente più ampie rispetto a quelle tassativamente previste dalla precedente legge 230/1962, questo non ha comportato, tuttavia, una minore tutela del lavoratore. Il controllo sull’operato del datore, e quindi sulla effettiva e concreta sussistenza, formale e sostanziale, delle ragioni che hanno formalmente e sostanzialmente giustificato il ricorso al lavoro a tempo determinato è sempre possibile in via giudiziale. Ciò trova conferma nell’ampia e particolarmente rigorosa elaborazione giurisprudenziale, secondo cui le ragioni oggettive che il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare, pena la nullità della clausola di apposizione del termine, devono essere specificate in modo chiaro, al fine di evitare eventuali abusi e raggiri attraverso comportamenti fraudolenti. Nonostante la formula elastica scelta dal legislatore riguardo le ragioni che legittimano il ricorso al lavoro a tempo determinato, non è sufficiente fare riferimento alla semplice e tautologica riproposizione di dette ragioni e, in caso di contestazione da parte del lavoratore, l’obbligo del datore si estende alla prova della loro esistenza e consistenza (In tal senso Trib. Milano 31/10/2003, Trib. Milano 25/11/2004).
Sempre secondo la giurisprudenza formatasi sul decreto legislativo 368/2001, è necessario descrivere la particolare realtà attinente alle esigenze dell’impresa alle quali si è inteso sopperire con la stipulazione di un contratto a termine, non costituendo specificazione della ragione ai sensi di legge, ad esempio, il mero riferimento all’esigenza di provvedere alla sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto, nemmeno ove integrato dal richiamo all’inquadramento di detto personale assente e all’area di riferimento. Occorre invece che la specificazione raggiunga un livello tale da consentire al giudice di verificare il collegamento causale tra assenza e assunzione, esponendo, ad esempio, indicazioni circa la struttura, le dimensioni del luogo di lavoro e le esigenze specifiche di sostituzione del personale relativo allo stesso luogo (In tal senso Trib. Milano 14/10/2004).
La disciplina del contratto a termine, introdotta con il D. lgs. 368/200, pone, quindi, a carico del datore di lavoro, l’onere non soltanto di specificare a monte le ragioni del ricorso al contratto a termine, ma anche a valle, quando cioè le stesse vengano contestate, di dimostrarne la loro esistenza concreta. E’ stata dichiarata la nullità del termine in un’ipotesi in cui, pur ammettendo come fatto notorio il maggior flusso postale nel periodo natalizio, nulla era stato dedotto per dimostrare gli effetti di tale aumento nella sede in cui il lavoratore era stato assunto (In tal senso Trib. Milano 13/11/2003). Un’ulteriore ipotesi in cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’apposizione del termine con il conseguente accertamento della sussistenza di un ordinario rapporto a tempo indeterminato, è quella concernente la motivazione, addotta dal datore nella lettera di assunzione che, oltre ad essere stereotipata e ripetitiva, faceva riferimento a una pluralità di ragioni alternative.
L’alternatività delle ragioni giustificatrici vanificherebbe l’esigenza di specificità e, tutt’al più, il datore dovrebbe dimostrare e specificare congiuntamente tutte le ragioni previste, con riferimento a esigenze precise e dettagliate (In tal senso Trib. Milano 31/10/2003).
L’unica valutazione sottratta al controllo del giudice è quella inerente al merito della scelta, che rimane insindacabile poiché le scelte organizzative del datore di lavoro fanno capo al principio cardine in materia, quello della libertà dell’iniziativa economica privata, garantito costituzionalmente (art. 41 Cost.).
Riguardo la durata dei contratti a termine, il decreto legislativo 368/2001, in esecuzione di quanto previsto alla clausola 5 della direttiva comunitaria 1999/70/CE, che imponeva l’obbligo di prevedere una durata massima totale dei contratti a tempo determinato, stabilisce un termine massimo complessivo di tre anni e di cinque anni per i dirigenti (art. 4, comma 1 e art. 10, comma 4 del D. lgs. 368/2001).
In riferimento alla possibilità di rinnovare detti contratti o rapporti a termine, la Direttiva imponeva agli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, l’introduzione di misure relative a ragioni obiettive per giustificare il loro rinnovo nonché la determinazione del numero possibile dei loro rinnovi.
Il legislatore italiano, in applicazione di criteri ragionevoli e concordati con le parti sociali, ha innanzitutto ammesso, all’art. 4 del decreto 368/2001, la possibilità di una sola proroga del contratto a tempo determinato, sino al raggiungimento di una durata massima complessiva per l’intero rapporto di tre anni (cinque per i dirigenti), a condizione che ci sia, oltre al consenso delle parti, anche una ragione oggettiva che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato. Sul punto, in una delle peraltro rare pronunce giurisprudenziali, si è precisato che le ragioni oggettive legittimanti la proroga devono consistere in circostanze sopravvenute rispetto al momento della stipulazione del contratto a termine originario. Deve, pertanto, ritenersi nulla la proroga motivata da ragioni già presenti ab inizio; nel caso di specie la durata del rapporto era stata determinata per un periodo inferiore all’aspettativa obbligatoria per maternità della lavoratrice sostituta e, alla scadenza, il contratto era stato prorogato con la motivazione del mero protrarsi dell’assenza (In tal senso Trib. Milano 31/3/2006).
La Direttiva 1999/70/CE obbligava gli Stati membri, sempre previa consultazione con le parti sociali, a stabilire a quali condizioni i contratti a tempo determinato dovessero considerarsi “successivi” ed a quali condizioni gli stessi dovessero essere ritenuti a tempo indeterminato.
L’art. 5 del decreto legislativo 368/2001 ha introdotto un “periodo di tolleranza” oltre la scadenza originaria del termine, durante il quale la prosecuzione del contratto è ancora ritenuta legittima; più in particolare, fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine originario il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere il 20% in aggiunta alla retribuzione, mentre per ciascun giorno ulteriore la percentuale aggiuntiva diventa del 40% (art. 5, comma 1 del D.lgs. 368/2001).
Superato il periodo di 20 giorni (se l’originario contratto aveva durata inferiore a sei mesi) o 30 giorni (se invece l’originario contratto era superiore a sei mesi), il contratto si trasforma, ex nunc, in contratto a tempo indeterminato (art. 5, comma 2 del D. lgs. 368/2001).
Questa previsione mitiga il tenore tassativo della vecchia legge 230/1962 che prevedeva, in caso di continuazione del rapporto oltre la scadenza, la trasformazione in contratto a tempo indeterminato sin dalla data della prima assunzione.
Sono altresì previsti nella disciplina vigente, al fine di definire la “successione” di contratti, intervalli temporali (10 o 20 giorni a seconda della durata del primo contratto) che devono obbligatoriamente trascorrere prima di una nuova assunzione a termine e che, se non rispettati, generano la patologia della conversione del contratto a tempo indeterminato. Il dies a quo della conversione si calcola dalla data del secondo contratto stipulato, quando gli intervalli sopraindicati non vengono rispettati, mentre nel caso di due assunzioni a termine, senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ex tunc (art. 5, commi 3 e 4 del D. lgs. 368/2001).
Obiettive problematiche emergono dalla successione di contratti a termine, pur nel rispetto sia dei limiti complessivi di durata di ciascun contratto sia degli intervalli temporali previsti dalla legge, appena ricordati.
In linea teorica, potrebbe essere realizzata una successione sine die dei contratti a tempo determinato che, nella gran parte dei casi, configurerebbe una prassi diretta a raggirare fraudolentemente le prescrizioni sia della Direttiva che della legge vigente.
A tal proposito, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con una recente sentenza, ha considerato che il potere discrezionale degli Stati di determinare il carattere “successivo” dei contratti a termine, non è illimitato, ritenendo non conforme alle finalità della normativa europea la legislazione nazionale che consideri “successivi” i contratti separati da un lasso temporale pari o inferiore a venti giorni lavorativi (In tal senso Corte di Giustizia C.E., sentenza 4/7/2006 C-212/04).
In conclusione, dalla breve analisi normativa e giurisprudenziale proposta, emerge l’inopportunità di qualsivoglia intervento restrittivo sulle ragioni legittimanti il ricorso al lavoro a tempo determinato, ma piuttosto la necessità di interventi mirati e chiari, diretti ad evitare una fraudolenta e illimitata reiterazione di detti rapporti. (Pubblicato sul Sole 24 Ore - Norme & Tributi in data 07/05/07)
Avv. Marco Emanuele Galanti
Studio Legale Galanti Meriggi & Partners