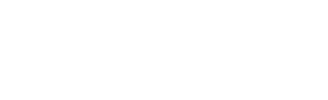[Novembre 2012] - I nuovi termini di pagamento per la Pubblica Amministrazione e per i rapporti tra imprese commerciali
La problematica dei ritardi nei pagamenti sia della PA nei confronti delle imprese commerciali sia nei rapporti tra le stesse imprese, ha determinato sia l’aumento delle situazioni di crisi ed insolvenza sia il diffondersi di un inaccettabile malcostume.
Il Governo italiano, al fine di porre rimedio a tali criticità, ha approvato nel Consiglio dei Ministri del 31/10/2012 un decreto legislativo con cui ha recepito, in anticipo rispetto alla scadenza fissata dalla Commissione Europea per il 16 marzo 2013, la direttiva 2011/7/UE.
La direttiva UE riguarda i tempi di pagamento per tutte le transazioni commerciali, ovvero per “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. La nuova normativa, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013 per tutti i contratti conclusi a partire da questa data, si applicherà ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale così come sopra definita, con esclusione dei debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore ivi compresi gli accordi di ristrutturazione del debito ed i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno compresi quelli effettuati da un assicuratore.
Da una prima lettura degli articoli del decreto legislativo, la nuova normativa sembrerebbe applicarsi anche in favore dei liberi professionisti in quanto nell’art.2 il legislatore ha chiarito che per imprenditore deve intendersi “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione”. Il condizionale è d’obbligo in quanto la citata norma si pone in contrasto con le definizione di “professionista” formulata dal medesimo legislatore nell’ambito della riforma delle professioni di cui al D.P.R. 07.08.2012 n° 137 pubblicato in G.U. 14.08.2012. E’ auspicabile sul punto un intervento chiarificatore del legislatore al fine di eliminare qualsiasi problematicità interpretativa con risvolti negativi sul piano applicativo.
La nuova normativa, quindi, prevede che le Amministrazioni Pubbliche dovranno pagare i debiti nei confronti delle imprese fornitrici di merci e/o servizi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; o quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equipollente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi; o infine, entro 30 giorni dalla data di accettazione delle merci/servizi o della verifica della conformità delle stesse rispetto alle previsioni contrattuali. In tale ultima ipotesi, detta procedura non potrà avere una durata superiore a 30 giorni dalla data di consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo diveso accordo scritto tra le parti o diversa previsione nel bando di gara e purchè ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
Solo per le imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003 n. 333 o per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria (come asl e ospedali) viene concessa una deroga ed i tempi per il pagamento saranno di 60 giorni invece dei 30 fissati dal decreto.
Una analoga proroga del termine di pagamento è prevista anche per altre PA, ma solo se la proroga è giustificata “dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione” e la relativa clausola risulta provata per iscritto.
Le nuove previsioni normative sopra ricordate valgono anche nei rapporti tra imprese commerciali ed anche la deroga a 60 giorni dei termini di pagamnto tra le stesse sarà ammessa solo se giustificata da espresso accordo scritto tra le parti, mentre i termini di pagamento superiori a 60 giorni potranno essere pattuiti solo se non “gravemente iniqui” per il creditore.
Gli aspetti più interessanti della nuova normativa sono rappresentati sicuramente dalle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini di pagamento suindicati.
In primo luogo, è stato previsto che nel caso in cui si superi il termine di pagamento dei 30 giorni o dei 60 giorni in caso di proroga, il debitore, senza necessità di formale costituzione in mora, sarà tenuto a corrispondere al creditore interessi moratori calcolati sulla base del saggio degli interessi legali di mora (attualmente pari all’1%), aumenati dell’8%.
Il mancato o ritardato pagamento del credito entro i termini sopra ricordati, legittimerà altresì il creditore ad ottenere un rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, rimborso che è stato forfettariamente quantificato, senza che sia necessaria la costituzione in mora, in euro 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva in ogni caso la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza, anche legale, per il recupero del credito.
Infine, sono stati tipizzati dei casi di nullità di clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori, al risarcimento per i costi di recupero e alla predeterminazione o alla modifica della data di ricevimento della fattura da parte della PA.
Dette clausole saranno dichiarate nulle dal giudice, anche d’ufficio, quando risulteranno “gravemente inique” in danno del creditore, tenuto conto di tutte le circostanze che ne hanno determinato l’inserimento, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale, il contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l’esistenza di motivi oggettivi per derogare sia al saggio degli interessi legali di mora sia ai termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
Certamente affette da nullità, in quanto a priori ritenute dal legislatore “gravemente inique” per il creditore, saranno invece giudicate le clausole che escludono sia l’applicazione degli interessi di mora sia il risarcimento per i costi di recupero.
Per tutte le altre clausole che verrano introdotte dalle parti nei rispettivi contratti, sarà quindi necessaria una valutazione del giudice per determinare i casi di grave iniquità nei confronti del creditore e ciò molto probabilmente potrà determinare, ad avviso dello scrivente, l’incrementarsi di azioni, anche di natura defatigaroria e meramente strumentale con conseguente dilatazione dei tempi di pagamento dei debiti, attenuando di fatto le finalità che il legisltatore ha inteso perseguire con la nuova normativa.
* Marco Emanuele Galanti
* Stefano Bardelloni
*Studio Legale Galanti Meriggi & Partners