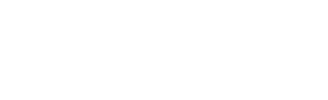[Marzo 1996] - Art 25 l 06/02/96 n° 52
CIRCOLARE N. 2 MAR96
Sull’art.25 della LEGGE 6 Febbraio 1996, n.52
Introduzione
Scopo di queste note è quello di porre l’attenzione degli operatori sulle novità che derivano dal recepimento della Direttiva CEE 13/93 del 5/4/1993 nel nostro Ordinamento, avvenute con la Legge 6/2/96 n.52.
Le note che seguono costituiscono una prima lettura delle nuove norme e quindi non hanno alcuna ambizione di completezza: ci sembra già un buon risultato quello di fornire un’utile fonte di conoscenza per coloro i quali operano nei mercati sia come “professionisti” che come “consumatori”, nelle eccezioni recepite nella novella e di eguito meglio delineate.
Nell’intento di non appesantire queste note ma di renderle semplice strumento operativo nei primi tempi di applicazione, si eviterà l’esercizio (meritorio ma, probabilmente, approssimativo) di esemplificare tipi di clausole ritenute vessatorie e ci si limiterà al richiamo al testo delle norme che per completezza viene allegato alla presente.
Struttura della novella
Le norme in esame sono state introdotte dall’art.25 della legge 6/2/96 n.52 (cd. “legge comunitaria 1994), che recepisce, fra l’altro, la Direttiva CEE 13/1993, in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
La legge è entrata in vigore il 25/2/1996; quindi si applica ai contratti stipulati dopo tale data mentre sembra coerente l’applicabilità ai contratti anteriori a tempo indeterminato nonchè a quelli soggetti a proroga o rinnovazione dopo tale data.
Il nostro legislatore ha ritenuto di adottare il sistema della “novella” del Codice Civile, inserendo un nuovo capo (Capo XIV bis”Dei contratti del consumatore”) nel titolo II del libro IV con i seguenti articoli:
-art.1469 bis (clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore), che prevede un elenco di venti clausole che si presumono vessatorie nonchè disposizioni specifiche in tema di contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi finanziari;
-art.1469 ter (accertamento della vessatorietà delle clausole);
-art.1469 quater (forma ed interpretazione);
-art.1469 quinquies (Inefficacia), che menziona altresì clausole vessatorie che si potrebbero definire “abusive”;
-art.1469 sexies (Azione inibitoria).
Art.1469 bis
Il primo comma dell’articolo enuncia il principio in base al quale una clausola contrattuale è considerata vessatoria, ossia quando essa determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in contrasto con il principio di correttezza.
Tale ultimo inciso sembra essere il significato del testo letterale della norma (”malgrado la buona fede”) : criterio fondamentale è quello dello squilibrio, mentre la contrarietà alla buona fede è una qualificazione di tale squilibrio.
Lo “squilibrio” che qualifica la vessatorietà è stato quindi definito di tipo “normativo” e non di tipo economico (così invece quello qualificato all’art. 1469 ter, secondo comma del Codice Civile).
La normativa è generale, e si applica quindi a tutti i contratti, anche verbali (tranne norme specifiche dettate per alcune categorie di contratti contraddistinti per il loro oggetto: “prestazioni di servizi finanziari”), siano o meno predisposti dal professionista.
Il secondo comma pone le definizioni di consumatore e professionista, ossia i soggetti tra i quali viene concluso il contratto di cui al primo comma, così confermando la tendenza del legislatore comunitario all’identificazione di categorie contrattuali soggettivamente caratterizzate, “nel senso di una sorta di corporativizzazione del diritto “.
Il “consumatore” è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” e quindi
: -non sarà tale nè l’impresa collettiva nè l’imprenditore individuale, non avendo il legislatore ritenuto meritevoli di tutela le imprese “deboli” nei rapporti contrattuali con le imprese “forti”;
Il “professionista” è la “persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma ” e quindi:
il soggetto delineato dalla norma non è riconducibile alla figura del “professionista” così come intesa nel nostro diritto positivo, la definizione essendo stata mutuata dal polivalente vocabolo della lingua francese “professionel”;
è testuale il riferimento ai soggetti pubblici. Il terzo comma elenca venti clausole che “si presumono vessatorie”, con l’onere a carico del professionista di provare il contrario, ossia che la clausola non provoca alcun significativo squilibrio a carico del consumatore (presunzione semplice o relativa, quindi suscettibile di prova contraria).
I commi quarto,quinto e sesto sono destinati a disciplinare i contratti che hanno per oggetto “la prestazione di servizi finanziari” per l’identificazione dei quali si può fare riferimento all’art.1, secondo comma, della Legge Bancaria (D.Lgs.385/1993) e quindi interessano in primo luogo le banche, le società di “leasing”, le società di investimento mobiliare e le società che gestiscono fondi chiusi mobiliari ed immobiliari: si tratta di norme che consentono, in considerazione del particolare oggetto dei contratti posti in essere, quali professionisti, da tali soggetti, deroghe alle clausole sopra considerate vessatorie.
Infine, il settimo comma prescrive la disapplicazione delle clausole di cui ai nn.12 e 13 alle clausole di indicizzazione dei prezzi “ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte”, con ciò ponendo un ulteriore obbligo di trasparenza a carico del professionista.
Due brevi considerazioni:
La prima: il criterio generale che qualifica come vessatoria una clausola nei contratti in esame (buona fede oggettiva e squilibrio normativo) non si esaurisce nell’elenco di cui all’art.1469 bis e quindi vi possono essere clausole contrattuale che, pur non comprese in tale elenco, sono da considerarsi “vessatorie”.
La seconda: alcune delle clausole in elenco prevedono che venga meno il loro carattere di “vessatorietà” qualora sia dato un rimedio al consumatore al fine di eliminare lo squilibrio dei diritti e degli obblighi (v.clausole nn.5-7-9-11 e 13). La previsione di ciò che è stato definito dalla dottrina che per prima ha commentato la norma di cui ci occupiamo come “contrappeso” a favore del consumatore, non esclude la “vessatorietà” della clausola, ma fa solo venire meno la presunzione (relativa) di “vessatorietà”
Art.1469 ter
Precisata al primo comma dell’articolo precedente la definizione di clausola vessartoria, i primi due commi dell’articolo in esame indicano gli elementi per accertare la vessatorietà delle clausole.
Il primo comma dispone una valutazione, in positivo, che deve tenere conto:
- della natura del bene o del servizio (oggetto del contratto);
- delle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto;
- delle altre clausole del contratto o di un altro contratto collegato o da cui dipende.
Il secondo comma dispone invece una valutazione in negativo: la clausola non deve attenere “alla determinazione dell’oggetto del contratto, nè all’adeguatezza del corrispettivo dei beni o dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”: onere quest’ultimo che sembra essere posto a carico del professionista.
Quindi l’accertamento della vessatorietà di una clausola è il risultato di una valutazione discrezionale, operata sia in base a concetti elastici, quali quelli desumibili dalla stessa formulazione letterale delle clausole elencate nell’articolo che si commenta, sia in base ad un canone generale quale è il criterio di buona fede.
Ma l’art. 1469 ter, ai successivi quarto e quinto comma, reca due disposizioni che si pongono come un antecedente logico rispetto alla valutazione della vessatorietà e che costituiscono, soprattutto la seconda, uno degli elementi chiave di tutta la novella.
Il quarto comma dispone infatti che non sono considerate vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge o di principi contenuti in convenzioni internazionali: è da notare che il legislatore italiano non ha fatto riferimento ai regolamenti (fonte normativa di secondo grado), come invece è previsto dall’articolo 1 della Direttiva, nonostante l’importanza del ruolo che gli stessi svolgono specie nella contrattazione con gli enti pubblici, cui pure si applicano, come detto, le disposizioni in commento.
Ancora più importante è la prescrizione del quinto comma, in base alla quale non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausole che siano stati oggetto di trattativa individuale: in questo caso viene meno l’intervento del legislatore a tutela del consumatore.
Per “trattativa” deve intendersi l’attività di negoziazione del contenuto della clausola svoltasi tra il professionista ed il consumatore; si può, anche in questo caso, fare riferimento alla giurisprudenza formatasi in merito all’art. 1341, secondo comma, del Codice Civile.
Ai sensi dell’ultimo comma è a carico del professionista l’onere di provare che è avvenuta una specifica trattativa nel caso di contratti conclusi mediante moduli o formulari (cd. “contratti standard”), dal medesimo professionista unilateralmente predisposti.
Certamente si rivela problematica la prova (a carico del professionista) circa l’effettiva esistenza di un “negoziato individuale” (così si esprime la Direttiva all’art.3) con il consumatore mentre è da escludersi la efficacia di una clausola (di stile) che comunque dia atto dell’avvenuta trattativa.
Art.1469 quater
La dottrina che per prima ha esaminato la norma ha messo in luce come la stessa non ponga affatto un requisito di forma, ma imponga un obbligo di “trasparenza” a carico del professionista (primo comma).
Il secondo comma aggiunge un ulteriore canone legale di interpretazione dei contratti a quelli già previsti nel Codice Civile, così sovrapponendosi alla disciplina dettata dall’art.1370 del Codice Civile per i contratti cd. “standard”.
Art. 1469 quinquies
E’ questa una norma fondamentale del sistema.
Il primo comma dispone l’inefficacia delle clausole considerate vessatorie, specificando che il contratto rimane efficace per il resto, senza dare risposta al problema della sussistenza del contratto nel caso in cui le clausole inefficaci siano essenziali per l’esistenza del contratto medesimo.
La scelta del legislatore circa la sanzione dell’inefficacia piuttosto che quella, più grave, della nullità, è probabilmente dovuta, oltre che alla valutazione circa l’impatto della nuova normativa all’interno del sistema sanzionatorio del Codice Civile, anche alla considerazione che la conservazione del contratto (depurato dalle clausole vessatorie) è un regime di favore nei confronti del consumatore.
La disciplina di tale inefficacia (salvo quanto previsto dall’articolo successivo) è così delineata al terzo comma:
-può essere rilevata d’ufficio dal giudice;
-il professionista non può farla valere rispetto ad una clausola dal medesimo predisposta: così si interpreta l’inciso “opera soltanto a vantaggio del consumatore”.
Non è fatto cenno alla decadenza dell’azione nè all’opponibilità ai terzi dell’inefficacia
. Il secondo comma dell’articolo dispone l’eccezionale inefficacia di tre clausole, anche se oggetto di trattativa tra il professionista ed il consumatore: sono queste clausole di esonero o limitazione della responsabilità per danno alla persona o per inadempimento o di adesione a clausole non conoscibili.
Tali clausole, secondo la dottrina preferibile, si debbono presumere in ogni caso vessatorie (presunzione assoluta) e comunque, indipendentemente da ogni valutazione, inefficaci: da ciò la differenza con le clausole, contenute nei precedenti articoli, che si “considerano vessatorie” (presunzione relativa).
Il quarto comma dell’articolo sancisce un principio di rilevante importanza e che per il suo contenuto può di fatto estendere gli effetti della Novella a soggetti non direttamente destinatari della stessa.
Si stabilisce infatti, seppur in modo non certo chiaro, il diritto del venditore ( professionista) all’azione di regresso nei confronti del suo fornitore per i danni che dovesse subire in conseguenza della declaratoria d’inefficacia delle clausole dichiarate abusive e dallo stesso imposte al consumatore.
In forza del descritto principio, tutte le imprese intermedie della a volte complessa catena distributiva, possono teoricamente essere coinvolte in un’azione di regresso per il ristoro dei danni conseguenti all’inefficacia delle clausole abusive.
Infine, il quinto comma, quale norma di chiusura del sistema, dispone l’inefficacia, senza necessità o possibilità di diversa valutazione, di una clausola che abbia come scopo quello di eludere le norme di protezione del consumatore dettate dalla legge.
Art.1469 sexies
L’art.7 della Direttiva lasciava al legislatore nazionale la scelta circa l’autorità cui demandare la repressione.
Il legislatore italiano ha scelto la via del controllo giudiziario, anzichè amministrativo, mediante l’introduzione di una particolare azione al fine di inibire l’uso delle clausole di cui sia stata accertata la vessatorietà, ai sensi di legge.
Questi i principali caratteri dell’azione:
-in quanto azione inibitoria, ha essenzialmente funzione di prevenzione, indipendentemente dal fatto che sia esperita prima che la clausola venga dedotta in contratto ovvero nei confronti di clausole già utilizzate, in quanto è comunque volta ad impedire il possibile uso della clausola vessatoria;
-presupposto dell’azione è l’attività illecita in quanto tale, prescindendo dalla colpa e dal danno;
-la legittimazione attiva spetta alle associazioni “rappresentative” sia dei consumatori sia dei professionisti, nonchè alla Camera di Commercio;
-la sentenza inibitoria può essere oggetto di pubblicità mediante pubblicazione sui giornali.
Considerazioni Finali
Le brevi note che precedono non possono ritenersi concluse senza farsi carico di affrontare due questioni, l’una di carattere generale e sistematico, l’altra di natura più specialistica ma non per questo priva di rilevanza pratica.
La prima questione riguarda il coordinamento delle nuove norme con gli articoli 1341, 1342 e 1370 del Codice Civile.
L’articolo 1341 del Codice Civile (”Condizioni generali di contratto”) disciplina il fenomeno della predisposizione unilaterale del contratto, al fine di un suo impiego reiterato (cd. “contrattazione di massa”), subordinandone l’efficacia alla conoscenza e, quanto meno, alla conoscibilità da parte del soggetto non predisponente.
Il secondo comma del medesimo articolo prevede un elenco, da intendersi tassativo, di clausole tradizionalmente definite “vessatorie” (o onerose) in quanto stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, una posizione contrattuale privilegiata: tali clausole (condizioni, nel testo della norma) non hanno effetto in mancanza di una loro specifica approvazione scritta.
L’art. 1342 del Codice Civile, al primo comma, ha natura di norma di interpretazione, da coordinarsi con quella contenuta nell’art. 1370 del Codice civile: entrambe confermano la maggior tutela che l’ordinamento presta a favore del contraente, considerato “più debole” nei confronti del predisponente le condizioni contrattuali, che si presume essere dotato di organizzazione e di mezzi tecnici tali da assumere una posizione dominante all’interno degli equilibri contrattuali.
Non vi è dubbio che la normativa appena menzionata si pone in diretta relazione con le norme entrate in vigore a seguito del recepimento della direttiva Comunitaria: non solo hanno un “humus” comune ma si ritrova nelle stesse un lessico simile, se non identico.
In verità, l’unico comune denominatore è la sanzione che il Legislatore ha previsto.
Piuttosto, bisogna affermare che il piano di intervento dell’art. 1341 del Codice Civile non incide principalmente con il problema del controllo sul contenuto delle clausole contrattuali, investendo il distinto (e più limitato problema) del modo di inserimento delle singole clausole nel contratto.
E quindi, limitandoci all’esame delle clausole cd. “vessatorie”, l’eventuale specifica sottoscrizione richiesta dall’art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, non sarà sufficiente ad escluderne l’inefficacia quando, alla luce delle norme introdotte dalla Novella, il loro contenuto sia da considerarsi abusivo.
Si ritiene quindi che nei contratti con i consumatori, strutturati come contratti “standard”, le clausole in esame, per risultare efficaci dovranno sia non avere contenuto vessatorio, ai sensi degli artt.1469 bis e 1469 ter del Codice Civile, sia essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell’art.1341, secondo comma, del Codice Civile: entrambi i requisiti debbono essere richiesti, in considerazione dei diversi livelli di intervento che le norme menzionate hanno nella contrattazione tra professionista e consumatore.
Secondo la dottrina che per prima ha affrontato l’argomento, si può invece ritenere che il controllo sul contenuto, come stabilito dalla novella, sostituisca ed assorba il requisito formale della doppia sottoscrizione.
Considerata la complessità e le continue innovazioni in relazione alla materia trattata, lo studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento o chiarimento che si dovesse rendere necessario.
Milano , Marzo 1996
Studio Legale GGM